«Il luogo da dove venite non c’è più, quello dove credevate di essere diretti non è mai esistito, e il luogo in cui vi trovate ora non ha senso, a meno che non riusciate a scappare via subito. La coscienza è solo un trucchetto: non esiste. E se invece credete di averla è meglio che la tiriate fuori, dovunque ce l’abbiate nascosta, le diate la caccia e la uccidiate». Nelle parole di Hazel Motes, il sinistro protagonista de la Saggezza nel sangue che vagava per il sud degli Stati Uniti imbattendosi in personaggi via via sempre più inquietanti, quando non talmente fragili da essere alla mercé di chiunque, si può scorgere uno scenario non poi così lontano da quello che fa da sfondo a Bad Boy (pp. 298, euro 15, traduzione di Federica Angelini) il romanzo con cui Jim Thompson raccontò la prima parte della propria vita e che torna in libreria grazie ad HarperCollins che sta ripubblicando tutte le opere dello scrittore, tra i padri nobili dell’odierna narrativa poliziesca e del noir.
FLANNERY O’CONNOR, cattolica della Georgia, scrisse quel libro tormentato – appena tornato per i tipi di minimum fax nella traduzione di Gaja Cenciarelli – nel 1952 facendo i conti con i fantasmi dell’America della Bible Belt dove la fede si stava trasformando in uno show delle redenzione a buon mercato, tra vecchi superstizioni e nuovo business. Jim Thompson, che era nato all’inizio del Novecento nel centro dell’Oklahoma, in una località, Anadarko, che fin dal nome pagava un debito alle tribù native espropriate delle loro terre, scelse di raccontare in quel libro, pubblicato nel 1953, una vita trascorsa tra continui spostamenti, prima al seguito delle peregrinazioni famigliari quindi inseguendo la propria autonomia, tra lo Stato natio, compreso nel Midwest ma legato alla cultura «sudista», le campagne del Nebraska e il Texas. Con lo stile schietto, sottilmente ironico e dissacrante tanto da sembrare a volta intriso di cinismo che avrebbe caratterizzato anche i suoi romanzi più celebri, lo scrittore finirà così per delineare i contorni dell’America dei primi decenni dello scorso secolo che in quell’area del Paese stava legando il proprio sviluppo e l’accesso ad una modernità almeno di facciata, all’altalenante e incerto boom dell’industria del petrolio.

COME ACCADE SPESSO nelle storie più celebri di Thompson, sospese tra l’hard boiled e il noir, le esistenze dei più deboli sono alla mercé di una violenza oscura, indecifrabile quanto alle proprie origini ultime, spesso custodite nei recessi più nascosti dell’animo umano, ma che si manifesta nei territori di frontiera della psiche allo stesso modo che in quelli relativi allo sviluppo della società: come accade nel suo capolavoro, L’assassino che è in me (HarperCollins), dove le gesta sanguinarie dello sceriffo Lou Ford hanno luogo in una cittadina del Texas sconvolta dal boom del petrolio che ridisegna in modo selvaggio le regole del potere e della convivenza civile. Così, in Bad Boy Jim Thompson applica alle proprie vicende, e a quelle della sua famiglia un metodo d’indagine analogo, trasformando pagina dopo pagina le guasconate dell’infanzia e le avventure dal gusto picaresco che gli sono accadute nei prodromi di quel progressivo incedere verso l’orrore che sarebbe stato in grado di evocare in seguito.
L’autore pulp che conobbe una breve stagione di successo solo alla fine degli anni Cinquanta, testimoniata dalla collaborazione, economicamente importante ma ad altissima tensione emotiva, con il regista Stanley Kubrick per Rapina a mano armata, 1956, e Orizzonti di gloria, 1957, dopo quindici anni di libri pubblicati quasi esclusivamente in edizione tascabile, risaliva ad un repertorio in qualche modo domestico per rintracciare l’origine della sua osservazione dell’orizzonte perverso del male. Non a caso, proprio il profilo del personaggio di Lou Ford affonda nei ricordi di uno sceriffo che minacciò l’autore di «farlo sparire» se non avesse pagato una multa: «Non sapevo se mi avrebbe ucciso, perché non lo sapeva nemmeno lui. Alla fine, quando maturai, riuscii a ricrearlo sulla carta. Ma ci misi molto tempo per farlo, quasi trent’anni. E ancora non me lo sono tolto dalla testa».
JOE R. LANSDALE, l’autore texano nelle cui opere riecheggiano lo stile e le atmosfere di Thompson, ha spiegato più volte come quest’ultimo «scriveva di un mondo-pattumiera con una prosa fatta di ruggine, terriccio e un diamante ogni tanto». Pur riuscendo a ridere delle disgrazie proprie come altrui, l’autore di Bad Boy non girava certo la faccia da un’altra parte di fronte al malessere che si andava definendo intorno alla sua persona. Mentre le certezze della famiglia venivano messe ciclicamente a dura prova dal padre di Jim, quasi un interprete suo malgrado del lato in ombra e decisamente più sconnesso del sogno americano che fu di volta in volta sceriffo della contea di Caddo in Oklahoma, imprenditore dell’industria petrolifera, avvocato e contabile, rappresentante di generi vari e molto altro ancora, il futuro scrittore accumulava ricordi, e appunti, per tracciare l’inquieto ritratto dell’America che si avviava verso la Grande Depressione.
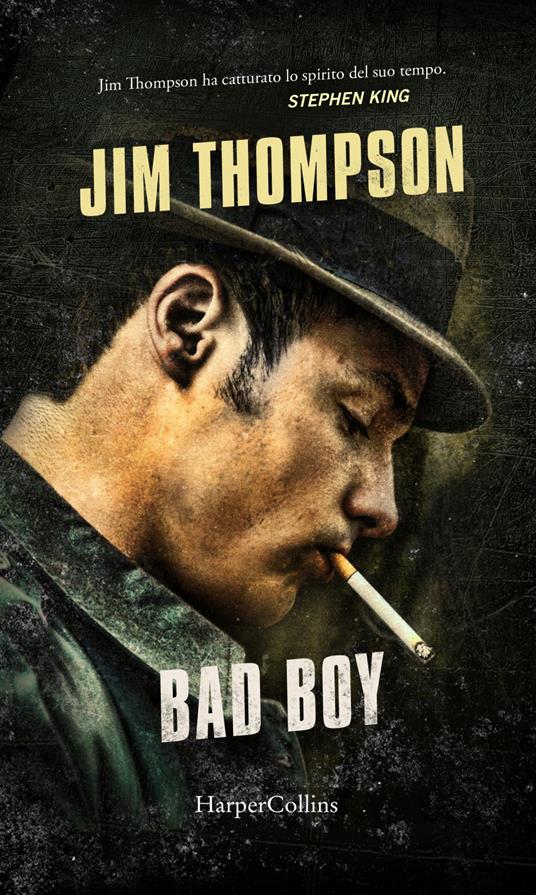
Dopo l’Oklahoma e il Nebraska della casa dei nonni, mentre Jim cominciava ad affacciarsi all’adolescenza, la famiglia si trasferì a Fort Worth in Texas, in quella che sarebbe diventata, all’epoca, una delle capitali della nuova industria petrolifera. Per il futuro scrittore iniziarono una serie di «lavoretti», divenuti sempre più pesanti e rischiosi e che lo avrebbero accompagnato, quindici anni più tardi, all’esordio come scrittore. Il primo fu quello di facchino in un albergo: «Ero entrato in un mondo strano, selvaggio e meraviglioso, era il mondo di un hotel di lusso nei ruggenti anni Venti», un mondo che «tipizzava il rude individualismo al meglio, o al peggio, un mondo la cui fisionomia urbana non rivelava nulla delle profondità in fermento e in subbuglio». I ragazzi si disputavano «il posto» a suon di cazzotti e in palio c’era soprattutto, neanche a dirlo, la possibilità di mettere le mani sulle valigie dei clienti più danarosi che sovente sparivano in modo misterioso. Non sarebbe durata però a lungo, e le occupazioni che attendevano Jim erano una più dura dell’altra.
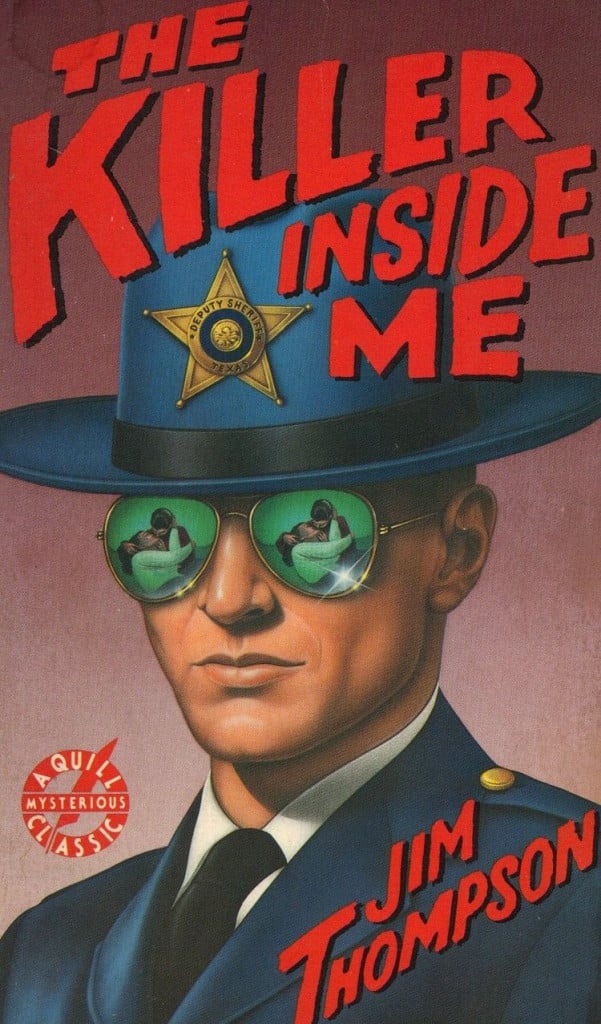
Un po’ hobo e un po’ sognatore, vittima delle follie famigliari, sempre e comunque sfruttato, Jim Thompson raccontava così una storia americana e la prima parte di una vita che sarebbe poi stata stroncata dall’alcol nel 1977 dopo aver goduto solo raramente degli esiti di un meritato successo. Probabilmente come il protagonista un altro suo celebre romanzo, In fuga, anche «la sua voce divenne un calmo sussurro, la calma intensa sulla superficie di una furiosa tempesta sotterranea».




