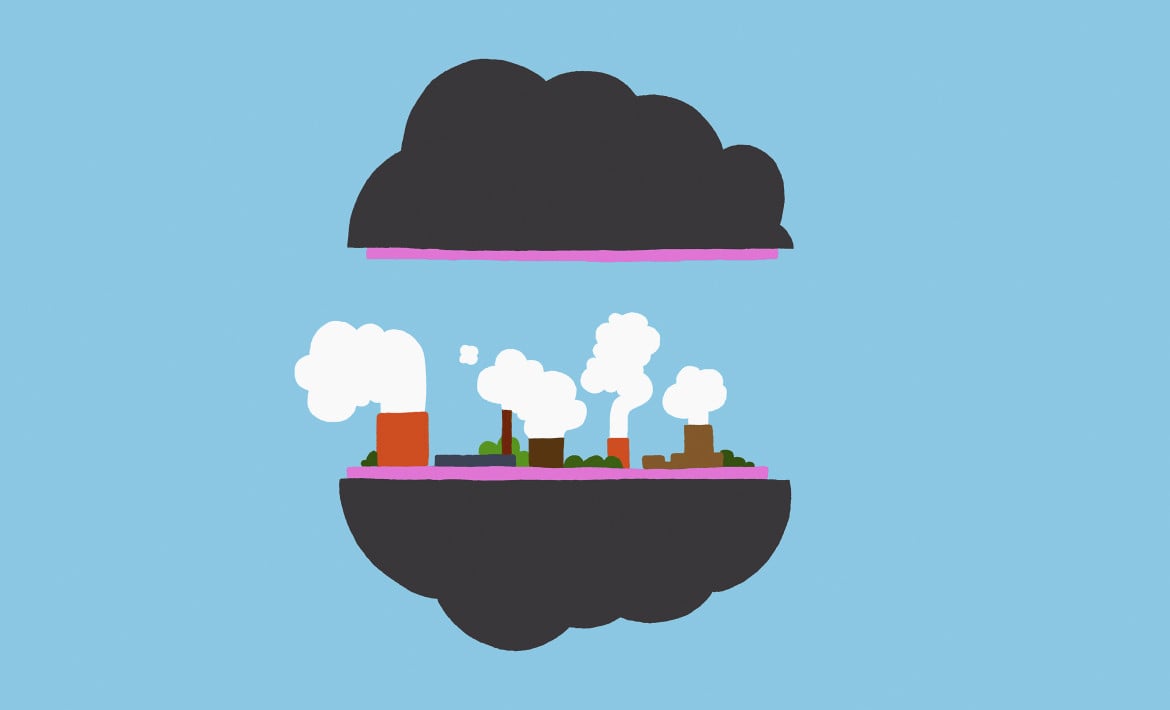Progressisti e sinistre varie discutono sul Decreto Dignità. Inversione di tendenza? Fumo negli occhi? Conferma del Jobs Act? O suo spianamento?
Mentre da una parte si discute, da un altra si attacca. Confindustria non ha il più remoto dubbio: «Segnale molto negativo per le imprese»; «rischio di riproporre vecchie contrapposizioni»» (quelle nuove, si vede, vanno benissimo); «regole punitive». Non si arriva alle punte di comicità involontaria di chi qualifica il provvedimento con un «impianto di stampo marxista», «da Pci anni ’80» (G. Meloni. Una che se ne intende.)
Le norme punitive riguarderebbero le delocalizzazioni. Bene punire gli abusi, così dice il comunicato confindustriale, ma così si rischia di scoraggiare gli investimenti. Interni ed esteri.
Dalla caduta – continua e indefessa – dei vincoli alla cicolazione dei capitali da parte degli Stati (da fine ’70- inizio ’90) uno dei principali compiti dei governi è diventato cercare di attrarre investimenti, in specie i famosi Ide (investimenti diretti esteri), cioè un flusso di capitale da parte di un investitore per acquisire il controllo di una attività produttiva.
Un po’ la storia del riccone straniero che si viene a comprare la fabbrichetta per rimetterla in carreggiata. Da allora la tabella degli Ide viene vista un po’ come una classifica calcistica, chi è in cima esulta e se ne vanta, chi è in fondo cerca altri argomenti per scantonare le domande.
Gli Ide sono cresciuti in maniera incredibile. A livello mondiali, sono passati da un valore di 10mila miliardi (1970) a 51mila miliardi (1980), a 196mila miliardi di dollari. Già un aumento considerevole. Nel decennio successivo vediamo una ascesa fino 1461mila (sic!) miliardi nel 2000; in un decennio si passa a un altro ordine di grandezza, oramai si ragiona in termini di trilioni (1 trilione=1000 mld). Il picco si raggiunge a 3 trilioni nel 2007, per un andamento calante successivo piuttosto ondeggiante.
Se confrontiamo questo dato con realtà assai più conosciute, gli Ide assomigliano di meno ad una panacea ineffabile: mentre il grafico di questi spicca un volo d’angelo continuo con un discreto inciamo alla fne, quello del Pil sembra un elettrocardiogramma. Alternanza di su e giù. Il saggio di profitto fra 1960-2008 calcolato da Alvarez-Medialte su dati della Commissione europea mostra invece un certo declino fino ai primi anni ’80, poi decolla e ascende senza tanti intoppi, tanto per gli Stati uniti che per l’Europa. Sicuramente in taluni casi gli Ide possono essere positivi, ma se non rapportati al loro effetto sul piano della redistribuzione possono essere mitizzati.
Le grandi aziende – che sono quelle che più fanno gli Ide logicamente – sono sempre più finanziarizzate, soggiacendo ad una prospettiva di corto periodo nella realizazione di profitti. Si compra la famosa fabbrichetta per smontarla magari dopo poco, se convinene a breve termine. Non pare che i confindustriali siano particolarmente preoccupati a tal proposito.
Quanto agli investimenti interni, va ricordato che il famoso protocollo interconfederale del luglio 1993 prevedeva la «moderazione» degli stipendi per consentire di fare più spesa per la ricerca e lo sviluppo. Da allora i salari sono stati sempre piuttosto stagnanti (dopo un balzo verso il basso post-93 di diversi punti); e tutt’oggi come mostrava il prof. Inguscio in audizione al Senato, la spesa sul pil privata in ricerca e sviluppo in Italia è inferiore alla media Ocse, più bassa rispetto a Francia, Canada, Germania, Corea, Usa, Gran Bretagna, Giappone e Stati uniti.
Meriterebbe farci una riflessione, perché sembra contrastante con l’immagine di folle di imprenditori che premono per investire entusiasticamente ma scoraggiati dal «comunista» Di Maio.