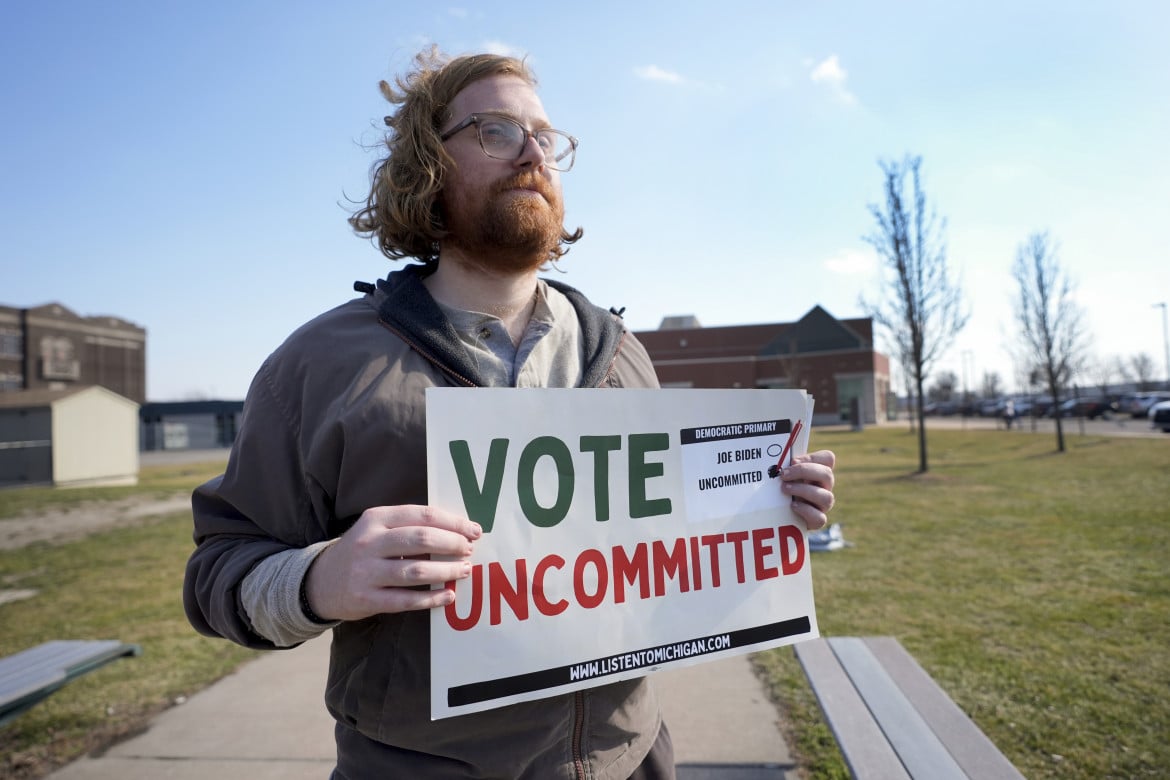Si vota in Indiana, ennesimo match point per Donald Trump e forse ultima opportunità per i suoi avversari repubblicani di rallentare la sua corsa. Tra i democratici, invece, la vittoria di Clinton è un fatto ormai acquisito. Hillary ha solo bisogno delle ultime manciate di delegati da raccogliere nell’ultimo mese di votazioni (mancano un dozzina di stati) per sancire una vittoria ormai annunciata.
La maggiore incognita per il partito riguarda la strategia di Bernie Sanders alla convention. Se la sua corrente progressista cioè riconfluirà «pacificamente» nel partito di Hillary o se userà il 40% dei consensi raccolti a sinistra per imporre modifiche sostanziali nella piattaforma della candidata.
Qualunque sia l’esito a Philadelphia è chiaro che la vera battaglia si profila a Cleveland, alla convention del Gop. A oggi Donald Trump dispone di quasi 1.000 delegati e ne rimangono da assegnare 500 circa. Se riuscirà a vincerne un po’ meno della metà diverrà automaticamente il candidato di un partito che in gran parte non lo sopporta. Mentre la base lo sta acclamando a furor di popolo, una nutrita schiera di dirigenti non si capacita di venire rappresentata da un imprevedibile outsider.
Il cosiddetto partito del «never Trump» punta quindi a negargli la maggioranza al primo turno per manovrare poi il voto della convention a favore di un alternativa. Per loro però il tempo sta per scadere. Al termine delle primarie repubblicane mancano solo 11 stati e quasi la metà dei delegati proverranno da New Jersey e California dove il miliardario newyorchese guida la classifica dei sondaggi.
L’Indiana oggi rappresenta uno degli ultimi serbatoi di conservatori «ortodossi» potenzialmente vicini a Ted Cruz. Come previsto nel patto fra Cruz e John Kasich – il moderato governatore dell’Ohio – per rallentare la corsa di Trump, l’Indiana «spetta» all’arciconservatore texano. Una vittoria di Cruz toglierebbe delegati preziosi a Trump e potrebbe forse incrinare la «narrazione» del suo inevitabile trionfo.
L’incapacità di esprimere un candidato di consenso è indice di una crisi profonda nel partito della destra americana, ormai diviso in fazioni di cultura ed interessi contrastanti. La coalizione fra destra religiosa e ala liberista è stata incrinata dal populismo di cui Trump è la personificazione.
Nelle prossime settimane avverrà lo scontro finale fra gli schieramenti. L’ultimo stato a votare è il più popoloso del paese. Le primarie in California si terranno il 7 giugno ma la campagna sta già fornendo un assaggio delle passioni che caratterizzeranno la battaglia presidenziale.
La scorsa settimana il primo grande comizio di Trump a Orange County, la roccaforte repubblicana a sud di Los Angeles, è finita in tafferugli fra sostenitori e contestatori. Due giorni dopo, a San Francisco, Trump ha avuto bisogno di una forte scorta per accedere al congresso del partito repubblicano californiano da una porta posteriore mentre manifestanti bloccavano l’entrata principale e si scontravano con la polizia.
I sondaggi indicano che fra gli elettori repubblicani Trump gode di un ampio vantaggio ma la California è a stragrande maggioranza democratica. Si tratta dello stato più multietnico (la popolazione bianca è poco più del 40%) e il più ispanico (38% di origine latinoamericana e soprattutto messicana). Non sorprende quindi che la retorica xenofoba di Trump abbia infiammato qui le passioni di un movimento sindacale e pro-immigrati con profonde radici. Le reazioni alla sua prima visita sono state un presagio di quello che potrà avvenire se avrà modo di porre la divisione e l’esclusione al centro della campagna nazionale.
Finora l’ascesa di Trump è stata una questione interna al partito repubblicano, sullo sfondo degli hinterland conservatori del paese. Molto più difficile sarà evitare il confronto diretto nel melting pot californiano.