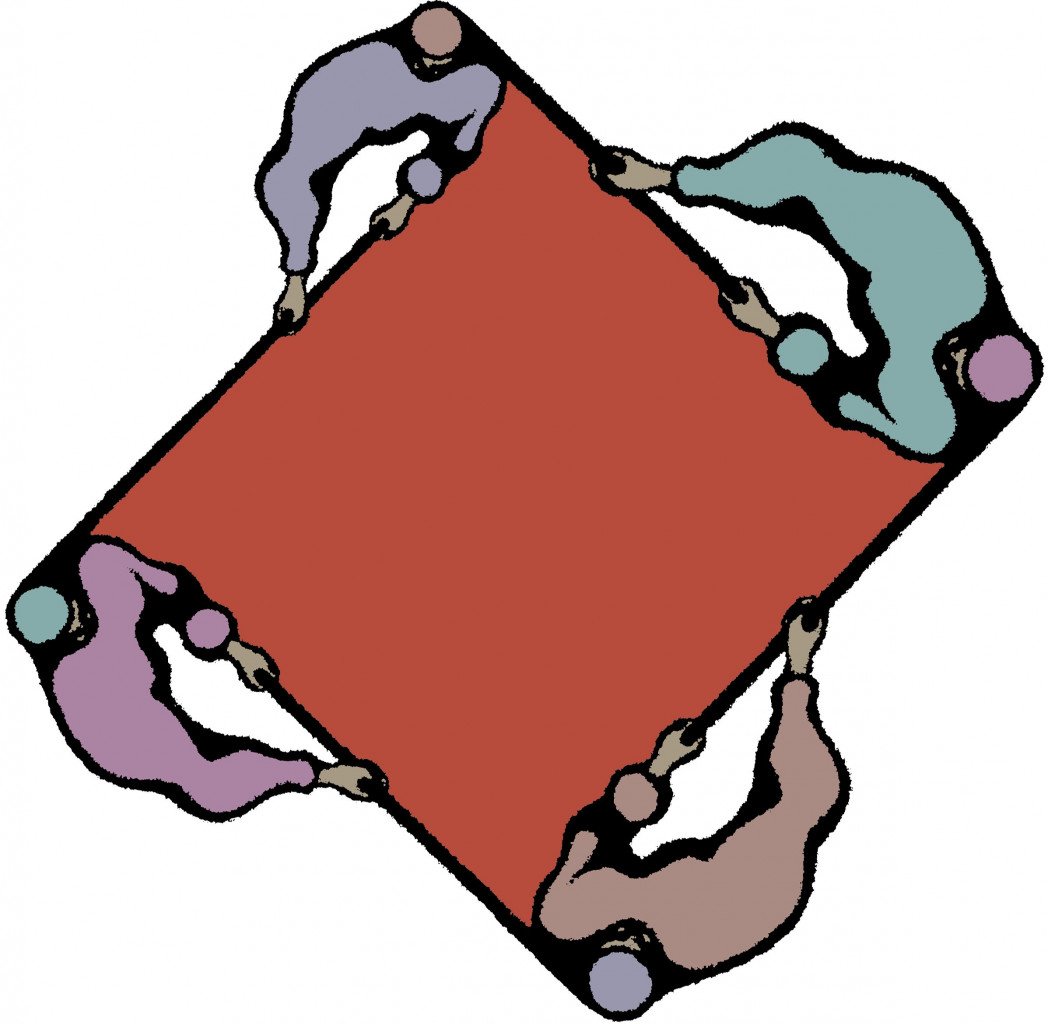Lo slancio progettuale e la curvatura ideale che Enrico Letta, se ne verrà eletto segretario, dovrà imprimere al Pd bisognoso, di rinascita in termini sia di identità sia di strategie, sono esemplificati da due questioni cruciali: il rilancio della “piena e buona occupazione”, il ruolo dello Stato adeguato a questo scopo. Da queste due questioni si misurerà anche la portata del profilo riformista del governo Draghi, di cui del resto, nella maturazione degli ultimi anni, egli stesso ci ha fornito elementi per interpretazioni non univoche, pertanto da non dare per scontato ma da sottoporre a ricostruzione e a vaglio.
L’obbiettivo della “piena e buona occupazione”- colpevolmente dismesso da decenni anche da governi di centrosinistra subalterni al blairismo e al neoliberismo temperato – va rivolto in primo luogo a giovani e a donne, i soggetti da troppo tempo trascurati e i più colpiti da una devastazione pandemica le cui distruttive conseguenze, se non invertite, rischiano di radicarsi strutturalmente. Pertanto esso oggi richiede l’assunzione di una “progettualità” grandiosa, sulle tracce autentiche del New Deal di Roosevelt, il cui ritratto non a caso ora campeggia nell’ufficio alla Casa Bianca alle spalle di Biden.
Tale progettualità, centrata sul lavoro, va finalizzata all’ideazione di un “nuovo modello di sviluppo” – più orientato alla domanda interna, ai bisogni sociali insoddisfatti, ai beni pubblici e ai consumi collettivi, al cui soddisfacimento debbono essere indirizzati lo sviluppo tecnologico e l’innovazione – e pertanto non può ricorrere solo a misure incentivanti volte a stimolare indirettamente la generazione di lavoro (incentivi fiscali, decontribuzioni, bonus, trasferimenti monetari e altro), ma richiede strategie di “creazione diretta” di lavoro, mediante un insieme articolato di progetti, promosso e veicolato dall’operatore pubblico che è l’unico che lo può fare, purché articolato in una architettura istituzionale plurale, aperto alla creatività, all’inventiva, allo “sperimentalismo istituzionale”, proprio come fece Roosovelt con il New Deal.
E qui vengo alla questione del ruolo dello Stato nei tempi odierni. Compiti così immani, ma anche così affascinanti, possono essere svolti da uno Stato che si dia come principio ispiratore prevalente quello della competitività? Eppure, questo è il principio ispiratore dominate negli approcci tradizionali alla questione del ruolo dello Stato, riproposti anche di recente per esempio da Giavazzi, Tabellini, Cottarelli.
In realtà, oggi appaiono inadeguati non solo gli approcci neoliberisti smaccatamente ostili allo Stato, ma anche quelli main stream coincidenti con l’idea che lo Stato debba limitarsi a fornire al mondo produttivo attività regolatoria e incentivi indiretti o con la convinzione secondo cui di politica pubblica (come quella industriale) si può parlare unicamente in termini di regole della concorrenza (antitrust, privatizzazioni, difesa dei diritti proprietari ecc.) o di finanziamento della ricerca di base e degli investimenti infrastrutturali.
Uno dei difetti maggiori di tali approcci è che da una parte immaginano interventi pubblici “circoscritti” e “occasionali” (come circoscritti e occasionali sarebbero i fallimenti del mercato mentre essi nella realtà sono “pervasivi” e “strutturali”), dall’altra parte ignorano un elemento fondamentale della storia delle innovazioni: in molti casi decisivi il governo non ha soltanto dato “spintarelle” o fornito “regolazione”, ha funzionato come “motore primo” delle innovazioni più radicali e della creazione di lavoro.
Come è avvenuto nei precedenti grandi cicli tecnologici, oggi per le tecnologie verdi, farmacologiche e sociali per l’avvio di un “nuovo modello di sviluppo” l’intervento dello Stato deve essere non solo “facilitatore” e alimentatore di condizioni permissive, ma creatore diretto, motore e traino dello sviluppo. Questo è, del resto, l’impianto che sorregge il Next Generation Eu, che non a caso ha il suo baricentro negli investimenti pubblici.
Al contrario, gli approcci tradizionali si fondano sull’idea che, quando si tratti di mercati perfettamente concorrenziali, questi bastino a se stessi. Invece ci sono molte situazioni in cui semplicemente i mercati non possono soccorrerci. E ciò è ancora più vero quando – come nei tempi presenti segnati dalla tragedia del coronavirus e dalla persistenza di populismi anti-sistema – la strutturalità della crisi fa avanzare l’esigenza di un’analoga strutturalità nel ridisegno della composizione della produzione e del modello di sviluppo, quando cioè le economie vanno rimodellate dalle fondamenta: il mercato non può domandare prodotti che nessuno sa se siano possibili e, d’altro canto, non si può assistere inerti al manifestarsi delle implicazioni del sovvertimento del mondo in atto. Tanto più che molte di queste implicazioni hanno uno straordinario potenziale positivo che spetta a una politica rinnovata e nobilitata far maturare e cogliere.