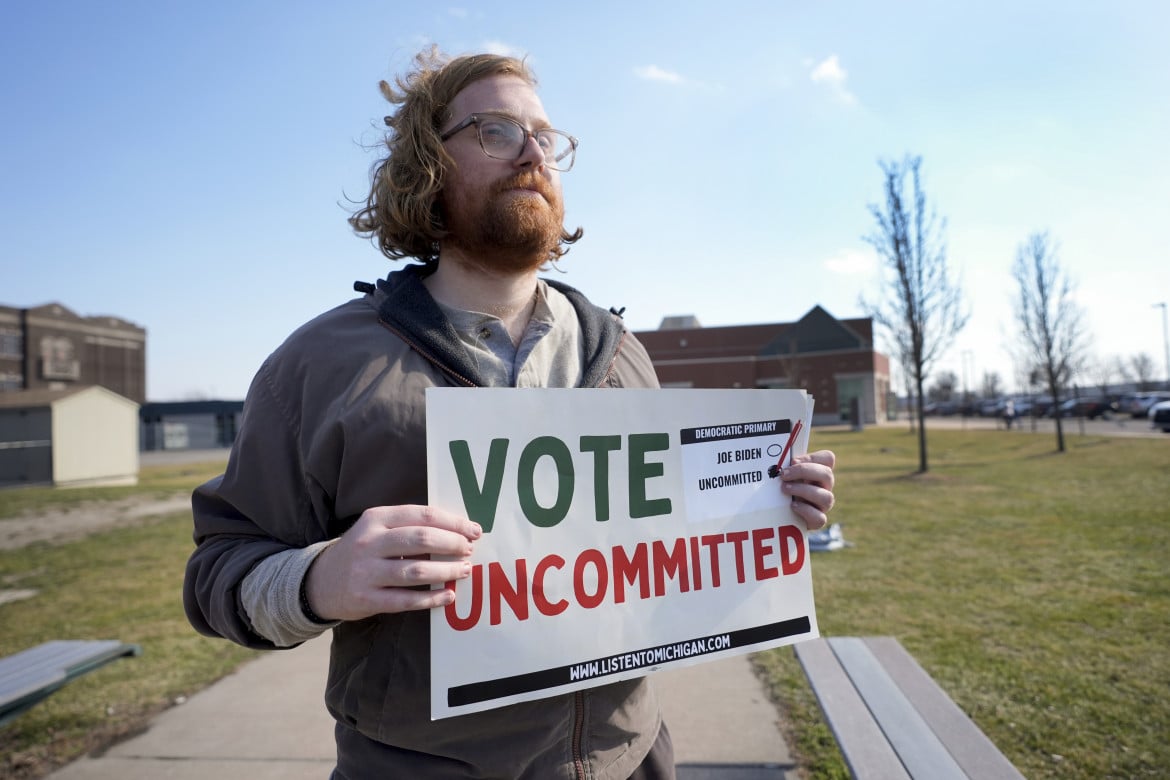Hillary Clinton e Donald Trump, vincitori del Supertuesday, hanno fatto un lungo passo verso le nomination dei rispettivi partiti nelle primarie Usa e verso elezioni sempre più imprevedibili.
L’esito del Super martedì ha rispecchiato in gran parte i pronostici della vigilia. Hillary Clinton ha vinto 8 stati concedendo a Bernie Sanders l’Oklahoma, il Minnesota, Colorado e il Vermont (nel suo stato Sanders ha vinto con percentuale bulgara del 91%). Il candidato «socialista» è anche andato vicino alla sorpresa in Massachusetts dove Hillary si è imposta di misura (50%-48%).
In generale un risultato tutto sommato dignitoso ma che all’atto pratico non modifica una posizione perdente nella conta dei delegati che è in tutta probabilità destinata a diventare presto insormontabile.
Per Sanders sono ora cruciali le prossime due settimane in cui voteranno un altra ventina di stati compresa la Florida e alcuni stati popolosi del Midwest quali l’Illinois, l’Ohio e il Michigan. Se la vittoria della Clinton è stata decisiva, quella di Trump è stata nuovamente soverchiante. Il miliardario ha conquistato 8 stati su undici allungando il suo vantaggio sui concorrenti e le mani sulla nomination di un partito ancora a forte disagio con la sua irresistibile ascesa.
Trump non ha esitato ad assumere il ruolo di «nominato» in pectore trasformando il suo discorso di vittoria in una conferenza stampa di grande effetto, come fosse il Presidente. Su un palco decorato con un tripudio di stelle e strisce, Trump è stato introdotto da Chris Christie, l’ex concorrente trasformato in sostenitore (con probabili mire vicepresidenziali). Nel salone della sua tenuta «imperiale», la villa deco Mar-A-Lago di Palm Beach, trasformata in resort di lusso, Trump si è rivolto alla folla di giornalisti con toni insolitamente pacati e «“ragionevoli» – possibile anteprima di una strategia della moderazione in vista della campagna nazionale contro Hillary Clinton. Trump ha deriso la probabile avversaria come figura politica di lungo corso «al potere da sempre» e quindi incapace di attuare riforme, una tattica non senza buone possibilità di risultare efficace a novembre nell’attuale clima populista.
Prima di allora però Trump dovrà riuscire ad unificare un partito profondamente diviso e riconciliarsi con i quadri repubblicani, molti dei quali trovano ancora improponibile la prospettiva di una sua candidatura. I vertici Gop del Congress, Paul Ryan e Mitch McConnell hanno espresso pubblicamente – la scorsa settimana – il proprio dissapore per la candidatura del populista «ribelle» e sono molti gli aderenti al partito dei «never Trump» che proclamano attualmente di preferire l’astensione, al voto per lui. All’indomani dell’ennesima batosta rimediata intanto i concorrenti non danno segno per ora di pensare al ritiro.
Ted Cruz ha vinto nel «suo» Texas e nel vicino Oklahoma. Marco Rubio ha ottenuto il suo primo risultato positivo in Minnesota. Messi assieme con John Kasich i tre contano ad oggi a malapena sullo stesso numero di delegati di Trump, ma in mancanza di un avversario «unificato» emerge l’ipotesi della resistenza ad oltranza in cui Cruz Rubio e Kasich, pur senza speranze di prevalere, rimarrebbero in lizza sino alla fine con l’unico scopo di sottrarre voti a Trump ed impedire (forse) che possa ottenere i 1.237 delegati necessari ad una candidatura ufficiale.
La pratica sarebbe poi risolta a luglio con un accordo a tavolino in fase di convention. Una strategia a dir poco spericolata che rischierebbe oltretutto di esacerbare le spaccature interne.
La realtà come ha avuto piacere di sottolineare lo stesso Trump è che «sto prendendo milioni di voti» e che il partito «se ne deve fare una ragione». Ai dirigenti repubblicani Trump ha rivolto minacce («se non ci accordiamo pagherete un caro prezzo») alternate a toni conciliatori («sto ampliando la base del partito…sono un unificatore, credetemi. Appena finite le primarie mi scaglierò contro Hillary»).
Contro le sue affermazioni confortate comunque da una aritmetica sempre più inconfutabile, Cruz e Rubio hanno potuto contrapporre solo generici anatemi: «è un liberal, non un vero conservatore» ha detto (risibilmente) Cruz. «Non possiamo consegnare a un impostore il partito di Reagan e di Lincoln» ha implorato Rubio.
Ma impostore o meno la dinamica di queste elezioni eretiche intanto rimane sostanzialmente invariata: Hillary, spostata a sinistra, almeno nominalmente dalla coriacea sfida di Bernie Sanders, osserva compiaciuta l’anarchia in campo avversario.
Ma per quanto affascinante, l’autodistruzione del partito repubblicano sconquassato dal «trumpismo» non garantisce necessariamente una vittoria democratica. Tanto più di una candidata «di sistema» nell’anno della rivolta populista.