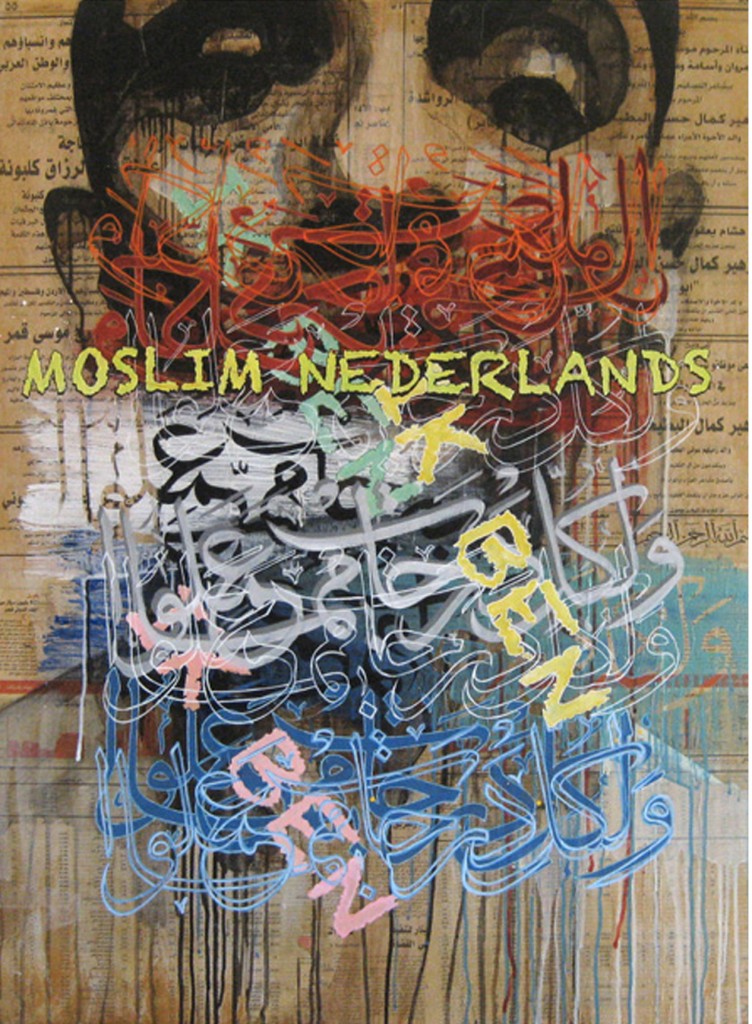Due anni fa, l’annuncio della nascita del Califfato in Siria e Iraq ha rivelato al mondo la forza militare dello Stato islamico.
In tanti si sono ritrovati a chiedersi da dove venisse Abu Bakr al-Baghdadi, l’evanescente leader del movimento, l’uomo che dal pulpito della moschea al-Nuri di Mosul nel luglio del 2014 si era auto-proclamato Califfo.
«È uscito dal nulla, come la sua organizzazione», hanno sostenuto in tanti, deducendone oscuri complotti orditi da grandi potenze e servizi segreti. Una spiegazione troppo semplice, e tutto sommato rassicurante: se i «cattivi barbuti» sono sempre e solo il prodotto delle grandi potenze, lo strumento attraverso il quale vengono coltivati ambizioni egemoniche e interessi geopolitici, vuol dire che i «cattivi» non hanno identità, forza e obiettivi propri.
Che sono simulacri, scatole di cartone riempite di generosi finanziamenti e armi contrabbandate. Fragili pupazzi nelle mani dei grandi burattinai. Ma la storia dei gruppi jihadisti è più articolata di quanto ci piace pensare.
Si fonda su dinamiche sociali e ideologie consolidate – interne alla galassia dei movimenti islamisti radicali -, su contrapposizioni strategiche e tattiche, su differenze dottrinarie, orientamenti politici e codici culturali specifici.
Negare questa storia significa ridurre a semplice prodotto militare, eterodiretto, ciò che invece è un processo sociale vero e proprio. Dotato di autonomia e di continuità storico-ideologica.
Lo dimostra proprio l’annuncio del Califfato, nel 2014. Quell’annuncio rivelava non tanto l’imprevista affermazione militare di un gruppo sconosciuto ai più, quanto una storia pluridecennale, perlopiù sotterranea, infine venuta a galla.
Il Califfato è lo strumento per vendicare le umiliazioni subite e restaurare la gloria perduta, annientando l’architettura politico-istituzionale imposta dall’Occidente alla comunità islamica, ha sostenuto al-Baghdadi, che con le sue parole ha rievocato, e cambiato di segno, un dibattito che ha attraversato tutto l’islamismo politico del Novecento.
Un dibattito che il Califfo ha voluto concludere a modo suo. Non prima di aver compiuto un vero e proprio parricidio. La restaurazione del Califfato da parte di Abu Bakr al-Baghdadi realizza un sogno coltivato a lungo.
Nel 1924 Kemal Ataturk, il sovrano modernizzatore della Turchia, abolisce l’istituzione islamica. Le resistenze sono deboli, ma diffuse. Molti islamisti, dal Nord Africa al Sud-est asiatico, continuano a sperare di recuperare la grandeur perduta, ricorda Jason Burke nel suo ultimo libro, The New Threat From Islamic Militancy.
Il dibattito sugli strumenti migliori per ristabilire uno Stato islamico va avanti per decenni. Attraversa tutti i testi più importanti dell’islamismo politico, incluso quello radicale. Negli anni Novanta diventa un obiettivo per Osama bin Laden. Per il fondatore di al-Qaeda e per il suo sodale, l’egiziano Ayman al-Zawahiri, il Califfato è il fine ultimo del jihad.
Un’ambizione che li accomuna ad al-Zarqawi, lo spietato combattente giordano, futuro leader di al-Qaeda in Iraq, che ne parla con lo stratega militare di al-Qaeda, Sayf al-Adel, già tra la fine del 2001 e l’inizio del 2002, quando entrambi si trasferiscono in Iran, subito dopo la caduta dei Talebani in Afghanistan.
Nel 2005 è lo stesso al-Zawahiri a includere esplicitamente l’instaurazione di uno Stato islamico nella sua strategia per al-Qaeda in Iraq, spiegata al giordano in una lettera privata.
I rapporti con la leadership di al-Qaeda si fanno però sempre più tesi. Il brutale settarismo confessionale di al-Zarqawi non piace ai leader qaedisti, che provano a farlo ragionare. Senza successo.
Osama bin Laden, pragmatico, ritiene inoltre che le condizioni sul terreno non siano favorevoli alla restaurazione del Califfato. Più passa il tempo e più ne è convinto, come dimostrano i documenti ritrovati nel covo pachistano di Abbottabad. Se non si sconfigge prima il grande nemico – gli Stati uniti – ogni tentativo di istituire uno Stato islamico è destinato alla sconfitta, pensa Bin Laden. Il suo sogno califfale, rimandato a tempi migliori, sarebbe stato realizzato da Abu Bakr al-Baghdadi, attraverso un parricidio.
Pur innestandosi su rivalità ben più datate, il parricidio si consuma tra il 20013 e l’inizio del 2014, a proposito delle attività in Siria dello Stato islamico in Iraq e nel Levante, il gruppo guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, il quale vuole intestarsi il jihad in Siria e sottomettere ufficialmente il fronte al-Nusra. Al-Zawahiri, diventato il numero uno di al-Qaeda, intima ad al-Baghdadi di limitarsi a operare in Iraq. Prova a mediare. Ma il futuro Califfo, giovane e impaziente, pugnala alle spalle il vecchio egiziano, la massima autorità nel panorama jihadista globale, sconfessandolo pubblicamente: non ha alcuna intenzione di rinunciare all’espansione in Siria.
Dopo qualche mese, al-Zawahiri prende atto che uno dei figli cresciuti all’ombra dell’ideologia esportata in tutto il mondo con il marchio qaedista ha ormai preso la sua strada: è la fine di un rapporto burrascoso, segnato da conflittualità e divergenze. La vecchia guardia è sopraffatta dall’impazienza della nuova leva. Lo Stato islamico e al-Qaeda diventano antagonisti.
Da allora, lottano e competono per assicurarsi l’egemonia della galassia jihadista. La rottura si consuma su questioni ideologiche e strategiche – i tempi del Califfato, i metodi per ottenerlo, i nemici da combattere, gli strumenti per farlo – ma ha implicazioni prosaiche: più si afferma uno dei due marchi, maggiore diventa la capacità di reclutamento e di attrarre investimenti. Questioni di marketing. Questioni di prodotti da vendere. E di simboli da esibire.
L’Afghanistan è uno dei più importanti. Sul mercato dei barbuti ha un valore inestimabile. Culla del jihad contemporaneo, è stato il campo di addestramento, proselitismo e reclutamento dei maggiori ideologi del jihadismo-salafita.
Il Califfo punta a penetrarvi. All’inizio del 2015 è stata annunciata la nascita della provincia dello Stato islamico nel Khorasan, un’area che storicamente include il territorio dell’attuale Afghanistan, le zone orientali dell’Iran, oltre a porzioni significative di Uzbekistan, Turkmenistan e Tajikistan, ma che per lo Stato islamico si estende fino al subcontinente indiano.
La partita cruciale si gioca però in Afghanistan e Pakistan, i due paesi su cui punta Hafiz Saeed Khan, l’uomo a cui il Califfo ha affidato la consueta politica espansionistica: reclutare con denaro contante, sfruttando il malcontento dei combattenti disillusi.
Per ora i risultati sono scarsi. Qualche cambio di casacca e un discreto attivismo militare nelle province afghane al confine con il Pakistan, lì dove è più diffuso l’Islam salafita, alieno ai Talebani, di scuola deobandi.
Ma in Afghanistan il Califfo è destinato alla sconfitta: i Talebani afghani, che con al-Qaeda hanno stabilito un’alleanza tattica mal sopportata, vedono come fumo negli occhi Hafiz Saeed Khan, il Califfo e la loro pretesa egemonica sul jihad in Afghanistan.
Che è e deve rimanere una partita locale, interna ai confini nazionali, dicono i seguaci del nuovo leader talebano, Abaitullah Akhundzada.
È stato eletto pochi giorni fa. E si aspetta a breve l’endorsement del leader di al-Qaeda, al-Zawahiri, per far fronte comune contro il Califfo al-Baghdadi. Un giovanotto troppo impaziente, pensano entrambi.