Se il mito americano va da est a ovest, la direttrice da nord a sud rappresenta un immaginario altrettanto potente: mille miglia cucite da una sola strada portano da Chicago a New Orleans. La Route 61, oggi nota come Blues Highway, segue il corso del Mississippi: all’ingresso dello stato che prende il nome dal fiume si legge «Birthplace of America’s Music». Lungo il percorso spuntano come funghi musei dedicati al blues e si moltiplicano memoir di viaggio, guide turistiche, pacchetti organizzati che vendono un on the road alla scoperta delle radici della musica nera, del rock’n’roll e del country, in un’America che si promuove come un lungo drive-in stradale, dove magari si finisce a bere nel Ground Zero Blues Club, il locale di Morgan Freeman a Clarksdale. Lasciamoci alle spalle la mitologia della Highway 61 da Robert Johnson a Bob Dylan. Se la strada che separa Chicago da New Orleans è un catalogo a tappe, i poli del nord industriale e del sud pastorale rappresentano ancora gli estremi di un mondo non riconciliato. Due recenti uscite della casa editrice Mattioli 1885 permettono di accostare questi immaginari accompagnati da scrittori autoctoni. Sia il polacco-americano di seconda generazione Stuart Dybek che l’afroamericano Ernest J. Gaines sono «hyphenated americans», americani con il trattino appartenenti a minoranze connotate. «Impuri» secondo la vecchia tripartizione wasp (bianco-anglosassone-protestante), marchiati con la lettera scarlatta del trattino separatore: è capitato per gli italoamericani, gli ebrei americani, i nippoamericani e via elencando.

MELTING POT
Entrambi raccontano storie condizionate dalla componente etnica, dove non è possibile ignorare che il melting pot è vero non tanto per gli aspetti propagandistici (l’amalgama di gruppi, religioni, culture diverse nella superiore utopia della terra promessa), ma perché in questo recipiente gli ingredienti non si fondono spontaneamente: vengono tenuti sotto pressione da polizia e vincoli sociali e sgretolati con la forza, come fossero sottoposti all’azione di mortaio e pestello. Dybek in La costa di Chicago racconta l’adolescenza di un gruppo di ragazzi (polacchi e non, tutti appartenenti a minoranze ghettizzate) dei quartieri di immigrati che finiscono per ciondolare negli stessi bar, nelle stesse periferie. Gaines ambienta il romanzo breve La tragedia di Brady Sims nella fittizia cittadina di Bayonne, situata nell’entroterra della Louisiana, dove le ville delle vecchie piantagioni e le abitazioni signorili della metà bianca della popolazione si contrappongono alle catapecchie della metà nera. Uno scrittore è nato in un quartiere malfamato di Chicago, l’altro in una piantagione della Louisiana, ma entrambi hanno trovato nel secondo dopoguerra la via dei corsi di «creative writing» e successivamente hanno continuato a gravitare nell’accademia insegnando nelle università locali, scegliendo di chiudersi nei loro mondi: geograficamente circoscritti, poeticamente sconfinati.
I ragazzi protagonisti dei racconti di Dybek si muovono tra palazzoni fatiscenti, scantinati lugubri e vie pericolose. Per Dybek sono quartieri di Chicago meno estremi di Cabrini-Green, l’esperimento di edilizia sociale diventato un inferno di criminalità e abbruttimento, raso al suolo nel 2011. «L’accelerazione del tempo rende irriconoscibili i paesaggi», scrive Marco d’Eramo nel suo saggio su Chicago, Il maiale e il grattacielo, raccontando una città corrosa da un capitalismo che costruisce e demolisce senza requie. Qui è nata la prima scuola di sociologia urbana d’America e il circolo di economisti noto come Chicago Boys ha imposto al mondo l’ultraliberismo. Non è casuale che il miglior cantore americano contemporaneo di paesaggi urbani scomparsi sia Dybek e che i suoi bozzetti siano ambientati a Chicago. Siamo negli anni Cinquanta: i miti di questi giovani di periferia sono Bo Diddley e Little Richard, i ragazzi cantano a squarciagola I Put a Spell on You di Screamin’ Jay Hawkins sotto un viadotto dove l’eco amplifica il loro sgraziato blues. «In quegli anni tra la Corea e il Vietnam, quando si è perfezionato il rock’n’roll, il nostro quartiere era stato proclamato ufficialmente Area Degradata», racconta Dybek. In questo ambiente dove sbandati ribelli italoamericani, ispanoamericani o dell’est europeo corrono in macchina senza meta, suonano negli scantinati o cercano il riscatto nello sport, uno di loro, il letterato del quartiere, inizia Degrado, il suo «Grande Romanzo Americano» con questo incipit: «Sorge l’alba come dei vecchi malati che giocano sui tetti in mutande». Qualcun altro sogna di sfondare come Elvis Presley e incide il proprio 45 giri per sentirlo nei bar di quartiere, tra Frank Sinatra e Ray Charles, in quei jukebox: «Che avevano sparato i Platters e Buddy Holly (…) pieni di polke e di canzoni messicane che stranamente sembravano polke». I ragazzi formano band sgangherate, la musica annoda l’America marginale bianca a quella nera. Qualche ragazzo perso tra Kerouac e il blues passa: «Un sacco di tempo ad ascoltare i vecchi 78 giri di cantanti neri i cui nomi sembravano cominciare tutti per Blind o Sonny». Salvezza e perdizione convivono. Le mura sottili dei palazzoni portano le note dall’appartamento dove una studentessa di origine polacca si esercita a suonare Chopin; anche se presto verrà ripudiata dalla famiglia per aver messo al mondo un figlio con un musicista nero e averlo battezzato Tatum, in onore del grande pianista Art Tatum.
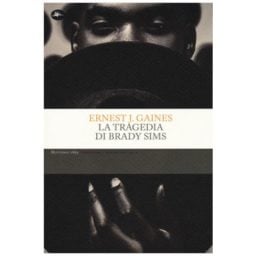
FUGA DAL SUD
A mille miglia, nella Louisiana di Gaines, paesaggi e climi mutano. Le cittadine sono piccole e la natura prende il posto del cemento. In questi spazi immensi lo sport tradizionale del fine settimana, la caccia, diventa il terreno di una improbabile amicizia interrazziale. Da una parte il bianco Mapes, ultimo discendente – dopo il nonno e il padre – di una dinastia di sceriffi, dall’altra Brady Sims, un nero duro come la roccia che non ha paura di scontrarsi con i bianchi, sempre con il fucile da caccia pronto, una mira formidabile e la bisaccia piena di selvaggina. Sims è insieme buono e cattivo, dispensa la violenza come il castigo del dio biblico, difende i giovani neri dai pericoli della società segregata frustandoli a sangue, per farli stare al loro posto, dove (forse) possono salvarsi dai bianchi. La passione per la caccia lega Mapes a Sims, l’uno buono ma codardo, l’altro crudele, ma a suo modo giusto.
Anche qui vince il paesaggio: i bar di paese, i campi incolti, le vecchie piantagioni, le strade di campagna, la natura che si riprende gli spazi rurali spopolati. Il blues non è citato da Gaines, ma è impossibile leggere la storia, una tipica tragedia di razzismo, morte e degrado, senza sentire vibrare questa musica nella parola scritta, colonna sonora di un crimine annunciato il cui approdo non può che essere la prigione di Angola, lo spauracchio per tutti i neri. Chi finisce rinchiuso dentro Angola muore o ne esce zombie. È l’Angola Blues cantata da Leadbelly o Robert Pete Williams, due che da quel cimitero di morti viventi sono riusciti ad andarsene senza impazzire, grazie al blues guaritore perché Blues is the Healer, come cantava John Lee Hooker. Il racconto è ambientato nei primi anni Settanta, come si intuisce da alcuni particolari, ma l’autore non fornisce riferimenti certi. L’impermeabilità al cambiamento del sud, il suo destino, è senza tempo. Si può solo fuggire. La grande migrazione afroamericana verso nord, piena di rabbia e speranza, è stata una diaspora su quella strada – oggi turistica – dove la musica, approdata a Chicago si è solidificata in stili immortali. Così sono arrivati per primi giganti come Louis Armstrong o Sidney Bechet che hanno trasformato il jazz in arte, ma dopo qualche decennio è giunto, a elettrificare il blues, un altro oriundo del sud come Muddy Waters.
Perché i neri sono scappati dal sud? Nel romanzo di Gaines se ne discute dal barbiere, da sempre vitale luogo di aggregazione per gli afroamericani (e non solo). Nel negozio, le fotografie appese alle pareti raccontano una storia di orgoglio razziale, sport e musica. «C’erano foto di atleti famosi come Joe Louis, Jackie Robinson, Muhammad Ali e Bill Russell. Poi c’erano le foto di Martin Luther King Jr. e dei fratelli Kennedy. E una di Mahalia Jackson che cantava, una di Malcolm X che predicava e una di Duke Ellington al pianoforte». La discussione verte su due possibili cause per la fuga dei neri dal sud: la guerra e il trattore. La guerra attira al nord promettendo lavoro nelle industrie belliche e migliori opportunità a chi entra nell’esercito. L’arrivo dei macchinari agricoli, che solo i bianchi possono acquistare, riduce il lavoro dei neri nei campi alla sussistenza. Dietro le parole dei clienti del barbiere si coglie l’eco dello Steinbeck di Furore, ma Gaines non fa né il sociologo, né lo storico: racconta il solito amaro vecchio buon blues.

