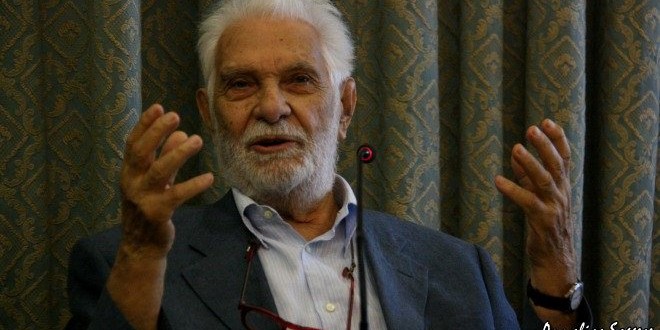Poco meno di un mese fa, Ermanno Rea si stava preparando per il suo ultimo viaggio con la stessa meticolosità che gli aveva consentito di non affidare neppure una parola al caso in decenni di reportage giornalistici e romanzi-verità. Questa volta lo faceva senza spostarsi dalla sua bella abitazione romana, «la mia prigione dorata» come amava ironizzare, di fronte alle mura di cinta di quel Vaticano che così tanto aveva condannato in un «libro-sfogo» sul carattere degli italiani, La fabbrica dell’obbedienza, al quale teneva come a un figlio a cui aveva prestato poca attenzione: un improvviso ricovero in ospedale gli aveva impedito di promuoverlo come avrebbe voluto. Per questo, appena poteva, lo ritirava fuori. Più che dalle cronache dell’immancabile manifesto sempre in bella vista sulla scrivania, in quei giorni era catturato dalla riscoperta dei Racconti di Tolstoj, raccolti in un Meridiano Mondadori. Aveva in mente di dedicarsi alla forma breve, l’unica che avrebbe potuto reggere al rischio dell’incompiuto. In quei giorni, Rea fantasticava di un giornalista-scrittore che aveva fatto del disordine uno stile di vita ma aveva accumulato quasi maniacalmente libri e oggetti. E ormai, avanti con gli anni, aveva deciso di mettere ordine nelle proprie cose, buttando tutto ciò che riteneva superfluo, salvando solo l’essenziale. Superfluo immaginare che pensasse a se stesso, alla libreria sterminata nella quale non riusciva più a raccapezzarsi, ai tanti libri inutili che non aveva avuto il coraggio di eliminare e alle migliaia di pagine di appunti e alle altrettante ore di interviste su nastro utilizzate per le inchieste giornalistiche e i suoi romanzi: basti pensare che dagli appunti di Mistero napoletano era riuscito a tirare fuori un libro-appendice, Il caso Piegari, una sorta di giallo-verità sulla follia del fondatore del gruppo Gramsci napoletano negli anni Cinquanta.
Ogni oggetto ritrovato gli riportava alla mente un momento particolare della sua vita o gli ripresentava agli occhi un episodio rimosso. Negli ultimi anni, da quando gli acciacchi dell’età lo facevano sentire più «scassatello», come minimizzava per non far pesare sugli interlocutori l’usura del tempo, lo scrittore-giornalista aveva preso a scandagliare la libreria di casa. Era nato da queste ricerche Io reporter, il bellissimo libro fotografico edito dalla Feltrinelli che testimonia gli anni in cui, licenziatosi da Vie Nuove, il settimanale del Pci dov’era compagno di banco di Miriam Mafai e Pier Paolo Pasolini, aveva deciso di appendere la penna al chiodo per darsi al fotogiornalismo. Per mesi Rea si era dedicato alla ricostruzione del suo archivio, recuperando i negativi e facendo riprodurre gli scatti pubblicati su quotidiani e settimanali. Li aveva raccolti per argomenti e ordinati in libroni con le didascalie, quasi costruendosi su misura, da amanuense provetto, il libro che immaginava dovesse venirne fuori.
Sempre rovistando tra i ricordi di Mistero napoletano, il romanzo-inchiesta sul Pci campano che gli alienerà le simpatie di molti tra gli eredi di quella stagione politica ma allo stesso tempo gli garantirà l’immortalità letteraria, aveva partorito l’idea di un mini-romanzo, poco più di un racconto lungo, che si intitola La comunista. Qui la protagonista Francesca Spada ritorna a Napoli da «fantasma flâneur» e, in una notte da ubriachi, attraversa la città insieme allo scrittore. Lei ha l’età della sua morte, lui non è più quello di un tempo, ma si lascia dire «sei carino, sei proprio carino, peccato che hai le gambe corte, sei un brevilineo. Altrimenti mi sarei innamorata di te». Un giorno, dal suo «scatolone dei ricordi» aveva tirato fuori a sorpresa una vecchia foto: «Eccola, è Francesca nella sua casa napoletana, poco prima di suicidarsi».
Raramente i personaggi dei suoi libri, pur se inventati, non hanno avuto un alter ego nella realtà. Un giorno, a Napoli per un duetto con Raffaele La Capria alla libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri, aveva riconosciuto tra il pubblico l’uomo che gli aveva ispirato la figura di Vincenzo Buonocore, l’operaio dell’Ilva di Bagnoli protagonista de La dismissione, ancora una volta ambientato nella sua città. Chiamato a presiedere il Premio Napoli, nonostante fosse ormai quasi ottantenne, aveva cominciato a frequentare i disperati che affollano la stazione centrale fino a imbattersi nel personaggio che gli ispirerà Caracas, il naziskin convertito all’Islam di Napoli ferrovia, romanzo che chiude idealmente la trilogia cominciata con Mistero napoletano e proseguita con La dismissione. Da ultimo, aveva raccontato che pure il personaggio di Adele, l’avida lettrice «che viveva i libri dal di dentro» de Il sorriso di don Giovanni, è ispirato a una sua vecchia conoscenza.
Non parlava volentieri di un solo suo libro, Fuochi fiammanti a un’hora di notte, che pure gli aveva fatto vincere il premio Campiello. Non ne consigliava la lettura, quasi fosse un figlio da ripudiare, e non spiegava perché non gli piacesse. Di recente lo aveva ripreso in mano con l’idea irrealizzabile di riscriverlo. Il libro-inchiesta sulla misteriosa scomparsa di Federico Caffè, L’ultima lezione, lo aveva invece avvicinato alla galassia degli allievi dell’illustre economista, convincendolo della necessità di un «riformismo rivoluzionario», la stessa che l’aveva spinto, da ultimo, a schierarsi apertamente per Luigi de Magistris come sindaco di Napoli e a candidarsi alle Europee come capolista de L’altra Europa per Tsipras. «Mi sarebbe piaciuto entrare nel Parlamento europeo solo per un giorno», diceva. Poi si sarebbe dimesso per fare largo ai giovani. Forse era convinto di sapere dov’era finito Caffè, ma lo raccontava solo ai più intimi anche perché sapeva che ormai la sostanza di quel che aveva scritto non sarebbe cambiata.
Ermanno Rea era solito affermare di aver cominciato a scrivere libri tardi, «a 65 anni, quando sono andato in pensione». Aveva il cruccio di non averlo fatto prima, ma la sua grande passione per la letteratura («sono un maestro mancato», diceva) era stata soffocata dalle frenesie del giornalismo e pure dalla fotografia. È forse per recuperare il tempo perduto che negli ultimi anni ha pubblicato molto, almeno un libro all’anno, sempre documentandosi in maniera da non omettere alcun particolare.Negli ultimi mesi stava cercando di riordinare gli articoli pubblicati su numerose testate, dagli esordi all’Unità a Vie Nuove, dal Messaggero a Panorama, fino agli ultimi anni al manifesto. Alcuni li riteneva datati o semplicemente poco brillanti. «Ho scritto troppo e di tutto», scuoteva il capo di fronte ad alcuni pezzi che riteneva da cestinare. Di altri, come l’inchiesta su un caso di razzismo contro gli italiani in Svizzera, si compiaceva tuttora.
Ha lavorato fino alla fine, spostandosi tra il divano letto e la scrivania attrezzata con un vecchio Mac portatile, un telefono fisso e il cellulare, riuscendo a consegnare un ultimo romanzo senza curarsi del male che avanzava e del quale parlava con distacco. Si intitolerà Nostalgia ed è ambientato nel rione Sanità, quella «Napoli al quadrato» che amava così tanto semplicemente perché era nato al numero 8 di piazza Cavour, porta d’ingresso del quartiere, e da piccolo trascorreva i fine settimana dai nonni in via dei Cristallini, nella zona più povera. Il primo appunto risale al 10 febbraio del 2012, racconta la storia di un uomo che torna a Napoli dopo essere andato via da giovane e aver girato il mondo. Qui riscopre una lingua abbandonata, odori e sapori sopiti ma pure una città maledetta, dove il passato non passa mai davvero e alla fine lo condanna.
Nella smania di fare ordine nei cassetti e trasformare quest’operazione nel suo ultimo racconto, Ermanno Rea aveva di recente ritirato fuori questa cinquantina di pagine, trasformandole in un romanzo e affidando la voglia di riscatto a un prete rivoluzionario e a un pugno di giovani disposti a seguirlo. Un mese fa, era ancora indeciso sulla foto di copertina: un’immagine di povertà a Napoli di Mimmo Jodice, molto bella ma disperata, o un suo vecchio scatto napoletano, più speranzoso. Aveva lasciato intendere che gli sarebbe stata gradita quest’ultimo, non per narcisismo bensì per quello che intendeva.
Alla fine, lo scrittore-giornalista impegnato nell’arduo compito di decidere cos’era da buttare o cos’altro da salvare di tutto ciò che aveva maniacalmente conservato nell’arco di una vita densa e ricca di soddisfazioni come poche altre, non riesce a gettare nulla. Sconfortato, giunge alla conclusione che, parola di Ermanno Rea, «è più facile vivere che imparare a morire».