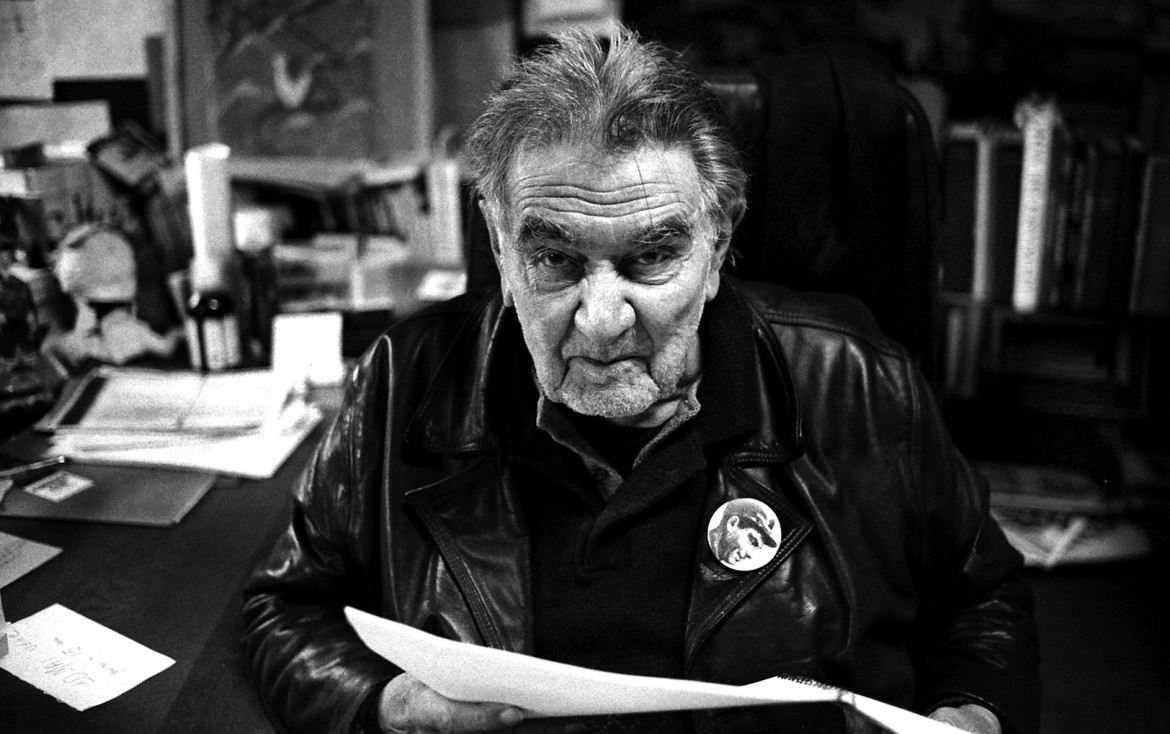Qui a enfanté Le Pen? Oltre una ventina di anni fa, quando ancora le nuove destre populiste e xenofobe erano trattate da molti analisti alla stregua di epifenomeni – «si tratta solo di un voto di protesta destinato ad essere rapidamente riassorbito dai partiti tradizionali», ci si sentiva spesso ripetere da quanti intendevano negare il pericolo ricorrendo ad un armamentario interpretativo vagamente consolatorio – alcuni tra i maggiori scienziati politici francesi, e tra loro Nonna Mayer e Pascal Perrineau, avvertivano già l’urgenza di definire, per quanto possibile, una «teoria» complessiva di ciò che stava accadendo, oltre a descriverne la fenomenologia.
La Francia era infatti all’epoca il paese in cui andava emergendo nel modo più netto quel profilo articolato e composito che fa ancora oggi della «nuova destra» uno dei protagonisti indiscussi della politica europea: le cas départ, il punto di partenza di qualcosa destinato a radicarsi e crescere nel tempo. Domandarsi, come facevano già nel 1989 i due politologi nel loro Le Front National à decouvert, chi avesse «partorito» in termini politici e culturali il movimento guidato da Jean-Marie Le Pen, quali il contesto economico e sociale che ne avevano favorito l’ascesa ben oltre il carattere episodico di una fase d’emergenza, significava legare, per le vicende d’oltralpe come per quelle del resto del Vecchio continente, la comparsa di queste formazioni ad alcune delle maggiori trasformazioni intervenute a partire dalla fine degli anni Settanta: la rivoluzione economica della globalizzazione, compiuta nel segno dell’offensiva neoliberista, e la conseguente rivoluzione conservatrice che ha ristrutturato l’intero spazio simbolico delle destre.
Come segnalato da Alain Bihr fin dal 1992, in Pour en finir avec le Front National, è infatti nel segno di una crisi maggiore del mondo occidentale che le idee dell’estrema destra, del tutto discreditate dopo la fine della Seconda guerra mondiale, sono tornate, seppure in una forma per molti versi del tutto nuova, ad ottenere visibilità nello spazio pubblico. Per Bihr, «quella vissuta da tutte le società europee occidentali a partire dagli anni Settanta è una crisi non solo economica, ma anche sociale, politica e culturale, che consentirà all’estrema destra di uscire dalla marginalità». In particolare, «la crisi ridefinirà la distribuzione geopolitica europea di queste forze, spostando il centro di gravità dal Sud al Nord dell’Europa. Un segnale, fra gli altri, di quanto l’estrema destra non possa essere considerata un arcaismo, l’espressione di un’arretratezza economica e politica, come spesso si è sentito dire, ma invece un fenomeno che si nutre di processi in atto nel cuore stesso della modernità».
Proprio il contesto della crisi, sociale e di senso, del mondo occidentale e le grandi trasformazioni evocate dallo stesso Bihr, produrranno una decisa riorganizzazione anche della «politica». In particolare, come sottolineato all’inizio del nuovo millennio in un editoriale di un numero monografico di Le Monde diplomatique, dedicato allo sviluppo del «nuovo populismo di destra», «durante i tre decenni che hanno fatto seguito alla Seconda guerra mondiale, la vecchia destra autoritaria ha dovuto mordere il freno». Ma, «non era andata in disarmo, continuava, discretamente a condurre la battaglia delle idee. Presentandosi come opposizione al “politicamente corretto” progressista, si interrogava sospettosa: non è che la democrazia si è spinta troppo in là? La morale tradizionale può essere impunemente messa in discussione senza il rischio che il caos si installi nei posti di lavoro, nelle famiglie, nelle strade?». Niente di nuovo, in apparenza. «Ma quando l’euforia dei “trenta gloriosi” comincia a dissiparsi, quando la disoccupazione diventa un fattore stabile dell’economia, si comincia a prestare nuovamente attenzione alle idee di un tempo che gli anni di prosperità e di progresso avevano contribuito ad allontanare».
In realtà, è negli ambienti del nuovo conservatorismo di matrice neoliberale, la cui offensiva egemonica sarà simboleggiata, pur con le loro distinte specificità, dalle vittorie elettorali di Ronald Reagan e Margaret Thatcher che si produrrà quella ricerca di un vocabolario atto ad interpretare le trasformazioni sociali e politiche dell’epoca che aprirà la strada anche all’emersione delle nuove destre populiste e xenofobe. Da questo punto di vista, sarà, ancora una volta in Francia, che la sfida per la conquista delle élite di un mondo conservatore attraversato da una tumultuosa trasformazione, a costituire, come ricordato dallo storco Pierre Milza, il primo banco di prova per il successo di un nuovo pensiero anti-progressista, incarnato in particolare dall’area della nouvelle droite intellettuale riunita intorno allo studioso Alain de Benoist. Nel suo Europa estrema, Milza segnala che il laboratorio culturale che fornirà in seguito al populismo di destra, a cominciare dal Front National, molti dei suoi argomenti diventerà «alla fine degli anni Settanta, la cellula pensante delle destre» francesi intese in senso plurale, a cominciare proprio «dalle grandi formazioni politiche» del mondo conservatore e, all’epoca, dai «gabinetti ministeriali dell’era giscardiana», dopo aver contribuito a formare una parte dell’opinione pubblica gollista e liberale attraverso le testate del gruppo editoriale Hersant, il Mondadori transalpino.
Il nocciolo duro delle analisi proposte dalla nouvelle droite, ha spiegato alcuni anni fa al Manifesto il politologo Jean Yves Camus, sarà, «dapprima costituito dalla riabilitazione di temi che erano stato completamente abbandonati dalla destra classica, vale a dire soprattutto le tesi sull’“ineguaglianza degli individui” e sull’importanza da assegnare alle “radici identitarie”, sia francesi che europee». Quindi «la proposta di un’idea della politica non più ancorata alla dicotomia tra destra e sinistra», bensì ridefinita nei termini della ricerca «di uno spazio comunitario fondato sull’identità nazionale. Ciò che Jean-Marie Le Pen avrebbe in seguito riassunto nello slogan “né destra né sinistra, solo francesi”».
La «rivoluzione conservatrice» della fine degli anni Settanta, tendeva perciò a ridefinire un’«idea organica» della società che ne potesse accompagnare la ristrutturazione produttiva ed economica all’insegna di una versione ammodernata di quel «Dio, patria e famiglia» che si pensava ormai inutilizzabile dopo il 1945 e che il Sessantotto aveva contribuito ad affossare ancor più profondamente. L’incontro con quanto stava emergendo, sebbene ancora in modo episodico, negli ambienti del radicalismo di destra, avrebbe contribuito a sviluppare una miscela potenzialmente incendiaria, come, ancora una volta in modo particolarmente evidente in Francia, è accaduto più di recente con la campagna lanciata da Nicolas Sarkozy per fare propri alcuni dei temi agitati da Marine Le Pen, dalla violenta critica alla «cultura del ’68» fino a quelli dal profilo identitario, securitario e xenofobo.
Se la crescente contaminazione tra la destra liberista e conservatrice e quelle che sono state ribattezzate in seguito come nuove destre postindustriali e anti-immigrati, ha trasformato per sempre il panorama politico alternativo alla sinistra, dando nei fatti origine ad una sorta di «destra plurale», ciò che gli strateghi neoliberali non sembrano aver però considerato è che le idee e le forze che avevano così contribuito a legittimare – spesso operando anche delle pericolose incursioni revisioniste sul piano storico, come la famosa visita compiuta nel 1985, in occasione delle celebrazioni per il cinquantenario della fine della Seconda guerra mondiale, da Ronald Reagan al cimitero militare tedesco di Bitburg, dove erano seppelliti anche decine di appartenenti alle Waffen SS, equiparati così implicitamente alla vittime del conflitto – da possibili partner si sarebbero rivelati ben presto come degli insidiosi competitori.
Sorta all’ombra delle grandi trasformazioni economiche dell’Occidente, la nuova destra si è trasformata da sintomo ad elemento costitutivo di una crisi che nel segno della precarizzazione delle esistenze è divenuta strutturale nelle società europee, usufruendo di un vocabolario retorico pienamente sdoganato nello spazio pubblico, si tratti del riferimento alla «preferenza nazionale» o all’odiosa e costante ricerca di un «capro espiatorio» da dare in pasto al malessere sociale diffuso. Come annotava Alan Bihr, non si tratta di una revanche sulla storia, ma di un ben più insidioso «ritorno al futuro».