Poiché si avveravano le seguenti condizioni fondamentali:1) che ci trovavamo in quattro; 2) che erano le nove di sera; 3) che tutti i teatri stavano chiusi per lo sciopero dei lavoratori della scena; 4) che era di sabato, Umberto propose di fare una partita a poker.
L’ultima delle sopra dette condizioni rivela sùbito al lettore che eravamo quattro buoni borghesi; la quale categoria di cittadini conta sulla domenica mattina per dormire qualche ora di più, e perciò soltanto il sabato sera si permette una veglia più lunga.
So che per molti sarà una delusione sentire che io, dipintore e celebratore della Vita Intensa, sono un buon borghese. Lo studio della storia letteraria dà spesso di siffatte delusioni. Ne dà anche di più profonde. Dante Alighieri quando scriveva i sonetti della Vita Nova, faceva, sia pure pro forma, lo speziale. (…)
«Un’oretta, non più» disse Umberto, cominciando senz’altro a mescolare le carte. «Un’oretta?» obietta il lettore ingenuo – e allora che bisogno c’è d’essere buoni borghesi, di trovarsi al sabato sera e contare sulla domenica mattina per dormire qualche ora di più, se erano soltanto le nove e non si trattava che di un’oretta?».
* * *
Manifestamente quel lettore ingenuo non ha tenuto conto dell’utile avvertenza che precede questo romanzo, cioè s’è messo a leggerlo senz’aver mai giocato a poker, altrimenti saprebbe che questo nobile gioco ti comincia sempre, infallibilmente, con la frase: «Un’oretta, non più». Nessuna partita di poker ha mai durato meno di sei o sette ore; i giocatori lo sanno, e quella frase per nessuno d’essi ha valore di misurazione preventiva del tempo. Ma è una formula immancabile, rituale e sacramentale d’inizio. Probabilmente è antichissima e tradizionale. Guai non pronunciarla: porterebbe disgrazia; tutte le volte che nel vasto mondo, è stata cominciata una partita a poker senza quella frase, alla fine qualcuno dei giocatori ha avuto da pentirsene.
Perciò Umberto, che conosce bene tutta questa materia, cominciando a mescolare le carte proclamò: «Un’oretta, non più». Al che qualcuno degli altri, sempre seguendo puntualmente il vetusto rituale, pronunziò con aria convinta: «Se si tratta di un’ora…».
E furono distribuite le puglie. Ma quando fummo tutti ben collocati (Umberto sul divano, io su una sedia in faccia a lui, Cesare sprofondato con la vasta metà posteriore del suo mobile corpo in una poltrona alla mia destra, Isidoro in faccia a lui su un’altra sedia) quando fummo tutti solidamente piazzati come quattro cannoni d’assedio, nacque una discussione pregiudiziale, importantissima, sul valore da dare alle puglie (o marche, o tessere come avrebbe detto Carducci se avesse giocato a cane con Lydia, o fiches come si chiamano in Italia). Discussione importantissima, non tanto per noi allora, quanto ora per i miei lettori, perché da quella discussione nacque ciò che formerà l’interesse precipuo e incombente di questo romanzo e la sua ragion d’essere fatale e profonda (senza contare che nella galleria della Vita Intensa moderna non poteva mancare un quadro di poker).

Sull’argomento, dunque, del valore da dare alle puglie, furono rapidamente esposte e sostenute due diverse tesi; non dico gli autori di ciascuna per non rivelare troppi segreti intorno alle loro indoli personali.
Prima tesi: il valore della puglia dev’essere un po’ alto, non per avidità di guadagno, ma perché altrimenti manca al giuoco quel sapore vivo, che gli dà un incitato e pimentoso fremito di lotta.
Seconda tesi: in un giuoco di maestria magnificamente psicologica quale è il poker, il giuoco stesso non ha bisogno d’essere avvivato o pimentato dal desiderio del guadagno o dal timore della perdita; anzi deve in esso operare quanto è possibile la sola e pura tecnica del giuoco stesso.
Disgraziatamente tra noi quattro c’era un sofista fantasioso, il quale (io lo conosco da tempo) parla e agisca talvolta sotto l’influsso del Maligno. Egli propose una
Terza tesi: facciamo operare la sola tecnica del giuoco, lasciando ignorata la posta.
«In qual modo?». «Stabiliamo tre o quattro valori ipotetici della puglia, senza sceglierne alcuno per ora. Solo a giuoco finito il estrarrà a sorte quale dei valori debba esser tradotto in realtà. Cosi ognuno giocherà soltanto secondo la propria maestria, senza sapere se sta perdendo o guadagnando poco o molto del proprio vile danaro; ma intanto, durante l’intero corso della partita, incomberà su noi tutti come un fato ignoto l’imperscrutabile sorte finale».
* * *
La terza tesi fu accettata, e con una lieve modificazione attuata nel modo seguente.
Anzitutto abbiamo scritto su quattro biglietti diversi quattro valori diversi da poter attribuire alla puglia-base. Il propositore della prima tesi scrisse dieci lire, quello della seconda scrisse una lira, l’altro tenne virtuosamente il cammino di mezzo e scrisse cinque lire. Io, il più giovane, fui l’ultimo a scrivere. Di fronte alle tre ipotesi dei mici compagni, dovendo formularne una quarta, rimasi perplesso per un poco. Non osavo scrivere «venti lire», e sarebbe stato assurdo porre un valore frammentario intermedio tra quelli. Infine mi feci coraggio, e scrissi un soldo.
Abbiamo messo i quattro biglietti in quattro piccole sopraccarte bianche identiche tra loro. Abbiamo chiuso le sopraccarte, e le abbiamo agitate scrupolosamente in un vaso.
Poi ne abbiamo estratte tre, e bruciate religiosamente su una candela, senza aprirle.
La quarta rimase, sola e misteriosa, nel vaso. Ponemmo questo su una mensola alta: da quell’altezza, là dentro, il fato ignoto e unico, imperscrutato e immutabile, doveva incombere sulle predestinate sorti dei vincitori e dei perditori durante l’intero corso della partita. La partita cominciò, religiosamente.
I primi giri d’una partita di poker sono sempre pallidi e tepidi. II grosso positivista, il quale pensa che sulla combinazione d’un certo numero di carte mescolate operi il puro caso, non ha mai giocato a poker. Perché nel vasto mondo non è avvenuto mai che ad alcun giocatore si presentasse una forte combinazione – un full, un colore, un poker, una sequenza reale – prima del quarto o quinto giro della partita. E in nessuna partita di poker, nel vasto mondo e nella serie infinita dei tempi, e accaduto un interessante e combattuto incontro prima del quarto o quinto giro.
Basta questo incontrovertibile fatto per avvertirci che nessuna combinazione di carte è mai casuale, ma tutte sono dominate da una intelligenza misteriosa (…). Fedele all’inviolabile legge, anche quella sera la misteriosa intelligenza, la quale plasma ogni partita secondo un’armoniosa norma sinfonica, frenò per qualche giro le energie latenti della sorte; non ho dunque per quell’inizio da registrare alcun fatto degno di memoria.
* * *
Al primo giro, com’è costume, si colse tutti l’occasione di passare, perché è opinione accreditata che porti disgrazia vincere in principio. Il primo piatto, insignificante, fu vinto da Cesare il quale ebbe da ciò l’occasione di emanare i suoi primi brontolii, ma ancora in sordina; e conseguentemente Isidoro potè scandirgli le prime rimbeccate, ma ancor blande, osservando così in tutto la moderazione voluta dalla suesposta legge di calma iniziale. I primi fremiti si manifestarono, se mal non ricordo, appunto al quinto giro. Io, come è mia abitudine, non ero riuscito a mettere insieme niente di buono ed ero passato.
Isidoro che, alla mia sinistra, aveva aperto e preso una carta, fece un discreto rilancio. Umberto passò. Cesare accettò (vedo) il rilancio di Isidoro. Mostrate le carte. Cesare aveva due coppie al re e Isidoro due coppie all’asso.
«Lei non sa» scandì Isidoro raccogliendo il piatto «che due coppie al re chiamano infallibilmente due coppie all’asso?». «Ma con due re avevo due donne» – ribatté Cesare cominciando ad agitarsi -, è lei che non sa che quando ci sono le due donne i re non dovrebbero più chiamare gli assi ». «La colpa non è mia – rimbeccò l’altro – se lei con due donne non riesce a far niente».
Insomma, le solite facezie. Cesare conchiuse: «Io me ne vado ». E cosi dicendo cominciò a mescolare le carte, perché era il suo turno.
Alla fine di quella prima fase della seduta le differenze non superavano 8 o 10. «Otto» o «dieci» che cosa? Non era ancora importante saperlo, e nessuno per il momento pensava al biglietto, vigile nella bianca sopraccarta entro il vaso impassibile sull’alta mensola.
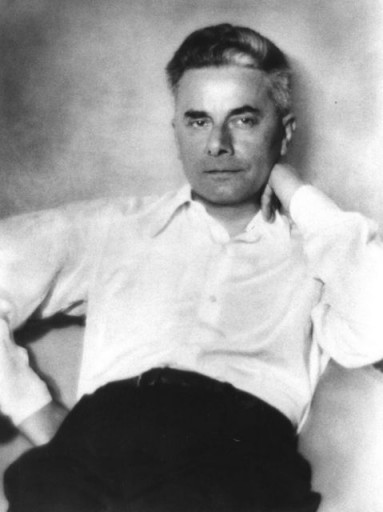
A questo punto la Misteriosa Intelligenza stimò opportuno rovesciare tempestosamente tra noi una serie di forti combinazioni. Fu come un tutti orchestrale che irrompa improvviso sopra un lungo preludio d’accordi indugiati e sommessi. I full pulsavano sul tavolino verde con un ritmo continuato e isocrono, e furono, per parecchi giri, il punto costante di partenza d’ogni assalto. Essi battevano le arsi e le tesi del tempo; in mezzo a quei battiti lampeggiavano girandole di colori, s’intricavano combinazioni variate di altri full maggiori e minori, schiantò il frastuono d’un poker improvviso e violento (lo aveva fatto Umberto, partendo con una coppia). Le cifre dei piatti aumentavano. Poi d’un tratto i full scomparvero, e sùbito sembrò abbassarsi, ma per breve, il tono della lotta. Quella scomparsa impreveduta fu forse provocata da uno scoppio di verace e legittima ira da parte di Cesare. Io avevo aperto con un magnifico tris d’assi: quadri, cuori e fiori.
Credo che molti converranno con me che il tris d’assi è il punto più gradevole da tenersi in mano. Quel triplice candore, appena violato nel mezzo dalla sigla unica delle simboliche figurazioni, dà un piacere artistico che supera il valore e l’interesse della combinazione. Mi compiacevo contemplando i due suggelli vermigli e il nitido fiore. Allo scorgere quel tris massimo, avevo avuto un profetico sussulto di gioia, assai più che se avessi sortito un punto migliore: mi ci ero attaccato con risoluzione fanatica. Presi onestamente due carte. E le guardai a malincuore. Se mi fossero venute due carte uguali tra loro, il mio punto sarebbe molto migliorato; ma non lo desideravo, anzi lo temevo: il mio piacere quasi puramente estetico, se ne sarebbe turbato e guasto.
* * *
Quando vidi che il mio tris rimaneva inviolato, ne fui felice. Non avrei rinunciato a lottare con quello, contro qualsivoglia provocazione. Ciò mi dette una invincibile forza di persuasione. Rilanciai. Isidoro passò. Umberto aumentò ancora. Cesare accettò il rilancio di Umberto. Io senza esitare rilancio di nuovo. Umberto passa. Cesare riflette un po’, poi passa anche lui gettando sul tavolino le carte coperte con un gesto di rabbia.
Avevano tutti abbandonati la lotta, avevo vinto. Avrei potuto raccogliere il piatto senza rivelare il mio punto. Ma, con intenzione puramente cordiale, mostrai le carte con cui avevo giocato: volevo far parte ai mici compagni del piacere artistico di quei tre assi (uno nero e due rossi!). Fu ingenuità. Umberto disse con calma: «Perbacco, io avevo un piccolo full».
Ma Cesare esplodeva come una granata di grosso calibro: «Anch’io full, e mica piccolo! Eccolo eccolo ancora qui: tre fanti e due re. Ma se il full ormai non valeva più niente. Ho perduto poco fa un colpo di quaranta con un full di donna. Da un’ora nascono i full come i funghi, e incontravano colori e poker! Chi va a pensare che tu, che hai perduto fino adesso, dovessi lanciarti a quel modo con un miserabile tris?».
«Domando scusa » mormorai malvagiamente. «Lei ha giocato da cane» – scandì Isidoro volgendosi a Cesare -, il tris era evidente, e io lo avrei veduto anche con una sequenza minima».
«Evidente un corno – bramì Cesare agitando le spalle e tutto il corpo fino alla parte che stava incastrata nella profonda poltrona – io dovevo per forza fargli in mano un poker, e non potevo supporre un bluff così spudorato».
«Chiama bluff con un tris d’assi, lei? ». Qui venne in campo la tradizionale discussione, se il bluff sia un assoluto o un relativo; ma Cesare la troncò dichiarando recisamente: «Io me ne vado!». E così dicendo cominciò a mescolare le carte, perché era il suo turno. Intanto ognuno di noi valutava approssimativamente, con un’occhiata rapida, la propria puglia; e tutti insieme, senza intesa, come spinti d’un tratto da un congegno meccanico o mossi da un comune spirito, volgemmo un tacito e lungo sguardo, sull’alta mensola, al vaso impassibile che custodiva il vigile foglio ov’era suggellato immutabilmente il valore ignoto di quella puglia.
L’Inviolato Biglietto, invisibile dentro le pareti del vaso, senti il nostro sguardo e impose misticamente silenzio alle dispute vane.
Ma il Direttore d’Orchestra dal suo cielo remoto fece tacere le trombe, e riportò sul nostro cerchio un breve periodo di calma: calma esteriore, corsa da fremiti forieri di nuovi e più vasti svolgimenti nel giuoco.
S’abbassò, in quelli sosta breve, il tono dei punti, ma crescevano le poste; e si facevano più frequenti e più intensi gli sguardi d’ognuno di noi verso il Vaso del Destino.
S’incalzarono alcuni notevoli episodi: un poker di donne (con l’asso quinta carta) incontrò un poker di re: intorno al quale incontro s’erano sentite squillare e incrociarsi, nel luminoso spazio tra la lampada e il tavolino, le parole «cento» «cento cinquanta» «trecento» quali assestati e ribattuti colpi di lancia.
* * *
Poi ci fu una corta accalmìa, colorata appena da un originale duello di bluff. Lo cominciai io, intenzionalmente; avevo cinque carte diverse; rimasi in giuoco, dichiarandomi servito. Mi tenne testa solamente Umberto, servito anche lui. Rilanciai. Rilanciò. Ma nel rilanciare, mentre con la sinistra teneva le carte, egli appoggiò il palmo della destra sull’orlo del tavolino premendocela contro.
Ora io altre sere avevo osservato che tutte le volte che Umberto bluffa appoggia e preme la palma della destra sull’orlo del tavolino; capii dunque che non aveva nulla e voleva farmi fuggire. Rilanciai ancora;
«Cento!».
«Duecento!» egli incalzò.
Non me l’aspettavo: rimasi colpito e mi giudicai battuto. Oscillai un istante: mi vergognavo a fuggire dopo essermi dato servito e aver sfoggiato quella iniziale aggressività, che non mi è consueti; ma commisi il grave errore di temere, in quel fugace istante, d’aver sbagliato giudicando Umberto in bluff: così non ebbi il facile ingegno di lanciarmi ancor più su. Fui dominato soprattutto dalla smania di volermi accertare del gioco di Umberto (ch’egli non avrebbe mostrato se mi fossi ritirato) e finii col prendere il partito peggiore, accettando:
«Vedo». Umberto gettò le carte come colui che ha perduto, dicendo: «Non ho nulla».
In metafisica il nulla è assoluto, non comporta strati o confronti, perché e unico, e non esistono due nulla, e se esistessero si identificherebbero, cioè sarebbero un nulla solo, il Nulla. Per contro nella empirica del poker non esistono identità. Si venne a confrontare il nulla di Umberto col mio. Anche lui aveva cinque carte diverse, e di varii colori. Ma la sua più alta era un re, la mia più alta una donna.
Ah le donne! Pagai duecento. Imperscrutabile Foglio sulla Mensola Eccelsa, aiutami. Isidoro chiese il permesso di assentarsi un minuto. Ci accorgemmo di essere tutti nelle sue condizioni. Ci chiedemmo reciprocamente il permesso di assentarci un minuto. Per un minuto il Vaso di Elezione rimase solo a vigilare dall’alto le cane sparse sotto la luce sul campo abbandonato del tavolino. (…)
Ogni discussione s’era spenta; il giuoco si serrava perdendo di agitazione, guadagnando d’intensità. Non c’era ebrietà, c’era una vertigine tutta interiore e occulta, come il contenuto del Foglio, la cui ora si slava avvicinando con un silenzio sempre più profondo, quale dev’essere nel cammino delle Idee quando abbandonano l’etere per discendere ad attuarsi sulla crosta del mondo. In tali ultime fasi d’ogni seduta del genere, tutti lo sanno, non sorgono incidenti, non si presentano episodi; i casi e gli incontri stessi che avvenuti in altre fasi si ricorderebbero per consegnarli oralmente alla tradizione aneddotici del giuoco, si succedono allora come grandi fenomeni naturali, si interpretano come volgimenti celesti; assumono un tono sacro e pacato, accolti con un uguale concentrato silenzio dai trionfatori e dai vinti.
Cosi, con vastità ed eroismo degni dell’ora, terminò quella memoranda battaglia. Quando lutto fu finito, si fecero freddamente, con un contegnoso aspetto di superiore distrazione, i conti delle differenze. Io non sto a raccontare in pubblico i fatti degli altri. Dirò soltanto che io avevo perduto. Avevo perduto «centocinquanta». 150 che cosa?
* * *
Il lettore arde, palpita, frigge per la curiosità di sapere che cosa stava scritto nel biglietto fatale. Umberto lo ha preso dall’alta mensola, lo tiene sollevato per quaranta secondi verso noi sotto la luce, come un’ostia sacra. Il lettore smania scalpita rugge per la curiosita di sapere se io – che avevo perduto centocinquanta – avevo perduto centocinquanta moltiplicato un soldo, o moltiplicato una, o cinque, o dieci lire, cioè se avevo perduto 7 e 50, o lire 150 o lire 750 o millecinquecento lire.
Vorrei che il lettore si guardasse in uno specchio in questo momento, che si vedesse quanto è brutto in questa sua volgare curiosità (…). Vorrei che potesse capire quanto una tale curiosità è malsana, meschina, fetida, antiartistica, bestiale vorrei dire se non riflettessi che nessuna bestia al mondo, nessun cane nessuna pecora nessun elefante sarebbe curioso di sapere se io avevo perduto 7 e 50, o 150, o 750, o millecinquecento lire. Il lettore ignora il vero fine e la vera efficacia dell’arte. II lettore non sa leggere. Egli non si rende conto che portandolo maestrevolmente, con il racconto d’un fatto in sé insipido, superficiale e banalissimo, traverso una serie di sensazioni e vibrazioni sapienti che gli hanno esagitato lo spirito durante la lettura di queste pagine, io ho del tutto assolto il mio compito di narratore e creatore di mosse fantasime, e non ho affatto l’obbligo di aggiungere un particolare tutto mio privato, insignificante, privo d’ogni portata artistica, d’ogni possibilità estetica; che col rivelargli il contenuto del biglietto (che Umberto sta tenendo sollevato sotto la luce come un mistico olocausto) io nulla nulla aggiungerei all’efficacia delle sensazioni che gli ho fatte provare.





