Il «Comune» gioca a rimpiattino. Si parte da una certezza. Non è proprietà pubblica né privata. Né Stato né mercato, dunque. Ma appena si prendono le mosse da questa chiara premessa, subito le biforcazioni si moltiplicano: ritorni all’indietro, svolte improvvise, vicoli cechi, prospettive ingannevoli.
Nel corso del tempo il «Comune» si inabissa e poi riemerge. Compare dove meno lo attendevamo, svanisce dove ci sembrava di averlo afferrato. Talvolta aggettivo che si combina con differenti oggetti, talaltra sostantivo che tutto abbraccia. Plurale e singolare. Ora prerogativa di un catalogo di «beni» concreti e definiti, ora qualità di un agire senza oggetti determinati. Talora si mostra nell’esperienza particolare della comunità per poi scivolare verso la dimensione universale dell’umanità. Lo ritroviamo nel mondo corporativo delle gilde, come in quello trasversale delle «Unions». Quando si affaccia nella lunga scia del diritto consuetudinario, eccolo subito sdoppiarsi tra il privilegio indifendibile dell’oligarchia e le legittime consuetudini della povertà, tra pretesa dell’avere e possibilità del fare, tra accumulazione e soddisfazione dei bisogni. Fa capolino nel diritto romano, storico guardiano del pubblico e del privato, per subito distinguersi tra la sfera inappropriabile del sacro e la «terra di nessuno» (res nullius) esposta all’appropriazione e al desiderio di conquista.
Un campo di tensioni
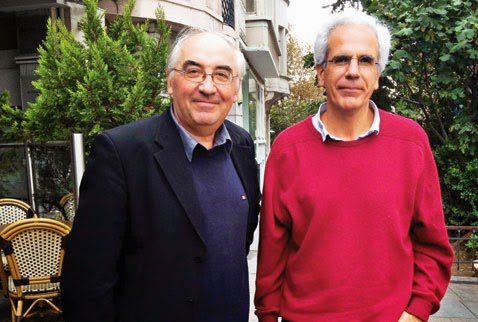
C’è chi lo intende come una terza forma di proprietà, chi come la negazione stessa di ogni logica proprietaria. Qualcuno lo vorrebbe «potere costituente», motore di una brusca rottura e di un nuovo inizio, chi, invece, capacità «istituente» di sottrarre terreno all’appropriazione privata e alla tirannia burocratica dello Stato sulla base di nuove regole condivise. Insomma, il «Comune» è uno campo di tensioni in cui diritto, sociologia, filosofia, interpretazione storica, azione politica sono chiamate a confrontarsi e cimentarsi.
Per seguirlo nella tortuosità dei suoi percorsi e nella molteplicità delle sue apparenze Pierre Dardot e Christian Laval hanno costruito un ponderoso volume (Del Comune, o della Rivoluzione nel XXI secolo, Deriveapprodi, traduzione e postfazione di Antonello Ciervo, Lorenzo Coccoli, Federico Zappino, prefazione di Stefano Rodotà, pp.535, euro 30) nella forma di un labirinto in cui seguire le tracce antiche di Pierre Joseph Proudhon, di Karl Marx o di Marcel Mauss e quelle più recenti di Ostrom, Castoriadis, Harvey o Negri e Hardt.
Nessuna delle quali condurrebbe, secondo gli autori, fuori dal dedalo di ipotesi e concetti che dovrebbero guidarci alla scoperta del «Comune». Ma, come spesso accade nei labirinti, si apprende assai di più nel percorrerli (e qui ci troviamo di fronte a uno straordinario percorso, quasi enciclopedico, di studio) che non una volta giunti tra le spoglie pareti della cella centrale. Una stanza vuota, un centro simbolico che dovremo riempire con la forza della soggettività e dell’ingegno.
Nella cella centrale, al fondo del nostro peregrinare, dopo esserci arrestati al termine di innumerevoli vicoli ciechi e circoli viziosi, dopo essere tornati più volte sui nostri passi, troviamo infatti un «principio», che così, e non come sostanza o qualità, deve essere inteso il «Comune». «Un principio – spiegano i due studiosi francesi – è ciò che viene per primo e che fonda tutto il resto», un «cominciamento sempre cominciante», arché che costantemente si rinnova.
Divieti di appropriazione
È dall’«agire comune» che proviene l’obbligazione politica, e i «beni comuni» non sono che il prodotto di questo agire «istituente», non il suo presupposto, non un passato da riscoprire e rioccupare. È insomma prassi politica che «apre un determinato spazio e che definisce le regole del suo funzionamento», il che può dirsi, beninteso, di innumerevoli esperienze. Che cosa poi possa accadere all’interno di questo agire, di questo spazio, quali forme, forse gerarchiche o insidiosamente fascinatorie, vi si possano sviluppare, quali regole e quali interdizioni, nulla potendo prevedere dovremo affidarci alla classica consolazione dell’ottimismo antropologico. Per non ricorrere a questa traballante soluzione Dardot e Laval inseriscono una «norma di inappropriabilità» a fondamento delle relazioni sociali: «l’inappropriabile non è ciò di cui non ci si può appropriare, ossia ciò di cui è di fatto impossibile appropriarsi, bensì ciò di cui non ci si deve appropriare, ossia di cui non è consentito appropriarsi perché deve essere riservato all’uso comune».
Sarà pure la prassi istituente di tutti i soggetti coinvolti a definire questo spazio, ma è difficile non percepire in questa norma un’ombra di trascendentalismo e di imperativo categorico. È il prezzo inevitabile da pagare per sgombrare il campo da ogni teleologia o determinismo che voglia il Comune partorito dallo sviluppo delle forze produttive? Stiamo ancora a dibatterci tra il «fine» e l’«a priori»?
A questo punto un passo indietro si rende necessario.

La conclusione che punta tutto su un principio politico, anzi sul principio stesso della politica è l’esito di un percorso che alla politica e al diritto conferisce un primato sul sociale e sulla dimensione economico-produttiva. Dardot e Laval, criticando il paradigma del capitalismo cognitivo, respingono l’idea che nel lavoro vivo sia andata trasferendosi quell’accumulazione di esperienze, saperi e procedure già cristallizzate nel sistema delle macchine, rendendolo così in grado di sottrarsi al comando del capitale, di passare dalla produzione dell’uomo per il capitale alla «produzione dell’uomo per l’uomo».
In altre parole, non si darebbe una potenza sociale autonoma (la forza collettiva della cooperazione) di cui il capitale si appropria, come riteneva il vecchio Proudhon, ma neanche una potenza che il capitale sviluppa nel suo seno fino a produrre una contraddizione esplosiva con il processo di accumulazione, le sue regole e le sue forme, quando i rapporti di produzione diventano la gabbia che impedisce lo sviluppo delle stesse forze produttive. Non si darebbe, insomma, nessuna generazione «spontanea» del Comune. E se non fosse per una pratica politica collettiva che stabilisce regole e produce diritto, la cooperazione produttiva resterebbe indissolubilmente connessa con gli imperativi dell’accumulazione capitalistica e il suo sistema di regole. Solo e sempre potenza del capitale.
Tuttavia, perché possano svilupparsi rapporti di natura capitalistica sappiamo essere necessaria la separazione tra il lavoratore e il suo strumento, tra produttori e mezzi di produzione. Ma questa separazione diventa problematica quando qualità cognitive e risorse soggettive devono essere messe al lavoro in posizione non più marginale per continuare a garantire la riproduzione allargata del capitale. Si tratta allora di costruire una sorta di «autonomia eterodiretta» e si può ben capire quanto questo equilibrio sia contraddittorio, fragile e «innaturale», quanto poco assicurato da automatismi o da quelle parvenze di «oggettività» che da sempre hanno fatto la forza dell’ordine costituito. Cosicché Dardot e Laval aggiungono alle due classiche forme marxiane della sussunzione capitalistica (quella formale che sottomette l’esistente e quella reale che lo trasforma), una terza forma, che i due studiosi chiamano «sussunzione soggettiva», una sorta di colonizzazione neoliberista delle anime, di interiorizzazione delle ragioni del capitale, in breve una nuova frontiera dell’alienazione.
Autonomia eterodiretta
Ma, in fondo, questa «ultrasoggettivazione», come la battezzano gli autori, non è che un altro modo per indicare come solo strumenti extraeconomici – politici, giuridici, ideologici, comunicativi – possano ricondurre il «Comune» della produzione nell’alveo dello sfruttamento capitalistico. Il che equivale a evidenziare, appunto, la natura arbitraria, parassitaria o «estrattiva» del capitalismo contemporaneo, messa però in dubbio dai due studiosi francesi. Basterà guardare al peso senza precedenti del prelievo fiscale nell’assicurare il flusso della rendita finanziaria per rendersi conto di come questi strumenti siano diventati a loro volta fattori di produzione. Non più come semplici guardiani dell’ordine proprietario, gendarmi al servizio della borghesia, ma come veri e propri rapporti di produzione. Di fronte alle tante speranze riposte in un diritto che dovrebbe difenderci dal mercato, portatore di una superiore razionalità, converrà segnalare il passaggio dalla sussunzione formale del diritto a quella che potremmo definire la sua sussunzione reale, laddove, come nel campo estremamente mobile della proprietà intellettuale, siano le norme stesse, le sentenze e i trattati a produrre valore di scambio.
I grandi studi legali statunitensi, le corti nazionali e internazionali, sono a tutti gli effetti formidabili fattori di produzione della ricchezza e non solo semplici negoziatori della sua distribuzione. Il che non significa, beninteso, che il campo del diritto debba essere disertato o che la sua sussunzione risulti senza residui, ma che non può semplicemente essere identificato con l’autogoverno del «Comune».
Un problema di condizione

La politica, dunque, è inevitabilmente chiamata in causa. Non perché assente dalla sfera dell’economia, ma proprio perché con essa strettamente intrecciata nel sistema totale del neoliberismo. Il timore, legittimo, di non insabbiarsi nel determinismo economico ha fatto spesso perdere di vista la complessità e la ricchezza dell’idea marxiana di produzione, già pienamente dispiegata in quella formula che indica il capitale come «rapporto sociale». Tuttavia, sull’intera argomentazione di Dardot e Laval mi sembra, invece, incombere quella distinzione tra «agire strumentale» e «agire comunicativo» da cui discende una concezione povera del primo e una interpretazione astratta del secondo, nonché la sostanziale incomprensione di entrambi. Impedendo, alla fine, al «Comune» di dotarsi di una solida base materiale, di una necessità riconoscibile. Contrapporre la «spontaneità», e cioè i processi storici, all’istituzione di regole condivise, fondare l’agire comune su un «principio» e non anche su una «condizione», separare la fonte del diritto da quella della ricchezza, rischia di condurci lontano dal «Comune» come costruzione sociale e costituzione politica tra loro inseparabili. Concependolo, alla fine, come un principio morale della ragion pratica.

