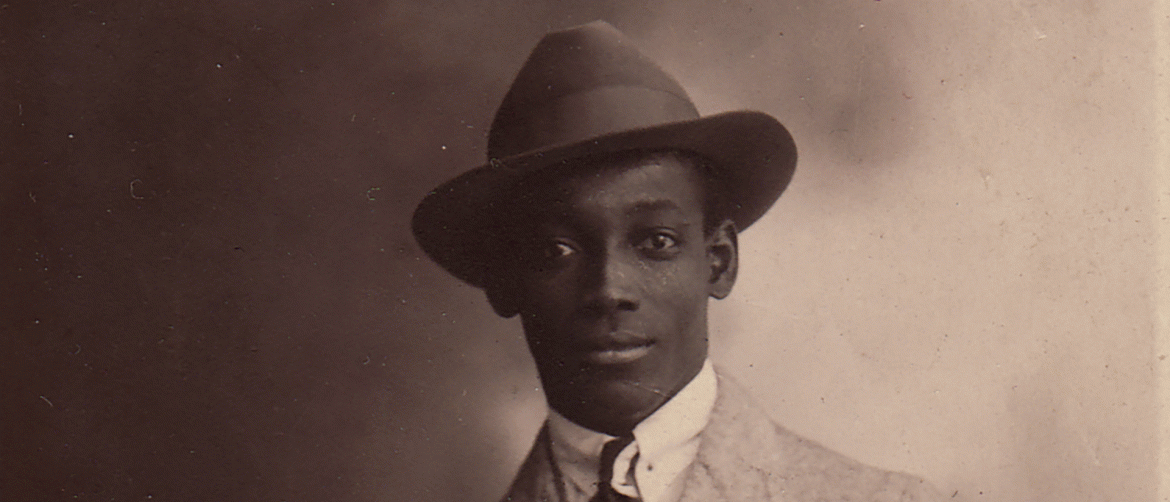Sul mappamondo in America del Sud in alto a destra, stretto tra due Guyane, una che fa da sé, l’altra che è Francia e quindi Europa tropicale. Una volta si chiamava Guyana Olandese, poi Suriname. Confinando col gigante brasiliano appare come una bagatella di mezzo milione di abitanti e non so quanto uccelli sinfonici che improvvisano minuetti colorati. Metà dell’Italia, ma quattro volte l’Olanda, il suo territorio per due terzi è coperto da foresta amazzonica, cascate armoniche e placidi fiumi. L’ossigeno non manca.
Non siamo sul National Geographic, perciò dirò subito che il 22 febbraio 1898 è nato a Paramaribo, la capitale, Anton De Kom, figlio di uno schiavo deportato dall’Africa. Se uno esplora la storia di questo paese scopre che è uno spartito del mondo su cui è stata suonata la storia degli ultimi secoli. Anche qui, frammento di un impero coloniale ordito ad Amsterdam, si è radicata la grande impresa della tratta per tenere in piedi l’economia della piantagione. Schiavismo puro con catene di ferro e marchiatura a fuoco sulla pelle. Nel 1863 in Suriname viene abolita la schiavitù e prende forma lo schiavismo impuro, catene legali e museruola mentale. Fa parte del gran traffico di lavoro vivo da sud a sud del mondo. Si arruola la merce umana nell’India britannica e nell’Indonesia olandese. Questo caporalato coloniale, tecnicamente definito indenture, da colonia a colonia, dall’Asia verso l’Africa e i Caraibi, movimenta più di tre milioni di persone. In Suriname i primi hindustani, come li chiamano, cioè indiani dell’India britannica [oggi India, Pakistan, Bangladesh] arrivano nel 1873 a bordo del veliero Lalla Kooch, sono induisti e musulmani. Seguiranno poi i cosiddetti giavanesi dall’Indonesia, colonia olandese. Anche non pochi cinesi. Gli africani deportati fin dal tardo Seicento lavorano schiavisticamente nelle piantagioni, molti fuggono nella foresta formando comunità con gli indios nativi, a metà Settecento riescono ad imporre alle autorità coloniali olandesi il riconoscimento dei loro diritti sul territorio e daranno poi modo agli antropologi di sbizzarrirsi in rigide classificazioni etniche. In tutto il continente gli schiavi che si sottraggono alla schiavitù vengono chiamati marrons, in italiano cimarroni, in olandese più spudoratamente bosneger. Nei Paesi Bassi oggi questa storia è totalmente svaporata anche se per Amsterdam o per Utrecht camminano molti discendenti di quelle popolazioni, che hanno in mente una musica che è in partenza fusion di molte musiche. Domina la White Innocence, com’è il titolo di un importante libro di Gloria Wekker, studiosa afro-surinamese-olandese. In Italia l’innocenza bianca è rimasta inviolata da sempre, forse esiste una vaghissima idea della decolonizzazione dei colonizzati, ma è un mistero gaudioso la decolonizzazione dei colonizzatori.
Anton De Kom? Il figlio di schiavi africani muore di tubercolosi il 24 aprile del 1945 nel campo di concentramento nazista di Sandbostel, satellite del lager di Neuengamme, sobborgo di Amburgo. Aveva partecipato attivamente dal 1940 alla resistenza antinazista in Olanda anche scrivendo sul giornale comunista clandestino De Vonk-La scintilla. Il 7 agosto 1944 viene arrestato per strada dalla Gestapo e deportato. Consuma la sua esistenza nello schiavista e paludoso Stalag X B.
Erano stati quarantasette anni di vita tra due piccole terre atlantiche distanti 8000 chilometri, una oltremare dell’altra. Nel 1920 il modesto contabile, autodidatta, si imbarca per Haiti e poi per l’Olanda. Si arrabatta, non ha grandi credenziali, collabora ad una rivista di scrittori di sinistra, è in contatto con militanti indiani, si sposa con Petronella Catharina Borsboom, avranno tre bambini e una bambina. Onore a questa donna che scavalca la linea del colore contrastando coraggiosamente i fortissimi tabù razziali. Primo arresto per Anton nel 1927 per attività sediziosa comunista, più tardi licenziato, nel 1932 torna con la famiglia in Suriname, con cui aveva mantenuto vivi rapporti soprattutto con i leader delle lotte dei lavoratori. Nella capitale apre una specie di Camera del Lavoro nel cortile di casa dei genitori, grande affluenza degli hindustani, giavanesi e afro-surinamesi, si parla anche di indipendenza. Agitazione delle autorità coloniali. Arrestato. La grande protesta per la sua liberazione finisce sotto il palazzo del governatorato, interviene la polizia che fa decine di feriti e due morti. Espulso, imbarcato a proprie spese su una nave torna con la famiglia nei Paesi Bassi.
Nel 1934 pubblica, molto censurato, Noi schiavi del Suriname. In olandese, in nederlandese come sarebbe più corretto dire. Ha scritto e scriverà ancora molto, saggi, romanzi, poesie, rimasti negli archivi familiari. Wij slaven van Suriname uscirà senza tagli solo nel 1971. Un testo che dà forma al passato, come forse gli ha insegnato il grande storico olandese Johan Huizinga, anch’egli finito nelle grinfie naziste e morto in carcere nel 1945. Un’opera multiforme che impianta una michelangiolesca rappresentazione di anticolonialità e una commossa rievocazione della sua prima età surinamese. Non mira all’innovazione storiografica o al plauso accademico, ma, ben prima che gli studiosi si accorgessero che gli indentured- i lavoratori a contratto erano un nuovo sistema di schiavismo globale, nel suo libro si può riconoscere la umanità, i sogni, la resistenza di questi lavoratori e lavoratrici trascinati per longitudine e latitudine. Molti decenni dopo si parlerà di Black Atlantic, di un oceano che unisce invece di separare storie e culture nere di origine africana, caraibica, euroamericana. In Noi Schiavi De Kom ne parla come di un dato esistenziale ed essenziale da nutrire e da mettere all’opera. Per lui anche i maroons, i negri della foresta, la feccia della feccia, sono invece combattenti della libertà e lo afferma perché sorpreso dall’affabilità con cui suo padre invitava in casa questo canagliume e con loro avviava conversazione e memoria. Il disprezzo che noi giovani avevamo per loro era uno dei grandi vincoli della catena che ci legava al sistema di produzione occidentale. L’apparato coloniale aveva convinto le nuove generazioni colorate che un negro era un essere inferiore e il tempo per liberarsi da questa pedagogia mimica era per forza lungo e traumatico. Alcuni si sono chiesti se De Kom nello scrivere si fosse anche prefissato intenti letterari, dal momento che il libro è ricco di descrizioni di vita e di paesaggio, come se ispirarsi all’incanto del pianeta fosse un privilegio dei soli poeti laureati. De Kom fa crescere lo sguardo di chi legge rappresentandogli non un museo a cielo aperto, bensì un multiverso in tensione di cui ci fornisce un’interpretazione e un programma: le diversità di cultura, origine, lingua, religione, non devono far dimenticare che queste popolazioni sono unite dalla loro subalternità e dalla loro opposizione all’ordine sociale coloniale. Dal dolore patito, dalla speranza arrabbiata, dalla fantasia scalpitante. De Kom vede la classe dove altri vedono solo folcloristiche etnie e nazionalità. E’ il suo marxismo vitale e non dottrinario che gli permette non di indovinare il mondo, ma di spiegarlo. Sfruttamento, razzismo, disumanizzazione, auto liberazione sono i suoi temi.
Nel 2006 ad Amsterdam in un quartiere periferico, ma globale per popolazione, gli viene dedicato un monumento che troneggia in una piazza che porta il suo nome. La scultrice olandese l’ha rappresentato eroico, ma seminudo, come può solo esibirsi un selvaggio negro che combatte. L’innocenza bianca ha qui la sua nefasta autocelebrazione.
Un bellissimo documentario con didascalie in inglese è stato girato da Ida Does, intitolato Peace, Memories of Anton de Kom, completo su YouTube.
Inutili i miei tentativi di fare di Noi schiavi del Suriname un’edizione italiana.