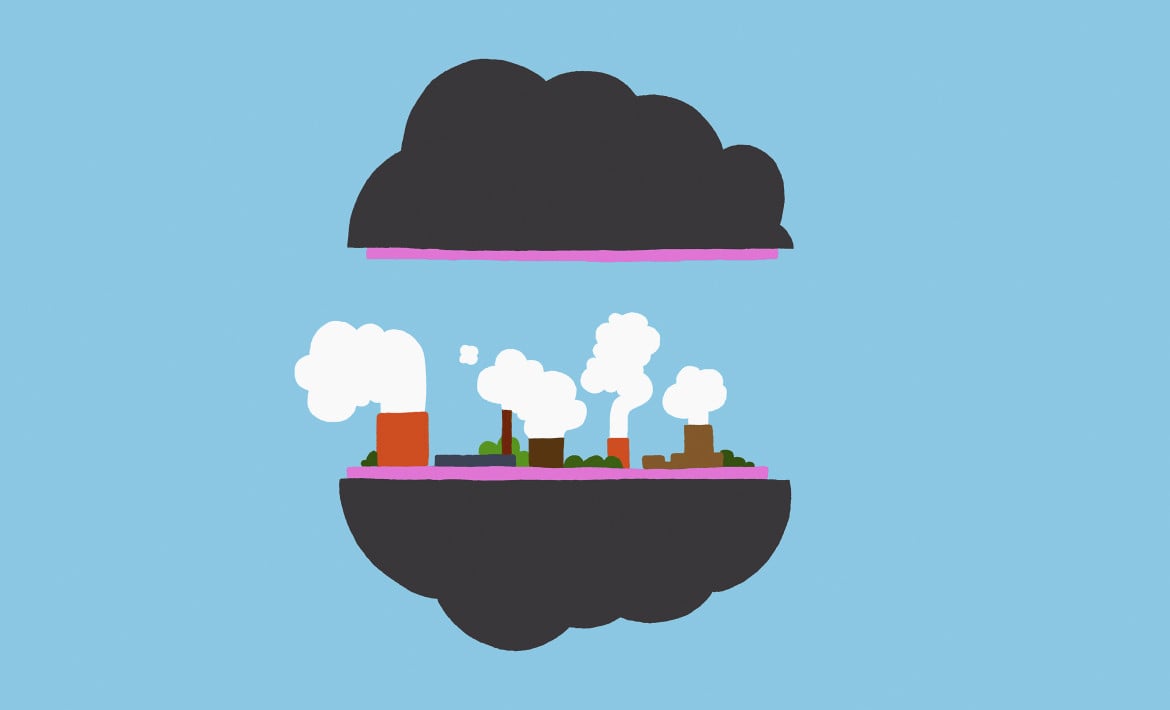Sembra un problema politico, ma è economico e come tale la politica prima o poi dovrà affrontarlo. Mentre si temono l’instabilità, il caos istituzionale e le elezioni anticipate, i problemi più profondi per l’Italia giungono dal versante economico-finanziario.
A fronte di una modesta crescita continentale potrebbe finire il periodo di supporto monetario della Banca centrale. E ancora prima che ciò accada pesano le fragilità strutturali non risolte in questo arco di tempo drogato dalla moneta facile.
La crescita prevista per il biennio 2017-18 ruota intorno all’1%, fatto salvo ulteriori ritorni di fiamma della crisi di origine geopolitica o locale.
La teoria suggerisce che attraverso la crescita economica si dovrebbe ripartire con produzioni, export, consumi, inflazione (quella strutturale, non dovuta solamente all’aumento dei prezzi di specifici settori particolarmente volatili come energia e agroalimentare), insomma un circolo virtuoso in grado di aumentare le entrate fiscali, ridurre il debito e persino stabilizzare l’incerto quadro del segmento bancario.
Negli ultimi due anni il costo del debito pubblico è stato insolitamente contenuto, eppure il debito ha continuato a salire sia in termini assoluti sia in rapporto al Pil. Gli investimenti in conto capitale si sono ridotti, la produttività resta eccezionalmente modesta, il tasso di innovazione delle imprese anche, inchiodando il secondo bastione industriale europeo su segmenti a bassa specializzazione e periferici nella catena del valore.
Ecco allora che l’establishment, recentemente tramite il presidente di Banca d’Italia Ignazio Visco, inneggia al Moloch della crescita economica e dell’austerità. La crescita prevista resta modesta e per renderla comunque adeguata si avanzano richieste di aumentare nuovamente il saldo primario (la differenza tra entrate e uscite statali, al netto degli interessi sul debito) e di immancabili riforme.
Quest’ultime sembrano una sorta di araba fenice dalla funzione taumaturgica ma in definitiva sono la somministrazione di ulteriori dosi di liberalizzazioni/privatizzazioni, deregolamentazione del mercato del lavoro, riduzione lineare e indiscriminata della spesa pubblica.
La crescita economica, poi, dovrebbe servire a far ripartire il sistema bancario nostrano, un sistema con bassa redditività e pieno di crediti deteriorati (a fine 2016 ancora pari a 350 miliardi). Per ora la stabilizzazione della crisi ha consentito di non fare aumentare ulteriormente la mole di questi crediti nei bilanci delle banche, ma non decolla la possibilità di crearne un effettivo mercato.
In poche parole, il sistema nel suo complesso non riesce a farsene carico e perciò periodicamente si torna a parlare di Bad Bank (un eufemismo per consentire il salvataggio pubblico di banche private) e torna sotto i riflettori l’estenuante trattativa tra autorità italiane ed europee per trovare una soluzione che in qualche misura aggiri le norme approvate sul bail-in (un complesso meccanismo dove a pagare almeno in prima battuta sarebbero azionisti e investitori privati dei singoli istituti).
Ecco allora che a sottolineare la difficile strada che ha di fronte l’Italia arriva l’ultimo rapporto dell’agenzia Standard&Poors, che lascia i titoli sovrani del Belpaese a un rating BBB-, cioè appena un gradino superiore alla categoria speculativa.
Nel pieno della crisi globale le agenzie di rating sono state accusate, non a torto, di essere corresponsabili della crisi, per la loro indulgenza nel definire titoli che si sono rivelati fortemente a rischio, ma dopo quello sconquasso la cautela con cui monitorizzano l’Italia appare più che giustificata.
Non è un problema di trame speculative, quanto di realismo nel giudicare le debolezze strutturali che stritolano l’Italia.