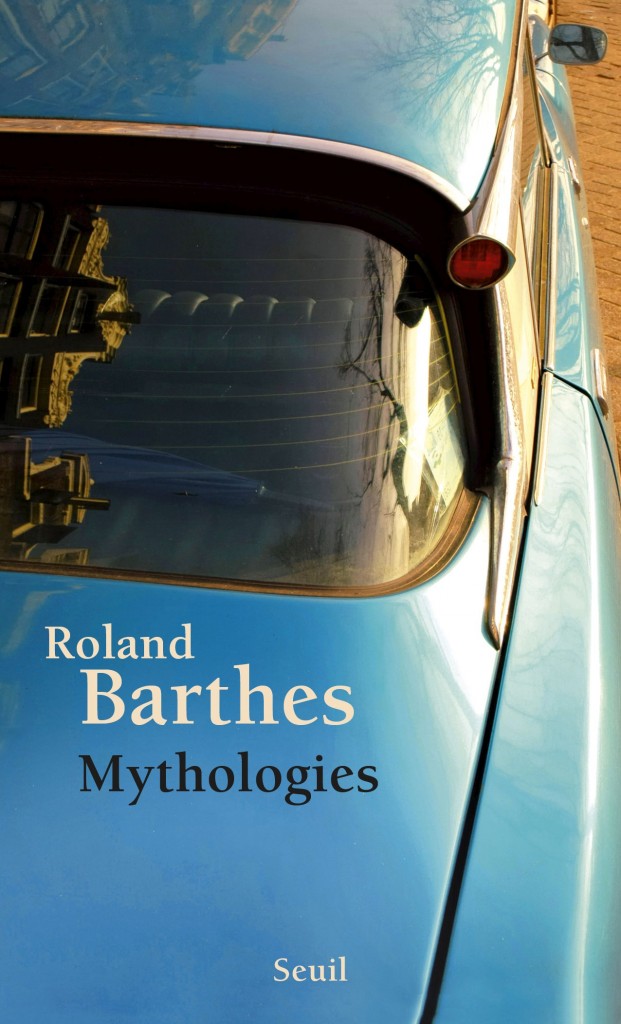Fitto com’è di riferimenti ai personaggi, agli ambienti editoriali, ai giornali e alle riviste che hanno animato la scena culturale francese, il libro, appena uscito, che Philippe Sollers ha dedicato a L’amitié de Roland Bathes (Seuil, pp. 170, euro 19,00) e che comprende anche un trentina di lettere e cartoline inedite dell’amico scomparso, è un libro molto parigino: propone un ritratto non solo e forse non tanto di Barthes, quanto di una lunga amicizia, o, per meglio dire, offre un ritratto di Barthes attraverso la lente del suo rapporto con Sollers. Ma, nonostante sia intriso di quello che lo stesso Barthes, in una delle missive, chiama il «veleno di Parigi», il volumetto ha il merito di sottolineare due aspetti della personalità e dell’opera di Barthes che oggi sembrano un po’ trascurati: la dimensione politica (quello che Sollers chiama il suo antifascismo) e la sorveglianza razionale, che fa di Berthes un erede della tradizione illuminista.
Per comprendere la profondità dell’antifascismo di Barthes, documentato fin da quando era giovanissimo (a diciannove anni, nel 1934, fondò insieme a compagni del Liceo Louis-le-Grand un gruppetto antifascista), basterebbe la sua famosa e discussa dichiarazione, secondo la quale «La lingua è fascista», «perché fascismo non è impedire di dire, è costringere a dire»; un’affermazione che riecheggia la concezione foucaultiana del potere e che soprattutto mostra quanto vaste, potenti e minacciose fossero ai suoi occhi le radici del fascismo. Né si può dimenticare con quanta serietà Barthes abbia letto e meditato Marx (c’è stato un momento, racconta il biografo, in cui loro due pensavano di essere gli unici in Francia, insieme a Althusser, a leggerlo). Del resto, nota ancora Sollers, fin dalle primissime opere (penso all’ancora oggi bellissimo Mythologies), Barthes vide che «la società mente» e studia «sistematicamente e molto concretamente il modo in cui la società si rappresenta», inscenando uno «spettacolo permanente di menzogne attraversato evidentemente dal denaro»; in questo senso, egli sarebbe stato il primo teorico della società dello spettacolo, anche se Debord non fa mai riferimento ai suoi testi.
La tensione politica, d’altra parte, non è mai disgiunta da quella lucidità d’analisi che gli derivava anche da Brecht: «Barthes è lo spirito dei lumi – scive Sollers –. È il più antioscurantista degli intellettuali o degli scrittori che ho potuto conoscere»: questo elogio può sembrare strano se si pensa a testi certo non facili come S/Z o i Frammenti, ma il fatto è che la chiarezza (la saphéneia o perspicuitas, una delle virtutes elocutionis dalla retorica classica) significa soltanto, notava per esempio Leopardi, la capacità di trasmettere al lettore quel che si pensa: se le idee che si intende comunicare sono difficili o complesse il testo non sarà affatto facile, ma non per questo sarà poco chiaro. Ora, la difficoltà nei testi del Barthes post-strutturalista deriva da qualcosa cui si riferisce egli stesso nella lettera (qui sotto tradotta) in cui elogia il testo di Sollers su Lautréamont dicendolo di una «chiarezza rischiarante» (clarté éclairante), non senza aggiungere che ci sono anche altri tipi di chiarezza (la chiarezza della lingua che costringe a dire, della lingua «fascista»): quel testo «è un testo, un tessuto in anastomosi completa con il tessuto di Lautréamont, che smuove infine la scrittura del commento (cioè che lo distrugge)».
Il Barthes post-strutturalista cerca appunto l’anastomosi elogiata nel saggio di Sollers, non si stanca cioè di metter(si) fuori (dal) gioco (del)l’opposizione linguaggio-metalinguaggio.
Lo testimonia un libro, uscito in traduzione la primavera scorsa, che non si raccomanderebbe mai abbastanza a chiunque si interessi di Barthes, il seminario del 1974-76 Il discorso amoroso (a cura di Augusto Ponzio, Mimesis, pp. 656, euo 28,00), in cui il tema viene ripetutamente proposto e indagato nella sua dimensione teorica, rimasta piuttosto implicita nel libro che scaturì dal seminario, i giustamente celebri Frammenti di un discorso amoroso: l’istanza metodologica che impone di distinguere tra linguaggio e metalinguaggio è fondamentale, ma proprio perché nessun linguaggio può sfuggire alla presa metalinguistica, non esiste nessun metalinguaggio che offra un ancoraggio sicuro.
In quegli anni, come si sa, la stessa esigenza teorica era proclamata, benché in modi diversissimi, anche da Lacan e da Derrida (Barthes parla talvolta di «decostruzione» del metalinguaggio), e tralasciando le caratteristiche che differenziano i tre studiosi, c’è almeno un aspetto del lavoro di Barthes che va messo in rilievo e che Porzio, non a caso il maggior studioso italiano di Bachtin, spiega, nell’introduzione al volume citato, ricorrendo alla categoria bachtiniana del discorso indiretto libero. Nel progressivo abbandono della distinzione tra il discorso interpretante e il discorso interpretato, «la parola riportata penetra nella parola riportante, la influenza, la contagia, retro-agendo su di essa, e dando luogo a un rapporto di interferenza massimo, fino al punto che non si può assolutamente parlare più di discorso e di meta-discorso».
In qualche modo, come è evidente, il rifiuto del metalinguaggio ha una valenza performativa (e non potrebbe essere diversamente) anche in Lacan e in Derrida, le cui scritture non sono affatto assimilabili agli stili tradizionali derivati dalla psicoanalisi o dalla filosofia.
Nel caso di Barthes, si direbbe, è più compiuto il trapasso dal critico-semiologo allo scrittore tout court, mentre la dimensione teorica sfuma e si stempera nel gusto, un po’ simile a quella «rage de nommer» che lo stesso Barthes rimprovera affettuosamente agli studiosi di retorica, per la brillante invenzione di nomi che mimano, forse un po’ parodiandola, la terminologia scientifico-filosofica; quel che non viene mai meno è però la chiara intelligenza che alimenta una delle più belle prose francesi degli ultimi cinquant’anni.