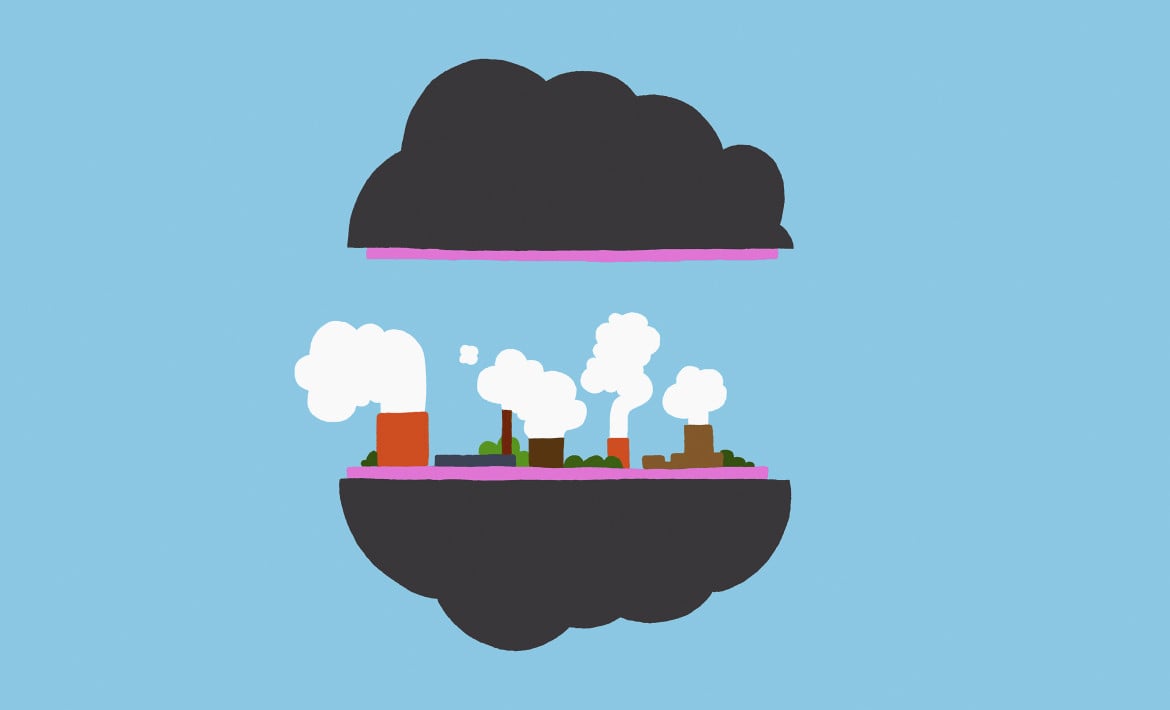La nuova legge elettorale – progettata come è per un esito di “governissimo” e di parlamentari “nominati” a immagine e somiglianza dei rispettivi leader – produrrà un addio all’alternanza, al riformismo, alla sinistra e allo stesso Pd (almeno per come era concepito nelle migliori intenzioni dei suoi fondatori). Sarà solo neocentrista la mediazione programmatica resa possibile dal cinismo trasformistico che si esprime in uno “scambio” che verte tutto su un’anticipazione delle elezioni.
Elezioni anticipate per soddisfare il narcisismo egotico di Renzi e Berlusconi (convinti di essere grandi artefici di vittorie elettorali e indifferenti al fatto che questa volta il beneficiario possa essere Grillo). Prova ne siano le anticipazioni del suo programma fornite da Renzi, dove – insieme all’ingiunzione a Padoan che la prossima finanziaria non si discosti e “sia in linea” con i suoi diktat e a continue, tanto velate quanto minacciose, allusioni a regolamenti di conti (tipo l’insistito «parliamoci chiaro», anche a proposito della complessa vicenda bancaria) – in cima a tutto viene posta «la vera scommessa di continuare a buttare giù la pressione fiscale», utilizzando a questo scopo «lo spazio del deficit» da strappare ulteriormente alla Commissione europea, dunque finanziando con debito spesa corrente (e non per investimenti).
Per Renzi la riedizione del sogno blairiano dello “sfondamento al centro” oggi si traduce nell’assunzione tout court del lessico e dei valori della destra. Così, però, da una parte si avvalora l’idea (tipicamente di destra) che le tasse sono un furto, un esproprio, un “mettere le mani nelle tasche dei cittadini” – parole che abbondavano e abbondano nel lessico di Berlusconi che ha legittimato moralmente chi si sente autorizzato ad evaderle -, dall’altra siamo ben lontani dal considerare le tasse un “contributo al bene comune” – parole del Catechismo sociale della Chiesa e della nostra Costituzione – perché il mezzo con cui reperire le risorse necessarie a finanziare da un lato una redistribuzione egualitaria per le famiglie, dall’altro strade, ferrovie, reti, scuole, ospedali, asili nido, riassetto idrogeologico, riqualificazione dei territori e delle città, Ricerca e Sviluppo e innovazione.
Nel momento in cui tutto il mondo si indigna per il dramma della disoccupazione invocando job, job, job, e Papa Francesco grida “lavoro per tutti”, Renzi affida le speranze di crescita al taglio delle tasse invece che a grandi piani di investimento e di creazione di lavoro aggiuntivo (visto che il Jobs Act non ha creato più lavoro di quanto le imprese non avrebbero naturalmente fatto e si è risolto in una colossale decontribuzione a danno delle finanze pubbliche e a vantaggio dei profitti e delle imprese).
Renzi riscopre, cioè – invece che l’ispirazione autentica del New Deal di Roosevelt e dei Piani del Lavoro – una forma di supply side economics (economia dal lato dell’offerta) in cui c’è ben poco spazio per gli investimenti pubblici e nessuno per la creazione diretta di lavoro, perché le misure a cui ci si affida sono benefici fiscali, flessibilizzazioni dei mercati del lavoro, liberalizzazioni, concorrenza, privatizzazioni, una forma di politica economica neoliberistica a cui concorre anche un lettura della rivoluzione tecnologica in corso come “guidata dall’offerta”, un’offerta che, lungi dal dover essere sollecitata o tanto meno indirizzata, ha bisogno solo di incontrare il suo consumo, per cui l’unica cosa che conta è dare incentivi indiretti alle imprese e potere d’acquisto (cioè tagli fiscali e trasferimenti monetari) ai consumatori.
Il punto è che nel delicatissimo crinale in cui si trovano oggi l’Europa e l’Italia l’urgenza non è un taglio delle tasse inevitabilmente finanziato – se finanziato correttamente – con una decurtazione della spesa pubblica (per esempio in sanità o in Università e ricerca, già tanto provate), ma un rilancio degli investimenti pubblici, e pertanto della spesa relativa, volto a soddisfare i grandi bisogni inevasi del paese e a creare lavoro, specie per giovani e donne.
Qui va riscoperto Keynes e non per contrabbandare come keynesiano lo strappare “margini di flessibilità” all’”austerità” europea, senza rimettere drasticamente in discussione la logica del fiscal compact, di cui è peraltro vicina (fine 2017) la scadenza della necessaria rinegoziazione.
Si tratta, infatti, di fare cose che fuoriescono dall’ordinario:
1) identificare fini e valori per dare vita a un nuovo modello di sviluppo (l’opposto dell’assumere gli esiti del mercato come un dogma naturale immodificabile e, conseguentemente, del limitarsi a compensare i perdenti e chi “resta fuori dal processo di innovazione”, come dice Renzi).
2) Dirigere l’innovazione orientandola verso bisogni e fini sociali (ricerca di base, rigenerazione delle città, riqualificazione dei territori, ambiente, salute, scuola, ecc.), l’opposto della “neutralità” e dell’ostilità per l’intervento pubblico (in nome del terrore del “dirigismo”) rivendicate dai consiglieri di Renzi.
3) Rilanciare l’obiettivo della “piena e buona occupazione” rovesciando la logica: invece che affrontare ex post “i costi della perdita di impiego” (secondo il suggerimento di Renzi), fare ex ante degli investimenti pubblici e della creazione di lavoro il motore di una crescita riqualificata.
4) Considerare lo Stato come grande soggetto progettuale e come Employer of last resort, invece che il “perimetro” da assottigliare e depotenziare ipostatizzato dalle politiche di privatizzazione e di esternalizzazione care ai tardoblairiani odierni.
Sono queste le finalità a cui ci richiama Tony Atkinson invocando “proposte più radicali” (more radical proposals). Nel suo ultimo, bellissimo libro (Inequality) il grande economista da poco scomparso denuncia l’insufficienza quando non la fallacia delle misure standard (quali tagli delle tasse, intensificazione della concorrenza, maggiore flessibilità del lavoro, privatizzazioni).
Il primo tabù che egli infrange è che la globalizzazione impedisca di mantenere strutture fiscali progressive e imponga che le aliquote marginali siano sempre inferiori al 50%, proponendo che il ripristino della progressività – violata dalle politiche neoliberiste a tutto vantaggio dei ricchi – preveda per i benestanti aliquote massime del 55 e perfino del 65%. Ed escogita tutta una serie di proposte “radicali”, tra cui gravitare sull’obiettivo della piena occupazione – eluso dalla maggior parte dei paesi Ocse dagli anni ’70 – facendo sì che i governi offrano anche “lavoro pubblico garantito”.