L’incontro con David Harvey è avvenuto a Bologna, dove il geografo marxista statunitense è stato invitato dalla «Academy of Global Humanities and Critical Theory» quale relatore di due incontri: un dialogo critico con Sandro Mezzadra e la presentazione di una relazione chiamata «Sovranità, movimenti sociali e il diritto alla città».
Iniziamo dalle origini, col tuo arrivo a Baltimora negli anni Sessanta. Come decidi di adottare Marx e la città quali imprescindibili tasselli della tua analisi?
Sono andato a Baltimora interessato alle lotte sociali che erano in corso nelle zone urbane degli Stati Uniti, mentre era in pieno svolgimento l’Urban crisis. Stavano accadendo anche molte altre cose: il movimento conto la guerra, il movimento per i diritti civili. Rimasi coinvolto in quanto stava avvenendo a Baltimora, in particolare nel 1968 dopo l’assassinio di M. L. King: un’insurrezione della città e una vera occupazione militare. Volevo comprendere cosa aveva portato a questa «eruzione». La maggior parte dei discorsi delle scienze sociali non funzionavano, quindi andai alla ricerca di altri framework interpretativi, iniziando a leggere le opere di Karl Marx. Scoprii che alcuni suoi concetti e categorie erano utili per spiegare la situazione. Scrissi numerosi rapporti di ricerca con un linguaggio marxista presentandoli a persone della finanza o delle istituzioni. Tutti mi dicevano che erano lavori eccellenti (perché non sapevano che venivano da Marx!). Fu lì che capii che Marx aveva ragione ed elaborai un approccio marxista all’urbanizzazione, cosa per nulla comune al tempo (a parte Henri Lefebrve, che non conoscevo, e Manuel Castells che incontrai nel 1967). Ciò mi ha portato alla pubblicazione del mio primo libro, Social Justice and the City.
Citi Castells. C’è una sorta di parallelismo – anche se segnato da nette e molteplici divergenze – tra i vostri percorsi teorici evidenziato anche dai numerosi libri sugli stessi temi che avete pubblicato in contemporanea. Quali sono le convergenze e le differenze del vostro approccio?
Ero molto vicino a lui durante gli anni Settanta, ma negli Ottanta Manuel Castells ha progressivamente abbandonato la prospettiva marxista, probabilmente per il lavoro politico che faceva col Partito Socialista. Ritengo che Castells abbia un’interpretazione di Marx piuttosto limitata, relativa alle sole forze produttive e molto legata al dogma dei Partiti comunisti europei. Nella mia prospettiva, invece, ciò che accade nella produzione debba costantemente essere messo in parallelo con l’analisi di classe e con le dinamiche della riproduzione sociale.
In base a questa lettura dell’opera marxiana, l’urbano è il quadro all’interno del quale i «vettori» che ho evidenziato – propduzione e riproduzione – possono essere meglio interpretati congiuntamente. Cerco di tenere assieme quella che potremmo definire come la «totalità» marxiana, mentre la posizione di Castells è esclusivamente produttivista.
Negli anni Ottanta hai sviluppato un’analisi critica del neoliberalismo. Potresti mettere questo tema in relazione alle mutazioni dello Stato nel suo rapporto con la città?
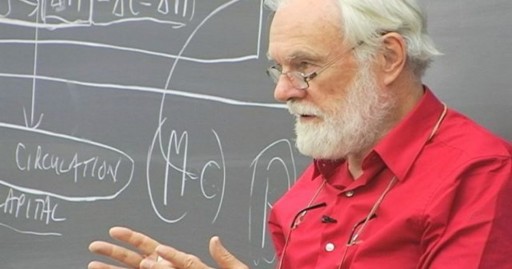
Col progressivo declino del welfare state lo Stato ha scaricato i problemi sociali sulle città dicendo: «Non è un mio problema, risolvetevela voi». Le municipalità hanno dovuto cominciare a trovare le risorse economiche in maniera autonoma: è il passaggio da una forma manageriale del governo locale a una governance urbana di tipo imprenditoriale. Il tema dello «sviluppo» urbano è divenuto così centrale, con un peso sempre più rilevante acquisto dai developer, unici soggetti a garantire un gettito fiscale per il bilancio delle città. Ciò ha prodotto uno spostamento netto delle risorse verso le corporation. A quel tempo, alcuni studiosi e esponenti politici hanno sostenuto che si poteva costruire una città in cui i bisogni sociali sarebbero stati affrontati col gettito proveniente dallo sviluppo urbano.
L’ex-sindaco della Grande Mela Michael Bloomberg diceva che solo le industrie che versavano contributi alla città di New York sarebbero potute rimanere in città. Ma il retro-pensiero di tutto ciò è che la stessa regola sarebbe dovuta valere anche per le persone, e quel modello si è realizzato, come abbiamo visto nell’incendio alla Greenfell Tower di Londra, l’emblema di come un municipio ricco tratta e considera i poveri.
Nei movimenti sociali c’è un confronto sul che fare a partire da diverse esperienze ed elaborazioni teoriche, dagli approcci legati all’«assemblea» all’esperienza del Rojava fino al riconsiderare il ruolo dello Stato…
Lo Stato ha un ruolo davvero importante in qualsiasi tipo di trasformazione radicale dell’ordine sociale. Non dobbiamo essere Stato-fobici. Allo stesso tempo se si assume una postura Stato-centrica ci si allontana dalla possibilità di realizzare effettivamente una trasformazione radicale. L’unica soluzione è che si costituiscano una serie di poteri al di fuori dello Stato, che siano però in grado di intrattenere una relazione forte con esso. Ma senza questo «fuori» dallo Stato non ci sono possibilità. Si pensi a Syriza e il suo progressivo identificarsi col potere dello Stato, che ha prodotto un drastico esaurirsi dei poteri dal basso. Anche in Spagna credo che Podemos sia in qualche modo di fronte allo stesso dilemma.
Un’organizzazione politica forte non può che svilupparsi assemblando differenti strutture e molteplici livelli, cosa che in qualche misura si sta determinando in Rojava. Credo sia necessario bilanciare il timore di rapportarsi allo Stato nazionale, proprio nel momento in cui gli Stati sono sempre più dominati dal potere finanziario che lavora di continuo contro i movimenti sociali.
Come ti poni in proposito rispetto a quello che hai definito «Partito di Wall Street» per indicare uno Stato sempre più colonizzato dalla finanza?
Il «Partito di Wall Street» è stato sfidato dal movimento che si è prodotto attorno alla candidatura di Bernie Sanders, anche se da quando ha accettato i vincoli della politica corrente l’emergenza che si era prodotta attorno alla sua figura è rientrata. Il punto però è che bisogna chiedersi perché il «Partito di Wall Street» controlla il Congresso.
I municipi possono essere luoghi per una possibile rivalsa di una politica di sinistra, anche se ovviamente esistono altri tipi di poteri che contrastano questa possibilità. Penso in primo luogo ai developer e alle loro lobby. È in corso una battaglia in molte città. Per esempio a New York c’è un sindaco molto di sinistra, ma di fatto non è in grado di contenere il potere delle lobby del real estate.
Pare che la relazione tra urbano e globale sia ormai costitutiva. Come interagiscono queste due dimensioni soprattutto in una prospettiva politica?
Siamo di fronte a una configurazione di poteri politici locali che possono essere giocati nei termini di una mobilitazione di massa. L’esempio più recente: il 16 febbraio 2003 quando milioni di persone scesero in strada contro la guerra. Un movimento globale.
Fenomeni del genere accadono anche a livello nazionale, come è successo in Turchia quando dopo la sollevazione di Istanbul moltissime altre città si sono mobilitate. Quando accadono cose simili non si può far finta di nulla, o pensare che non ci sia una qualche dinamica in atto nel profondo della società. Cosa sarebbe successo nel 2003 se tutte quelle persone avessero detto: «Basta, questa guerra non la farete, noi rimaniamo per strada finché non capitolerete». Credo ci sia una concreta possibilità politica a livello metropolitano, prché l’«effetto contagio» può davvero essere molto forte e veloce. La domanda difficile è: quale politica è possibile costruire su tutto ciò?
Da tempo sostieni che il modo nel quale organizziamo le città dev’essere legato al tipo di persone che vorremmo essere e che dobbiamo chiederci se le città debbano essere spazi per l’investimento o luoghi per l’abitare…
Sarebbe decisivo rivitalizzare l’idea di cittadinanza nei termini della città, un qualcosa che si è perso. Allo stesso tempo sarebbe necessario riuscire a esercitare una qualche forma di influenza sugli investimenti urbani chiedendosi a quali interessi rispondono. Invece si sta riproducendo ovunque il modello della gated community. Regan disse a Gorbačëv «Abbatti quel muro!», ma avrebbe dovuto dirlo ai costruttori americani dei suburb, dei veri e proprio costruttori di muri.

