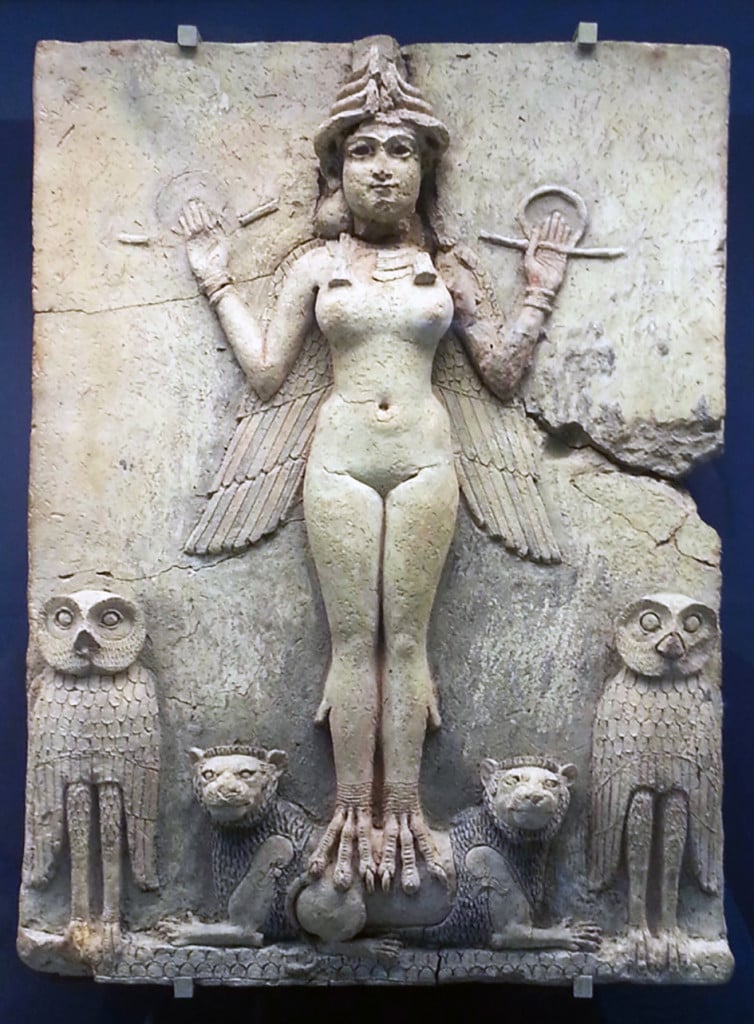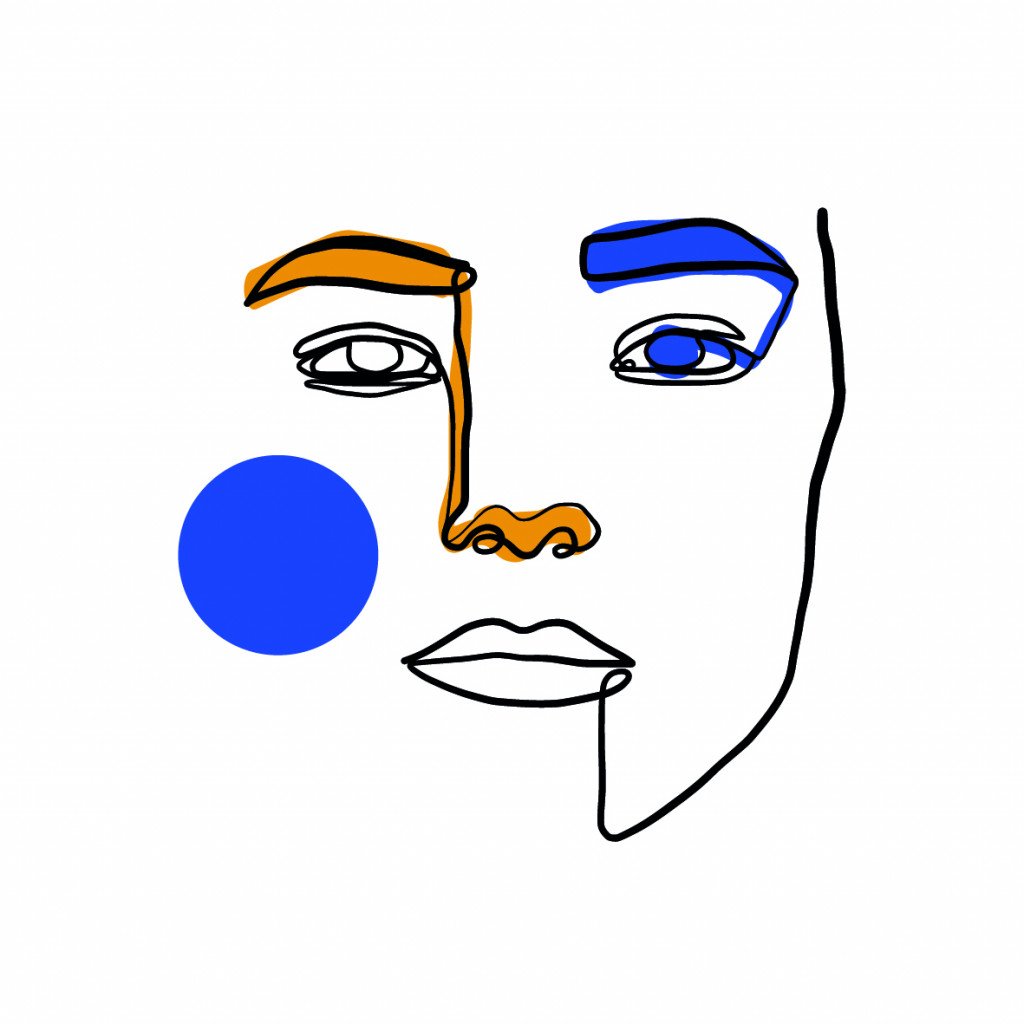La città nasce come centro di aggregazione umana, nei luoghi più favorevoli alla prosperità, alla soddisfazione dei bisogni primari. Se questo è il presupposto dal quale si diparte tutta la storia delle comunità cittadine, nell’evoluzione dei centri abitati entra in gioco un processo di adattamento reciproco che porta all’integrazione e all’interazione di individui socialmente organizzati.
Nei secoli si vanno strutturando i quartieri secondo le attività, le istituzioni, i poteri, in modo tale che le caratteristiche della composizione sociale determinino separazioni tra classi, proprio laddove si erano formati gruppi disomogenei in coesistenza ravvicinata.
Si avverte, quindi, il bisogno di un mezzo di controllo dell’ordine e dell’equilibrio dello spazio urbano, un meccanismo attraverso il quale si possa pianificare la trasformazione del territorio. Con l’adozione dei primi strumenti urbanistici si tenta di programmare l’assetto planimetrico e il destino della città. La farraginosità dell’iter di approvazione dei piani ne impedisce, però, l’attuazione in tempi coerenti con lo sviluppo e la crescita del costruito. La rapidità dei cambiamenti che sfuggono alla gestione centralizzata provoca scompensi e disordine. L’urbanistica, insomma, fallisce, favorendo, di fatto, la proliferazione di costruzioni abusive, edificate in ordine sparso, senza una logica distribuzione degli spazi e in assenza di infrastrutture.
La città collassa, il potere si piega alla corruzione, mentre architetti e urbanisti si esercitano con i grandi esperimenti di ghettizzazione della vita urbana. Sorgono le mega aree industrializzate e, attorno, agglomerati spogli di qualsiasi elemento di attrazione sociale. Si occupano le aree periferiche con insediamenti ad alta densità abitativa e pessima qualità edilizia. Si perde il senso della democrazia; le città, specialmente le metropoli, si fanno mostruose, prive di identità, riconoscibili soltanto attraverso le quinte dei centri storici, almeno di quelli correttamente conservati.
Il paesaggio, tutto il paesaggio urbano, risente inevitabilmente di quel laisser-faire colpevole avverso il quale la collettività non è interessata a reagire, poiché l’iniziativa privata prende il sopravvento modificando il mercato immobiliare e condizionando le scelte politiche, il cui interesse primario è volto a generare consenso fine a se stesso. Si assiste, perciò, da un verso alla produzione di strumenti urbanistici sempre più raffinati e perfezionati, dall’altro all’impotenza negligente dell’autorità nel contrastare il processo di appropriazione da parte dei cittadini del patrimonio anche comune.
Dal laisser-faire al degrado il passo è brevissimo. La città dovrebbe vivere assicurando almeno i servizi essenziali, che garantiscano livelli di relazione sociale differenziati e soddisfacenti negli spazi pensati: nelle piazze, nei parchi, nelle botteghe, nei campi dello sport, nei bar con i tavolini, sotto il campanile. Le diverse piccole unità di vicinato dovrebbero essere incentivate alla coesione dalla frequentazione dei luoghi socialmente utili, per la formazione di un “noi” che costituisca l’aspetto etico ed ecologico della città.
Al contrario, la morte dell’anima collettiva di un quartiere comporta disgregazione sociale, riduzione drastica delle relazioni umane, annientamento della naturale tendenza alla comunicazione, sostituita ormai da una fisionomia artificiale di convivenza asfittica, improduttiva. I non-luoghi omologati, quali i centri commerciali, gli ipermercati, rappresentano esattamente le sedi ideali per la distruzione dei valori fondamentali della sincronia civica. Non a caso si registra un aumento della dispersione scolastica, insieme alla cancellazione pressoché totale delle attività spontanee proprie dell’infanzia e dell’adolescenza e specialmente di quelle all’aperto.
In questa realtà, saltati i punti di riferimento, incoraggiato il consumismo e il consumo del territorio, accresciute le distanze tra sedi di lavoro e abitazioni, si è di fatto affermata una struttura urbana multicellulare, concentrata per lo più in edifici verticali all’interno dei quali ogni individuo, ogni nucleo familiare si è munito di sistemi di protezione, isolandosi dal contesto sociale e, al contempo, provocando la frantumazione dei rapporti interpersonali. Tale condizione, nei quartieri maggiormente disagiati, insieme con la povertà, esaltata dal disinteresse delle istituzioni, dall’assenza di azioni incisive per il recupero della dignità umana, è stata sfruttata anche dalla criminalità organizzata per territorializzare la propria affermazione.
All’inizio del 2020, col diffondersi del virus pandemico, i parametri vitali delle città, quasi come avvenuto per i parametri vitali degli esseri umani, sono stati sottoposti a prove estremamente dolorose. Non a caso negli habitat particolarmente fertili, già predisposti per conformazione alla coltura di malesseri collettivi, la carica virale ha attecchito con ferocia, provocando una vera e propria distruzione di massa. La popolazione è stata letteralmente decimata proprio in quelle aree dell’inurbamento industriale, laddove l’esistenza è costretta entro limiti fisici tali da determinare una sovrapposizione di strutture incoerenti, prive dei requisiti minimi per assicurare uno standard di vita individuale e sociale accettabile.
I quartieri sono stati riscoperti, come è stato paradossalmente valorizzato il significato della strada, improvvisamente deserta, e di quei luoghi di aggregazione a lungo trascurati.
Ogni singola abitudine della vita cittadina è stata modificata, generazioni diverse si sono ritrovate a condividere spazi che, in molte case, erano usati a turno nelle diverse ore della giornata. Lo spirito di collettività si è concentrato sui social, utilizzati come agorà virtuale nella quale il distanziamento non ha senso, poiché l’abbraccio si concretizza nella semplicissima scelta di una faccetta rassicurante.
Lo stravolgimento della condotta civica non può non avere riscontro nel tessuto urbano, che, offeso senza pentimenti sin dagli ultimi decenni del secolo scorso, attende di essere riscoperto quale valore umano. Le scelte urbanistiche, se non fatte discendere dall’analisi puntuale delle attività umane, non potranno mai raggiungere altro obiettivo che si discosti dalla mera rappresentazione grafica, spesso, come si è detto, dettata dalla speculazione e dalla corruzione.
Non c’è più tempo per rimediare ai danni subiti dalle città o, almeno, per limitarli. L’essere umano probabilmente non si adatterà alla convivenza con le pandemie, non a breve. Sono, quindi, necessari interventi immediati, da attuarsi mediante una sorta di rianimazione della città. L’esperienza di Nicolini a Roma, la sua audacia nell’interrompere un sistema e rinnovarlo attraverso la capillarizzazione della cultura, resa fruibile a chiunque, ha segnato una rivoluzione intellettuale nella visione della città.
Sembra ormai indispensabile dare la possibilità a portatori di idee creative di interagire con la politica, non soltanto con la partecipazione alle scelte, ma anche con l’apporto di novità concettuali per il superamento dei blocchi burocratici. Per sostenere la gestione della pandemia, così come per ricostruire il ponte di Genova, ci si è dovuti interrogare sulla funzione della politica e sull’uso quotidiano degli attuali strumenti istituzionali, del tutto inadeguati rispetto all’emergenza.
Si tratta, in sostanza, di identificare i servizi di primaria necessità e di velocizzare le procedure per dare risposta non più al disagio meramente fisico, quanto piuttosto al desiderio, alle aspirazioni, al benessere, che, se non tenuti nella dovuta considerazione, producono distrazione e la distrazione può essere altamente rischiosa.
Gli esseri umani fuggono dalla monotonia, dalla clausura, come il lockdown dimostra ampiamente. Scompensi, malessere sociale, pressione sociale, uniformità, grigiore, pesano sugli individui fino a determinare violenza: i ménage sottoposti alle restrizioni della pandemia hanno fatto assumere atteggiamenti di rifiuto collettivo verso la città ed esasperato tensioni precedenti. Un indicatore è rappresentato dalla domanda immobiliare che già si va caratterizzando nella ricerca di abitazioni dotate di spazi esterni.
Il rischio più grave è di scivolare nella spersonalizzazione delle città, il che potrebbe prestare il fianco a modelli di gestione autarchica del potere.
Insomma, per dirla con Mumford: «La funzione principale di una città è di trasformare il potere in strutture, l’energia in cultura, elementi morti in simboli viventi di arte, e la riproduzione biologica in creatività sociale».
È ora.
Caterina Ferraro Pelle, architetta, è specializzata in restauro di monumenti e autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico. È impegnata nella pubblica amministrazione a Roma come dirigente.