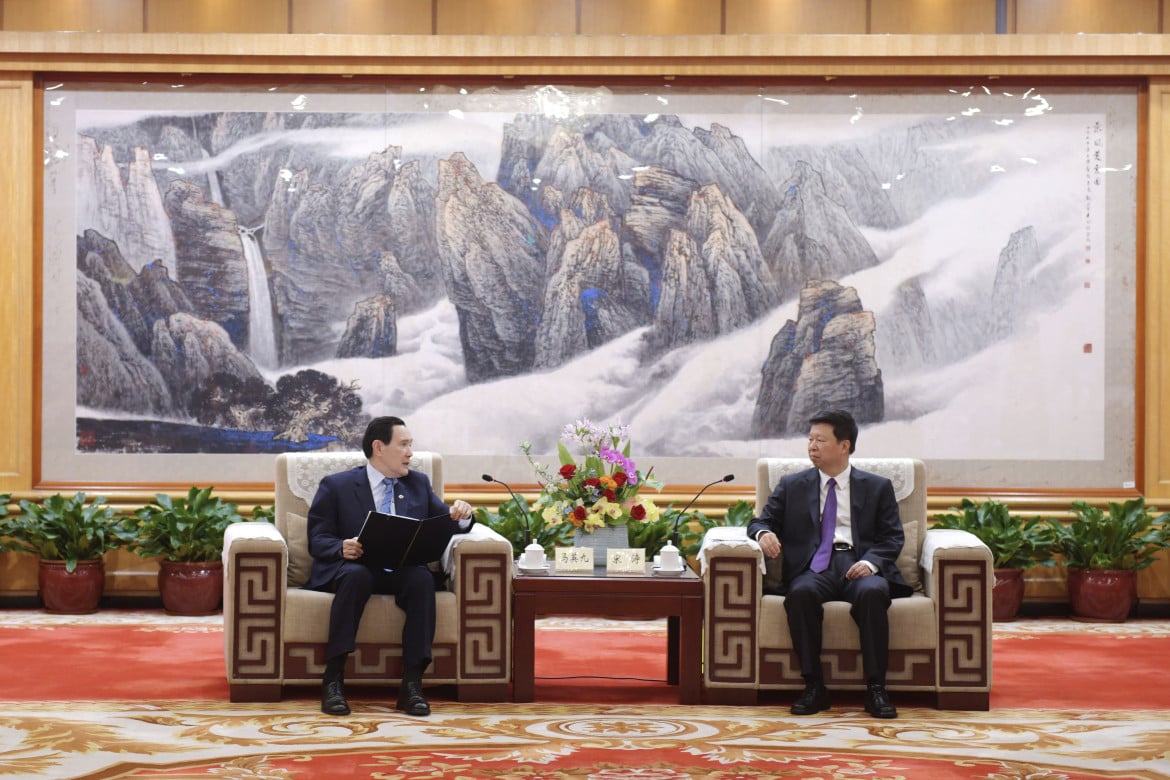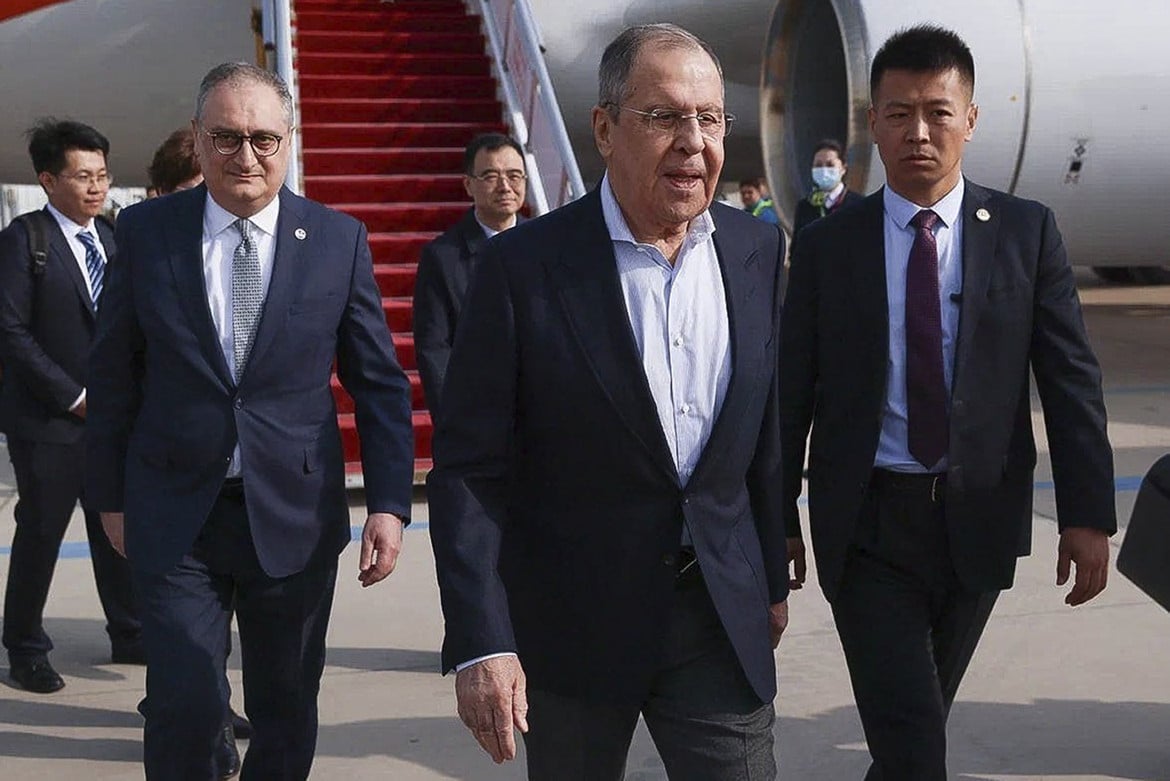Lo scorso 5 agosto, Hong Kong si è fermata per far posto allo sciopero generale più massiccio degli ultimi cinquant’anni. L’esperimento potrebbe presto venire replicato, se il “referendum” indetto per il 20 giugno da una ventina di associazioni sindacali, il partito di Joshua Wong, Demosisto, e l’Hong Kong Secondary School Action Platform, dovesse dare esito positivo. Un’alleanza tra studenti e sindacati non è esattamente l’alchimia più scontata per la mecca del capitalismo deregolato, dove la contrattazione collettiva per motivi politici è considerata illegale. Ma, a un anno di distanza dall’inizio delle proteste anti-governative, la necessità di rianimare il movimento democratico, stremato dai mesi di guerriglia, sta spingendo la popolazione verso nuove forme di resistenza. E il mondo del lavoro è in prima linea.
La recessione economica – aggravata dalle misure anti-Covid – ha fatto schizzare il tasso di disoccupazione al 5,9%, peggio del livello registrato durante la crisi finanziaria del 2009. Turismo e vendite retail sono in caduta libera. A ciò si aggiungono le pressioni politiche a cui sono sottoposti i dipendenti di multinazionali e aziende locali, come dimostra l’ondata di licenziamenti che ha travolto la Cathay Pacific durante le proteste dello scorso anno. L’insoddisfazione per come il governo ha gestito le fasi iniziali dell’epidemia ha consacrato l’ingresso dell’astensionismo collettivo dal lavoro nel movimento di disobbedienza civile. A febbraio, uno sciopero degli operatori sanitari ha costretto le autorità a chiudere parzialmente il confine con la Cina. Prima incoraggiante vittoria per un movimento che include un numero sempre maggiore di impiegati statali, imbarazzando l’amministrazione di Carrie Lam,
Era dal 2013, quando centinaia di portuali incrociarono le braccia per 40 giorni, che una lotta sindacale non otteneva tanta visibilità mediatica. Stavolta le ripercussioni si preannunciano anche più incisive e di lunga durata grazie alla nascita di nuove forme di associazionismo professionale.
Se il 2019 si era concluso con l’istituzione di 25 sindacati, quasi il doppio dei 13 registrati nel 2018, a metà marzo ne erano stati approvati addirittura oltre 100 degli 1700 ad aver fatto domanda dallo scorso giugno, pari a un incremento annuo delle richieste del 100%. Si tratta di nuove realtà che abbracciano trasversalmente una vasta gamma di settori, dall’alberghiero all’IT. Con circa 20mila membri, la Hospital Authority Employees Alliance, promotrice dello sciopero di febbraio, rappresenta uno degli esperimenti meglio riusciti. C’è chi parla già di una vera svolta per la difesa dei diritti dei lavoratori. Laddove un tempo le associazioni sindacali si limitavano a proteggere gli interessi professionali ed economici degli affiliati, il malcontento nei confronti del governo ha riconsegnato al movimento solidaristico tra lavoratori inedite connotazioni politiche. Per la prima volta il fronte pro-democrazia rischia di rubare la scena alle forze conservatrici rappresentate dalla filocinese Federation of Trade Unions (HKFTU), l’alleanza – che riunisce oltre 250 enti – nata al tempo degli scioperi di massa fomentati dalla Cina comunista nel 1967 e repressi violentemente dalla polizia hongkonghese.
Non è un cambiamento da poco. L’emergere di sindacati filo-democratici potrebbe persino influire sulla composizione della commissione elettorale – che riserva 60 seggi alle categorie professionali – incaricata di eleggere il prossimo chief executive nel 2022.
Come spiega il ricercatore e attivista Leung Po-lung in “Hong Kong Political Strikes: a brief history”, da quando nel 1844 – appena due anni dopo l’occupazione britannica – i coolies si resero protagonisti del primo sciopero ella storia di Hong Kong, i rapporti con la mainland sono rimasti una costante nel corso delle successive insurrezioni per la riaffermazione dei diritti dei lavoratori. Talvolta assumendo coloriture anti-imperialiste, altre volte in aperta contestazione alle politiche discriminatorie del governo coloniale, la Cina continentale ha sostenuto i lavoratori nelle contrattazioni con gli invasori, accogliendo i migranti di ritorno nei periodi di caos fino a quando la situazione politica interna lo ha permesso. Secondo Leung, è proprio in questi anni che il governo di Hong Kong si è dotato di alcuni strumenti ancora utilizzati per reprimere le proteste, come l’Emergency Regulations Ordinance introdotta nel 1922 per sedare lo sciopero dei marinai e che Carrie Lam ha minacciato di utilizzare durante gli scontri dello scorso anno per introdurre la legge marziale.
Oggi però la Cina non è più una sponda amica. Controbilanciando l’HKFTU, un’altra coalizione – la Confederation of Trade Unions – rispecchia gli ideali democratici dei sindacati generati dal ventre delle proteste contro l’ingerenza cinese. “Il diritto all’organizzazione sindacale è in pericolo”, recita un comunicato pubblicato sul sito della Confederazione, commentando l’annuncio dell’introduzione imminente di una legge antisedizione con cui Pechino potrà imbavagliare le voci più scomode.
Secondo quanto ci spiega Chan King Chin, professore di sociologia presso la City University of Hong Kong, il fronte filocinese sta cercando di boicottare la nascita di organizzazioni rivali, agevolando le procedure burocratiche dei sindacati vicini alla mainland. Non solo. La stretta sulla società civile e la brusca frenata dell’economia potrebbero smorzare l’entusiasmo sul nascere. La domanda sorge spontanea: con la disoccupazione in costante crescita, quanti saranno ancora disposti a rischiare il proprio posto di lavoro?