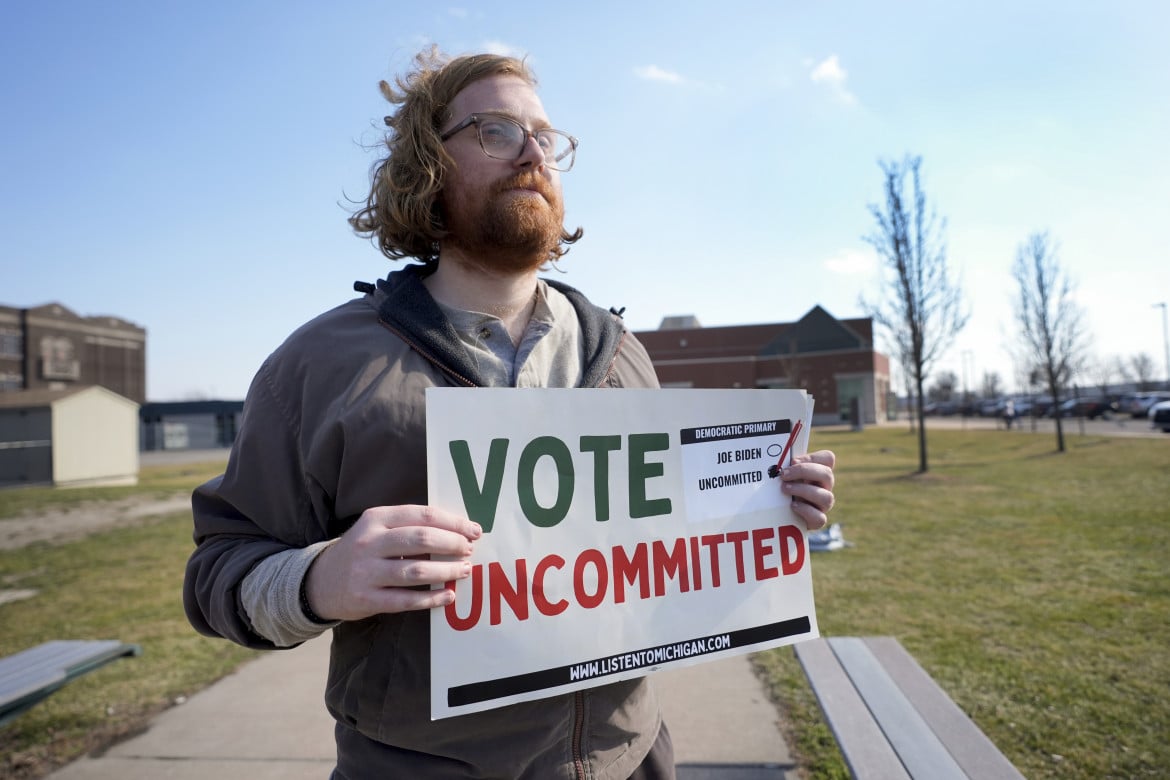Le ultime primarie (manca solo da formalizzare il voto nel distretto federale, a Washington, la prossima settimana) si sono tenute dopo l’annuncio della vincitrice da parte della Associated Press, ultima irregolarità di queste anomale elezioni presidenziali. La dichiarazione preventiva della vittoria di Clinton in base ad un sondaggio dei «super delegati» effettuato dalla Ap poche ore prima dell’apertura dei seggi e ripreso dai maggiori organi di stampa, ha provocato una dura reazione da parte di Bernie Sanders.
Tecnicamente nessuno dei due candidati ha raggiunto il numero necessario di delegati eletti dal popolo, ha tenuto a precisare il senatore del Vermont. Clinton se ne è assicurati 1.812 contro i 1.521 di Sanders. La soglia richiesta per la candidatura (2.383) verrà determinata dalle preferenza dei «superdelegati» designati dal partito che hanno facoltà di esprimerla durante al convention.
Il 90% di questi avrebbero espresso fedeltà alla Clinton, ma dato che il voto effettivo avverrà a Philadelphia, Sanders chiede di perorare la sua causa in quella sede, facendo leva sui sondaggi che lo vedrebbero più efficace della rivale nel confronto diretto con Trump, in virtù del numero di giovani e nuovi elettori che ha mobilitato. Da parte della corrente Sanders l’annuncio preventivo di vittoria, alla vigilia del voto in California e New Jersey, è stato percepito come un maldestro tentativo di soppressione del voto e la conferma di una sistema calibrato per favorire la front runner.
Clinton da canto suo ricorda che nel 2008 alla fine delle primarie, lei era distaccata da Obama di appena una sessantina di delegati (e aveva vinto nel voto popolare) ma ammise la sconfitta e si mise a lavorare per l’elezione del proprio avversario. È quello che chiede ora a Sanders. È vero tuttavia che quella attuale del partito è una divisione più fisiologica fra sinistra e moderati che non quella fra Obama e Clinton – più legata alle personalità dei rispettivi candidati. Oggi, affermano i sandersiani, i democratici si trovano davanti ad una fondamentale scelta politica rispetto alla voragine sociale fra classi subalterne e nuova oligarchia, una risposta di sinistra alle aberrazioni del tardo capitalismo. Alla fine è molto probabile che la spunti Hillary. Si profila dunque una campagna presidenziale che esprime le tensioni sociali del presente: una gara fra una candidata neoliberista e un nazional-populista fautore di un antiglobalismo viscerale di destra, strettamente imparentato con i neo nazionalismi xenofobi europei.
L’ascesa di Trump è sicuramente destinata a rimanere negli annali come un indice della profonda instabilità politica che attraversa l’occidente devastato da globalizzazione avanzata e dall’egemonia finanziaria. In questo quadro gli elettori progressisti saranno probabilmente chiamati, anche in America, ad esprimere controvoglia un voto strategico fra il meno peggio di due candidati imperfetti. O meglio, la candidata del capitalismo «moderato» e del continuato egemonismo americano ed un imprevedibile neo fascista. Molto dipenderà insomma dalla capacità della nuova sinistra – e dei molti giovani mobilitati da Sanders – di confluire pragmaticamente nei clintoniani per bloccare il nazionalismo fascistoide di Trump, un rigurgito post ideologico che fa perno sulla strumentalizzazione e la paura di un’America bianca che intravede il tramonto.
E sembra che già dalle prime battute una delle armi più efficaci contro Trump sarà l’escalation delle sue stesse esternazioni. È il caso della diatriba che alimenta in questi giorni contro il giudice federale che lo ha rinviato a giudizio per una delle numerose cause legali in cui è coinvolto. Trump ha chiesto che il magistrato Gonzalo Curiel dell’Indiana venga squalificato in quanto «messicano» (è figlio di genitori immigrati), allargando poi il concetto a giudici musulmani ed eventualmente magistrate donna – in quanto appartenenti a gruppi che potrebbero serbargli rancore. In un sol colpo quindi una spallata ad una serie di concetti cardine del paese: il protocollo multietnico, il sistema giudiziario e la stessa fondamentale mitopoiesi del «melting pot», tale da aver provocato profondo imbarazzo fra gli stessi repubblicani. Paul Ryan, leader della camera e del partito è stato costretto a sconfessare «l’espressione classica di razzismo», mentre nella frase successiva ha ribadito il sostegno a Trump per una «generale affinità ideologica». Le escandescenze del capo intanto hanno semmai rafforzato la convinzione del suo zoccolo duro – indice della tossica normalizzazione del pregiudizio che ha già sdoganato. Nel frattempo voci dalla casa Bianca indicano che Obama, rimasto finora fuori dalla mischia, starebbe per sciogliere le riserve e scendere infine in campagna, presumibilmente a favore dell’antica rivale. Il paradosso è che una vittoria di una Hillary vicina ai massimi sistemi d Washington e Wall Street e oggetto di un odio viscerale a destra non farà che aumentare il livore imprevedibile dei nuovi populisti.