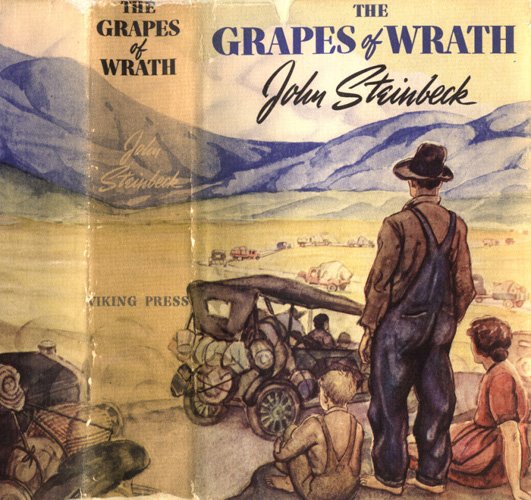Durante ogni anno solare, sono ben pochi gli eventi editoriali che, per importanza, novità o ardimento sono in grado di scuotere e trasformare la nostra percezione della letteratura, costringendoci a un lavoro di riflessione e di ridefinizione di coordinate culturali che pure ci sembravano consolidate. Quest’anno c’è stato forse un solo avvenimento che abbia avuto questa portata seminale, e a giudicare non solo dalle classifiche di vendita, ma anche dal posizionamento nelle principali librerie, esiste il rischio concreto che esso venga colto e sfruttato solo da un numero esiguo di lettori. L’evento al quale sto pensando è la nuova traduzione, finalmente in versione integrale, di Furore di John Steinbeck (traduzione di Sergio Claudio Perroni, Bompiani, «Grandi tascabili», pp. 656, euro 12, 00): un romanzo che per decenni si è collocato al centro dell’immaginario collettivo, trasformandosi nell’epitome di un certo modo di concepire l’America, per poi sbiadire e adagiarsi lentamente dentro lo status di classico e di testimonianza di un’epoca (gli anni della Grande Depressione e del New Deal) sulla quale la patina del tempo sembra essersi posata in modo assai più inclemente rispetto agli anni Venti dei Fitzgerald e degli Hemingway.
Una breve sintesi delle vicende editoriali vissute dal romanzo dovrebbe essere sufficiente a chiarire il senso e l’importanza di una ritraduzione che giunge benedetta, per quanto stranamente tardiva. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1939, con il titolo The Grapes of Wrath («I frutti dell’ira», citazione dall’Apocalisse di San Giovanni), accolto da un clamoroso successo di pubblico e vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 1940, trasposto nello stesso 1940 per il grande schermo da John Ford – in una versione non del tutto fedele al romanzo e molto più consolatoria, ma di straordinaria qualità cinematografica – Furore venne segnalato da Elio Vittorini a Valentino Bompiani (che nel 1941 avrebbe dato spazio alla antologia Americana, curata dallo stesso Vittorini e considerata l’atto di nascita dell’americanistica in Italia). Fu proprio Bompiani – come ci ricorda Luigi Sampietro nell’introduzione al romanzo – a scegliere, con invenzione tutto sommato felice, il titolo italiano dell’opera, che fu tradotta nel giro di pochi mesi (da Carlo Coardi) e pubblicata già nel gennaio del 1940.
È sempre Sampietro a spiegare le probabili ragioni per le quali il regime fascista autorizzò l’uscita del libro, pochi mesi prima dell’entrata in guerra dell’Italia. Deve aver agito, sui censori del Minculpop, la convinzione che Furore servisse «a diffondere l’immagine di un’America violenta e barbarica. Primitiva. Un perfetto esempio a sostegno della propaganda fascista», che aveva tutto l’interesse a includere gli Stati Uniti nel novero delle plutocrazie borghesi nemiche del popolo. La concessione del visto per la pubblicazione fu comunque accompagnata da un’attenta azione di tagli, che riguardarono tanto il contenuto politico del libro quanto il suo linguaggio, caratterizzato da una «creaturalità» e un’esplicitezza alle quali il pubblico dei telefoni bianchi era tutto fuorché preparato.
Del resto, dal tentativo di rendere meno esplicito e più accettabile il linguaggio di Steinbeck non fu esente neppure uno scrittore e traduttore del livello di Cesare Pavese – certo non vicino al regime –, che l’anno precedente, licenziando per le stampe la sua versione di Uomini e topi, non aveva mancato di edulcorare – e non poco – la lingua dei personaggi. Ne risultò in qualche modo schiacciata e sminuita quella varietà di registri linguistici, quel potente impasto di linguaggio biblico e slang contadino, nel quale consiste buona parte della forza e dell’originalità stilistica del miglior Steinbeck; senza che peraltro, come del resto accaduto per altri maestri degli anni Trenta come Fante e Caldwell, i limiti delle traduzioni ostacolassero la fama critica degli autori e delle opere. Si pensi al lavoro di Vittorini, che firmò le prime versioni di Pian della Tortilla, di Chiedi alla polvere e di Piccolo campo tra mille infedeltà, errori e tagli arbitrari, ma senza ottundere nei lettori la consapevolezza di trovarsi davanti un corpus di opere davvero unico, in grado di segnare a fondo la cultura degli anni di guerra e ancor più del secondo dopoguerra.
Sulla fortuna critica di Steinbeck in Italia agirono altre e non meno rilevanti rigidità. Se il regime fascista aveva tentato di appropriarsi di Furore facendone uno strumento di propaganda antiamericana, la cultura antifascista e di sinistra riconobbe in un primo tempo in Steinbeck un compagno di strada, esaltandone l’impegno in difesa dei lavoratori e dei diseredati e contro lo sfruttamento brutale da parte del grande capitale e dei cartelli. Non a caso, nel primo canone steinbeckiano trovò stabilmente posto un romanzo come La battaglia – tutto centrato sulla preparazione di uno sciopero, e tradotto da un’altra firma di assoluto prestigio come Eugenio Montale –, a detrimento di opere più «ariose» e virate verso la commedia, come Pian della Tortilla o Vicolo Cannery.
Con il progressivo spostamento della critica letteraria e anche di una parte della nascente americanistica verso un’ortodossia marxiana, la critica velata all’azione del Partito comunista contenuta nella Battaglia, e l’ispirazione fortemente anti-moderna che sottende diversi passaggi di Furore condizionarono pesantemente la valutazione complessiva dell’opera di Steinbeck, che si ritrovò paradossalmente relegato al rango di autore quasi minore rispetto a figure più inequivocamente borghesi come Hemingway o Fitzgerald.
La possibilità di rileggere finalmente Furore in traduzione integrale costituisce un’occasione unica per riflettere tanto sulle qualità del libro e sulla sua collocazione all’interno del canone americano, quanto sulla necessità e l’opportunità di «ritradurre» buona parte dei romanzi che, pubblicati tra gli anni Venti e i Quaranta, hanno proiettato la letteratura degli Stati Uniti al centro non solo dei percorsi di lettura, ma delle passioni e del sogno di rigenerazione di un intero paese.
Il primo dato, davvero impressionante, è la ricchezza linguistica del romanzo. Da traduttore consumato e avvezzo a sfide spesso vincenti con grandi autori contemporanei – da David Foster Wallace a James Ellroy, da Kurt Vonnegut a Michel Houellebecq – Sergio Claudio Perroni si è lanciato in un autentico corpo a corpo con i mille registri di Steinbeck, assecondandone con passione l’afflato biblico, il travolgente lirismo nella descrizione di una terra insieme rigogliosa e offesa dai trattori prima ancora che dalle intemperie, la ricchezza di richiami alla realtà contemporanea, la fascinazione per il viaggio dei nuovi migranti e per i luoghi – diner, empori, stazioni di servizio – che ne scandiscono le tappe. Ha trovato una lingua insieme arcaica e carnale che riproduce quasi senza falle le voci originali dei personaggi, rifuggendo da qualunque tentativo di edulcorare e appiattire. I membri della famiglia Joad parlano tutti allo stesso modo e insieme sono preservati nelle loro diversità: a partire da un registro comune, la psicologia di ciascuno emerge con chiarezza se possibile maggiore.
Ancora, Perroni si è calato nei capitoli «documentari» riproducendo un flusso nel quale la lingua giornalistica e l’oralità raggiungono a tratti esiti sorprendenti, ma anche senza nascondere quelle (non frequenti) derive ideologiche su cui si è esercitata spesso la critica marxista e che appaiono oggi l’unica parte di Furore veramente «invecchiata». Nel complesso, in questa nuova, completa e accurata versione, il romanzo risalta in tutta la sua potenza corale. Più evidenti sono i legami con la letteratura americana coeva: nei capitoli documentari il potente flusso linguistico sembra risentire della lezione di Whitman, magari filtrata attraverso le narrazioni fluviali di Thomas Wolfe, e anticipare la strabordante oralità di Sia lode ora a uomini di fama, il reportage di James Agee che, corredato dalle magnifiche foto di Walker Evans, sarebbe stato pubblicato due anni dopo Furore, segnando l’apogeo della letteratura del New Deal. D’altro canto, la lingua dei protagonisti, nella sua brutale creaturalità, ha non pochi tratti in comune con quella dei contadini impoveriti della Via del tabacco o di Piccolo campo, anche se la visione di riscatto che sottende il pellegrinaggio della famiglia Joad non trova corrispettivi nel nichilismo a tratti sardonico di Caldwell. Sul piano strutturale, l’alternanza tra capitoli giornalistici e narrativi deve certamente qualcosa ai romanzi di Dos Passos, che molti considerano il vertice assoluto della cosiddetta «letteratura proletaria» e che hanno conosciuto in Italia una sorte tutto sommato simile a quella di Furore (pubblicato nel 1932 con il titolo Nuova York, Manhattan Transfer subì diversi tagli da parte della censura, ed è stato riproposto in versione integrale da Baldini e Castoldi lo scorso anno). D’altro canto, Steinbeck è molto lontano tanto dal coté urbano che caratterizza la narrativa di Dos Passos, quanto dai collage modernisti e dal montaggio cinematografico che contraddistinguono le parti più innovative della trilogia U.s.a.
Eppure, niente incarna l’ideologia del New Deal e degli anni Trenta meglio del celeberrimo discorso con il quale Tom Joad, costretto di nuovo alla fuga dopo aver colpito (forse a morte) un brutale vice sceriffo, prende congedo dalla madre. Nella versione di Perroni, le parole di Tom acquistano un’ulteriore, potente vitalità, esaltata dall’impasto di sgrammaticature e richiami biblici. «Io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto. Sarò in tutt’i posti… dappertutto dove ti giri a guardare. Dove c’è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi ha fame, io sarò lì. Dove c’è uno sbirro che picchia qualcuno, io sarò lì». Ripreso verbatim da Bruce Springsteen nel memorabile The Ghost of Tom Joad, il discorso di Tom rappresenta il segno più tangibile di una letteratura che vuole prendere le distanze dall’individualismo ribelle del primo modernismo americano, e coniugarsi alla prima persona plurale (poche pagine prima, citando l’ex predicatore Casy, vero centro morale del romanzo, Tom aveva affermato: «Se due si coricano insieme, si scaldano tra loro; ma uno che sta da solo come fa a scaldarsi?»).
Questa letteratura al plurale, cui Hemingway cercò vanamente di adattarsi in Avere e non avere e in Per chi suona la campana e della quale Faulkner si fece portavoce dialettico nei suoi grandi romanzi degli anni trenta, Luce d’agosto e Assalonne, Assalonne!, risuona lungo tutto Furore, in pagine di irresistibile lirismo e vitalità. Ritradurre i classici del Novecento americano si rivela, in questo caso come non mai, una scelta provvida: non solo per colmare errori, lacune e censure che fanno ormai parte della storia della nostra cultura, ma per far scoprire o riscoprire autentici capolavori, sottraendoli così all’obsolescenza e all’indifferenza e proiettandoli in un’attualità che sappia preservare e valorizzare la memoria.