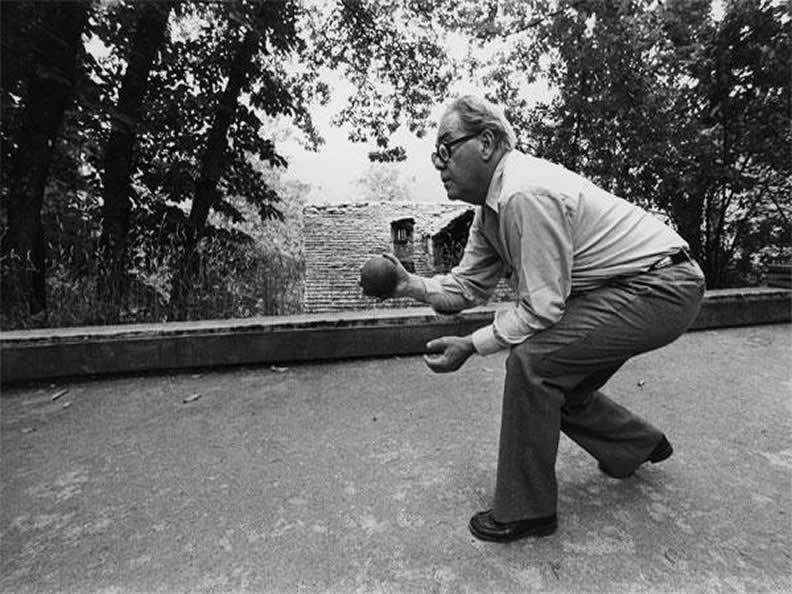L’attuale indifferenza nei confronti di Max Frisch la dice lunga sull’intempestività di noi contemporanei. Cees Nootemboom, raccontando in 533, il libro dei giorni dei suoi incontri con lo scrittore svizzero, ha notato come la contiguità linguistica con la Germania, percepita come «una sfida e una presenza», e la mancata partecipazione all’esperienza della guerra, abbia fatto degli autori svizzeri degli outsider involontari. Da qualunque lato la si prenda, la figura di Frisch appare mossa da istanze esplorative che ne decentrano l’esperienza, portandola a una inesausta riscrittura delle coordinate personali e estetiche. Atteggiamento magmatico, che funziona a spostare il lettore verso la consapevolezza di un orizzonte più ampio, evocando la costante irriducibilità del reale. È qualcosa di evidente anche tra le pieghe della raccolta Alla fine dell’Illuminismo Interviste e colloqui, appena pubblicata da Meltemi (traduzione e cura di Mattia Mantovani, pp.247, € 20.00), testi ordinati cronologicamente del grande scrittore svizzero, figura imprevedibile e allo stesso tempo paradigmatica della scena letteraria della seconda metà del Novecento, quella segnata dal contraccolpo del secondo conflitto mondiale e dai posizionamenti della guerra fredda.
Il ruolo sociale, un veleno
L’impianto consueto delle interviste, dove si risponde alle domande del proprio interlocutore, non regge al bisogno di Frisch di relativizzare i ruoli. Molto spesso, la sua propensione maieutica a liberare il movimento delle idee aderendo alle diverse angolazioni della coscienza lo porta in queste pagine a un gioco di scambio tra intervistatore e intervistato, dove la posta in palio è stanare i punti di vista che ci immobilizzano nella fissità di schemi prefissati a scapito della fluidità degli argomenti trattati.
Questa stessa inquietudine elevata a metodo è il fulcro dei suoi grandi romanzi esistenziali, Homo faber, Stiller, Il mio nome sia Gantenbein, fondati sulla irriconoscibilità dell’uomo a se stesso, e sullo smascheramento delle invenzioni dell’Io. Qui e altrove, i suoi testi propongono una galleria di fuggitivi, o di ambigui impostori equivocati a causa della loro indeterminatezza: il ruolo sociale di ciascuno di noi è per Frisch un veleno che aliena, irrigidendo ciò che tocca, e costringendoci a allineare la nostra precarietà. Nei colloqui raccolti, questa spinta verso la destrutturazione prismatica è tanto più interessante perché attivata lucidamente, e con l’apporto di una componente dialettica.
Consapevole del persistere in sé di quella simultaneità di dimensioni diverse, che è così tipica della sensibilità degli esuli, Frisch conserva anche memoria della sua formazione di architetto, trapiantata nella scrittura che ne conserva l’attitudine plastica, arricchita dagli scarti improvvisi di ogni testo letterario. Ce lo rivela il montaggio dei suoi diari, un vero e proprio cantiere di spunti e stilemi letterari, usati alla stregua di materiali di risulta animati da una vena sperimentalista.
«Scrivere significa: leggere se stessi» ha detto Frisch, portando all’evidenza quella terra incognita che si viene via via scoprendo. E, in effetti, non è molto diversa da un’intervista l’esperienza di una scrittura fondata sull’inedito incontro, sulla sorpresa che accomuna autore e lettore in un medesimo presente fatto di slittamenti e rivelazioni. Nel suo accadere, ciò che si scrive deve sorprendere prima di tutto l’autore, inteso come quel sé che si identifica con gli altri.
Nei famosi «Questionari» di Frisch, una serie di spiazzanti domande esistenziali (per esempio sul matrimonio o sulla speranza) svolge la funzione di una vera e propria istruttoria della coscienza nell’atto di decifrare la realtà. Una realtà indagabile facendo piazza pulita di ogni scontata classificazione, mentre l’esercizio di inseguire la verità ha bisogno di parabole e metafore: sembra possa essere solo inventata. Frisch resta tuttavia uno scrittore concreto, impegnato nel confronto con materie e situazioni che vincolano la vita, affrontate con un’attenzione quasi carnale. «La verità è concreta» ripete con il suo maestro Brecht, e anche nella scrittura «è consentito solo ciò che riesce. E riesce soltanto ciò che riesco a capire e mi sembra possedere una residua credibilità».
A volte Frisch corre il rischio di farsi didattico, non a caso consumò una lunga frequentazione con Brecht, dal quale gli venne l’immissione della componente razionale nella produzione artistica. Ma ne è consapevole, sa quali siano i pregi e quali i pericoli: come quando confessa nell’intervista con Dieter E. Zimmer che alcune sue parabole teatrali – Omobono e Andorra – mentre funzionano da modello, si costituiscono come un insegnamento che irrigidisce il senso. E però, in un’altra intervista con Enrico Filippini, Frisch sostiene che l’epica non ha bisogno di illusioni ma di modelli, di storie raccontate non come fossero accadute, ma in quanto messinscene che rivelino il ruolo dell’invenzione nelle nostre vite.
La lezione di Montaigne
Diffidente verso l’inerzia dei risultati acquisiti, Frisch si muove sempre alla ricerca di varianti: questo suo moto di resistenza centrifuga fa da contraltare agli equilibri di un’epoca postbellica che proponeva nuove, farisaiche ricomposizioni. La sua, è una chiamata alle armi della coscienza critica a tutela della libertà che accompagna ogni vero percorso di conoscenza.
D’altronde, il suo umanesimo eretico e propenso allo scetticismo si alimenta al Montaigne il cui celebre motto: «Che cosa conosco?» potrebbe essere messo a epigrafe dell’intera sua opera. Nel suo solco, la disputa tra il paesaggio immobile dettato dalla fissità del pregiudizio e il punto di fuga attivato dall’esercizio di ogni rappresentazione è il segno distintivo della poetica di Max Frisch, ciò che ancora ci commuove nella sua concretezza.