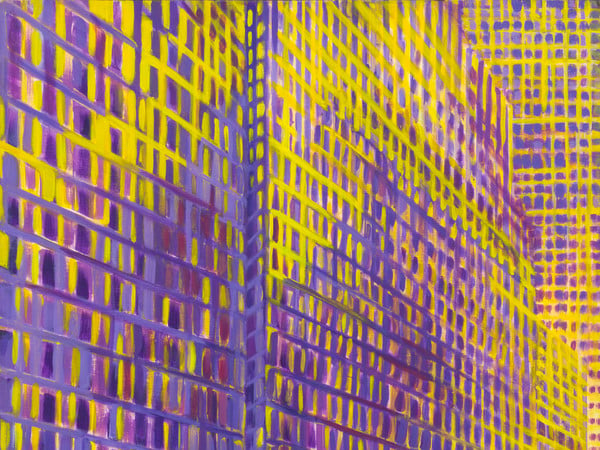Storia della cultura o evoluzione delle forme letterarie nel sistema-mondo? Critica dell’immaginario moderno, dei generi e delle figure che lo abitano (Il romanzo di formazione, Il borghese), o analisi quantitativa di dati bibliografici e fenomeni stilistici, con ampio corredo di grafici, mappe, alberi? Di che cosa è maestro Franco Moretti, senz’ombra di dubbio, a livello mondiale, il più influente fra i teorici della letteratura italiani oggi in attività?
A conferma di una vocazione duplice, e perfino contraddittoria, dopo Un paese lontano (Einaudi, 2019), lucida inchiesta, per frammenti esemplari, sulla modernità dinamica della cultura americana, e sulle ragioni profonde della sua egemonia, Moretti manda in libreria A una certa distanza (Carocci, pp. 232, € 19,00): dal polo saggistico, il pendolo si sposta verso quello ‘scientista’, della cui declinazione hard dà conto anche una silloge più specialistica, e a più mani, La letteratura in laboratorio (Federico II University Press, 2019). Il volume di Carocci è la versione italiana di Distant reading, pubblicato in inglese da Verso nel 2013; raccoglie dieci saggi non recentissimi (il primo è del 1993), e ormai canonici.
Moretti intuisce sempre il kairòs: riconosce lo spirito dei tempi, coglie il momento giusto. Anticipa a inizio anni Novanta la voga degli studi sulla letteratura europea, che si sarebbe sviluppata a cavallo dei due millenni: una voga rivelatasi poi effimera, come le illusioni di integrazione legate all’avvento dell’euro. Nel 2000, riesuma da secolare naftalina germanistica il concetto goethiano di Weltliteratur, per farne il fulcro di un dibattito, vivo ancora oggi, sui rapporti di potere e le interferenze formali fra i diversi sistemi letterari nel mondo globalizzato.
Una teologia secolarizzata
Negli stessi anni, interpreta in modo originale sia il rinnovato dialogo fra letteratura e scienza (le Convergenze di cui parlava Remo Ceserani), con alberi evolutivi per dar conto della storia delle forme letterarie; sia la ‘svolta spaziale’, che nella critica letteraria è stata il lascito più fecondo della moda foucaultiana, e che nel pragmatismo di Moretti si è tradotta nell’Atlante del romanzo europeo. E poi, più di recente, è stato fra i pionieri di quelle digital humanities che, in versione addomesticata, stanno invadendo i nostri dipartimenti di lettere: se per Moretti la potenza del calcolo informatico e la ricchezza dei grandi database, come quelli del Literary Lab di Stanford, servono a suscitare domande imprevedibili sulla storia dei generi e delle forme, in quell’ottica di lunga durata temporale, in quell’articolazione di rapporti fra centro e periferie (Braudel riletto attraverso Wallerstein), che per lui rappresentano la sola comparatistica utile, la nostrana informatica umanistica (salvo eccezioni) si compiace nel mero accumulo di stringhe testuali: Moretti gioca con il computer, con spericolata intelligenza; i filologi adorano come feticci la macchina e i dati inerti immagazzinati.
Richieste di replica
Di tutto questo parla A una certa distanza: letteratura europea e mondiale, evoluzione delle forme artistiche nel sistema-mondo, applicazione alla letteratura di metodi di analisi quantitativa. In Italia il libro arriva tardi, ma il ritardo rende più agevole un bilancio retrospettivo: quasi ognuno di questi saggi ha prodotto un filone di studi, con i suoi fautori e i suoi detrattori.
Per fare un solo esempio, il ruvido dialogo con Christopher Prendergast su evoluzionismo, mercato e letteratura, di cui dà conto il capitolo 7, è uno degli episodi più intensi di confronto intellettuale in anni recenti: sarebbe valsa la pena di tradurre anche l’intervento dell’interlocutore. Se Moretti è stato spesso accusato, non sempre a torto, di riduzionismo neopositivista, è soprattutto perché costante rimane, con diverse sfumature, l’obiettivo polemico dei suoi interventi: quell’ermeneutica testuale che in America si identifica con il close reading, prediletto in modi divergenti prima dal New Criticism e poi dal decostruzionismo, cioè con una lettura minuziosamente ravvicinata, che cerca i significati profondi dei testi canonici, sondandone le inesauribili ambiguità. Per Moretti, è teologia secolarizzata: al suo soggettivismo, a volte fumoso, sostituisce il rigore dell’analisi materialista; al suo arroccamento nella cittadella dei classici, la curiosità per la mole sterminata dei libri dimenticati.
Il piglio di una scrittura che mira dritta al punto, nella finta semplicità di un’elegante paratassi, rischia a volte di eccedere in sicurezza apodittica, di dare per scontati i nessi logici. Soprattutto nei saggi più lontani nel tempo, Moretti non sa rinunciare alla formula provocatoriamente icastica: «un continente che s’innamora di Milan Kundera faccia pure la fine di Atlantide»; «La vita è bella: ciò che un adulto infantile vuole che un bambino sappia di Auschwitz»; e così via. A guardar bene, però, non sono semplici trovate a effetto: condensano una visione della cultura, e chiedono una replica. Del resto, basterebbero i brevi cappelli che introducono ogni saggio per mettere all’insieme una sordina problematica; e per rendere la raccolta di saggi un libro vero, nuovo: in cui la rivendicazione, contro ogni pigrizia, di un’inesauribile creatività teorica è accompagnata da una sottile vena di scetticismo, a tratti nostalgico, a tratti autoironico. E anche le ampie note – sciaguratamente stampate in fondo al volume – non esitano a dar conto delle obiezioni ricevute, e non di rado a riconoscerne il fondamento.
Aggettivi senza avventura
Ogni pagina di Moretti, per consenso o dissenso, stimola una discussione. Non sarebbe così, se il conclamato bando imposto all’ermeneutica vigesse davvero nella concreta prassi di Moretti. In realtà, la soggettività dell’interprete dà forma al discorso storiografico perfino nei saggi in apparenza più inclini alla mera catalogazione quantitativa dei dati, come il capitolo 9, Stile SRL. Riflessione su settemila titoli (i romanzi britannici dal 1740 al 1850). Da una constatazione elementare – col passare degli anni, i titoli si abbreviano –, Moretti ricava conclusioni illuminanti: «Le sintesi settecentesche raccontavano ai lettori un sacco di cose sui romanzi, sì, ma non li mettevano alla prova»; la densità delle metafore ottocentesche, invece, spinge «il pubblico a sviluppare un interesse attivo verso il romanzo fin dalla prima parola». Anche l’analisi grammaticale può essere rivelatrice: «Senza gli aggettivi, siamo in un mondo di avventure; con gli aggettivi, in una familiarità destabilizzata». Tutto vero, fin qui.
Ma se quella di Moretti vuole essere, da sempre, una «critica falsificabile» (nel senso di Popper), per provare a essere all’altezza, nel darne conto, non ci si può sottrarre alla verifica. Un solo esempio. Confrontando corpora diversi, separati da un secolo (romanzi antigiacobini di fine Settecento, romanzi ‘suffragisti’, o New Woman Novels, di fine Ottocento), Moretti osserva nei titoli dei primi una schiacciante prevalenza dell’articolo determinativo, nei secondi una forte presenza dell’indeterminativo. Appoggiandosi all’autorità di Harald Weinrich, sostiene che il determinativo annuncia «qualcosa che già conosciamo», l’indeterminativo «lavora al contrario: attenzione, qui c’è qualcosa che non avete ancora incontrato».
Magari è vero per antigiacobini e suffragisti: non li ho letti. Di certo, però, uno sguardo alla narrativa canonica dice esattamente il contrario: in epoca romantica, l’articolo determinativo segnala l’esemplarità del tipo (Balzac, La zitella), ma anche, soprattutto, l’eccezionale unicità del personaggio singolare (sempre Balzac, La Rabouilleuse), dell’eroe straordinario, inaudito (per tutti: Dumas, Il Conte di Montecristo). Nel secondo Ottocento, invece, l’indeterminativo evoca la banalità seriale di storie senza qualità: Un cuore semplice (Flaubert), Una pagina d’amore (Zola), Una vita (Maupassant, e poi Svevo).
Antifrasi nascoste
L’indeterminazione, azzarderei, è la forma simbolica di quel trionfo dell’insignificanza che costituisce il più solido anello di congiunzione fra naturalismo e modernismo. E poi, il catalogo informatizzato non vede le antifrasi: Una bella giornata (Céard) può essere piovosa e vuota; mentre la routine di Una scampagnata (Maupassant) può sublimarsi in epifania ante litteram. E ancora: che ci può dire il computer dei titoli nelle lingue che ignorano l’articolo? Prendiamo Cechov: Una storia noiosa, senza alcun dubbio: non c’è titolo più naturalista e al tempo stesso modernista. Ma: Il duello o Un duello? Soprattutto: quello che è forse il più bel racconto (o romanzo breve?) del secondo Ottocento, il testo che meglio di ogni altro denuncia e sublima l’incompiutezza di ogni esistenza e di ogni sentimento, ha un titolo esemplarmente indeterminativo, che tuttavia sfugge alla ricerca di laboratorio, perché non ha bisogno di articolo: Tre anni – ritagliati quasi per caso, che poi «ci sono ancora da vivere tredici anni, trent’anni». Quanto incidono, nell’analisi, i dati oggettivi? E quanto due idee in parte diverse – quella di Moretti e la mia – dell’Ottocento e del modernismo?
Sempre a proposito di paratesti: al libro edito da Carocci, il sottotitolo (un po’ appiccicato, forse redazionale) non aggiunge molto: Leggere i testi letterari nel nuovo millennio; invece il titolo – concordato, si suppone, dal traduttore, Giuseppe Episcopo, con l’autore stesso – merita uno sguardo ravvicinato.
La lontananza secca del Distant reading si stempera in una modulazione indefinita («a una certa…») e sembra assumere un duplice significato: la distanza non è più solo fra il livello teorico dell’analisi e la singolarità irriducibile del testo; s’insinua anche nel tempo, fra l’oggi della ristampa in volume e gli anni in cui i saggi sono stati scritti. Quasi a disegnare in controluce il ritratto dell’autore, in quella che può essere considerata anche un’autobiografia intellettuale, o l’esame di coscienza di un critico.