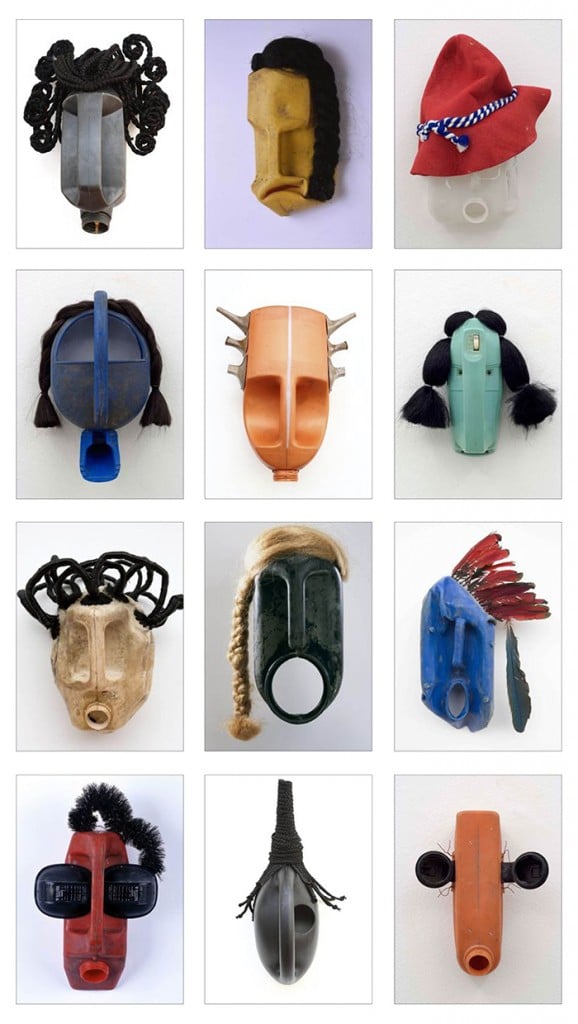Si invoca spesso, tra i vari smarrimenti, oblii, mancanze, di cui noi oggi porteremmo il lutto, una «crisi» dell’identità. Per le destre, la riconquista dell’identità, o la difesa dell’identità minacciata, è il caposaldo di ogni strategia, tanto che «identitario» è l’aggettivo più usato dalle destre di governo: ma anche a sinistra, l’analisi, o più spesso la lamentazione, è condotta nei termini di un’identità «forte», sempre data per perduta e sempre da ritrovare.
Allo stesso tempo, negli stessi discorsi che denunciano la perdita dell’identità (al singolare), le identità (al plurale) vengono additate come il nemico da battere, la causa di una deprecabile frammentazione: soprattutto quando esse appaiano sotto il segno delle cosiddette politiche dell’identità, o, in altre parole, delle rivendicazioni legate a genere, razza, cultura. In questo brusio che cerca la identità come ultima risorsa e teme le identità come la più inquietante minaccia, cade bene la traduzione italiana, a cura di Flavio Santi, di La menzogna dell’identità. Come riconoscere le false verità che ci dividono in tribù, di Kwame Anthony Appiah (Feltrinelli, pp. 280, euro 19).
APPIAH QUI METTE IN GIOCO la propria biografia, usandola come strumento contro la semplificazione comportata dai discorsi identitari. Padre nero ganese, cristiano metodista, madre bianca, inglese, anglicana, vissuto fino alla morte del padre a Kumasi, in Ghana, ora professore di filosofia alla New York University, Appiah racconta d’essere inseguito dalla domanda sulle origini: una domanda che lega indissolubilmente il dove sei nato con il chi sei. Ma le dimensioni biografiche si intrecciano continuamente: nazionalità, genere, razza, religione, residenza metropolitana o provinciale, plasmano le nostre esistenze in direzioni e in forme mai rappresentabili in modo stabile e definitivo. Partendo da sé, il filosofo costruisce così un percorso di apertura e smontaggio dei meccanismi identitari: l’identità è un’etichetta che influisce sia sul modo in cui ci concepiamo, sia sul modo in cui siamo visti e considerati dagli altri. Ricordare che essa è una costruzione sociale serve a curarci dalla trappola che scatta quando si dimentica che quell’etichetta è solo il risultato contingente di processi sociali plurali e conflittuali.
È L’ESSENZIALISMO, per Appiah, il pericolo mortale nella logica identitaria: così, attraverso l’analisi di concetti come nazione, razza, cultura, classe, il libro si trasforma in un esercizio di ascolto della mobilità e della pluralità irriducibile delle costruzioni identitarie, una terapia contro i fondamentalismi identitari e i vari tipi di trappole riduzionistiche. Significativamente, e a ragione, Appiah pone in una posizione diversa la questione del genere: in realtà, il discorso di genere non è una costruzione di identità tra le altre, ma ha prodotto il modo stesso di guardare all’identità come a un’etichetta, mettendo così in moto la critica all’essenzialismo. La stessa immagine dell’identità come costruzione sociale, confine mobile e contestato tra inclusione ed esclusione, scrive Appiah, «risulta una generalizzazione dei modi di pensare il genere elaborati dalle pionieristiche studiose del femminismo». Appiah riesce a cogliere molto bene come lo sguardo di genere sia capace di sovvertire ogni distribuzione fissa delle identità, dando vita a dislocazioni, transiti e ricombinazioni che rompono con qualsiasi «sindrome di Medusa» (per usare una bella espressione di Appiah) che pretenda di congelare essenzialisticamente le identità.
Lo sguardo (antiessenzialista) di genere apre così alla prospettiva intersezionale, che Appiah assume con grande forza: l’intersezionalità nomina la capacità di guardare all’interazione e al conflitto tra le diverse dimensioni dell’identità, di razza, di genere e di classe, andando oltre la semplice sommatoria di questi diversi aspetti, e analizzando piuttosto la produzione di ricombinazioni inedite, sia progressiste e liberatorie, sia stigmatizzanti e oppressive. Inoltre, sottolinea lo studioso, l’intersezionalità funziona come meccanismo di contestazione permanente del privilegio: nessuno può pretendere di parlare per tutti, nessuno può mai ritenere la posizione che occupa, nell’incrocio delle diverse condizioni di genere, razza e classe, talmente esemplare da costituire un’autorizzazione alla generalizzazione e una garanzia di particolare autorevolezza. L’intersezionalità, in questo senso, colloca e trasforma le identità, e, contemporaneamente, le destabilizza e le contesta.
L’INTERSEZIONALITÀ ci spinge così al cuore dei conflitti aperti dai movimenti di lotta che attraversano le identità (e le politiche dell’identità). Alla buon’ora, staremmo per dire: perché una terapia antiessenzialistica è sicuramente salutare, ma l’insistenza di Appiah sulle dimensioni plurali, multiple, mobili, dell’identità rischia di essere fragile se ci si affida troppo, come il libro tende a fare, a una sorta di ermeneutica dell’apertura infinita, a una pur solida demistificazione delle mitologie fondamentaliste. L’ascolto della ricchezza delle diversità del mondo è cruciale: ma non ci protegge dal brusco riemergere della violenza identitaria, né soprattutto dai meccanismi appropriativi che il capitalismo contemporaneo sa dispiegare, avendo imparato a estrarre valore proprio dalla diversità e dalla molteplicità dei soggetti e delle forme di vita.
Non che Appiah trascuri queste dimensioni: il finale del libro presenta molti esempi di conflitto tra la logica dell’appropriazione capitalista e l’opposta logica delle «appropriazioni culturali» reciproche e delle transazioni attraverso identità, tradizioni e culture. Ma per non cedere alle logiche della proprietà, decostruire la trappola identitaria evidentemente non basta. Occorre cercare di riaprire un discorso di classe, con tutta la forza, ma anche con tutti i rischi che il richiamo alla classe può comportare per chi intende farla finita con le menzogne dell’identità. La classe, infatti, può presentare anch’essa aspetti identitari, ma al tempo stesso è un motore di trasformazione rispetto alle identità.
Appiah ricorda esplicitamente la lezione dello storico inglese Edward P. Thompson contro ogni riduzionismo economicistico, la visione della classe operaia «nel suo farsi» come produzione di una soggettività proletaria irriducibile a qualsiasi omogeneità identitaria. Questa classe come dispositivo politico di composizione di soggettività eterogenee è una traccia indispensabile per costruire resistenze nei confronti, contemporaneamente, sia dei dispositivi identitari che di quelli proprietari. A cominciare da quel «carapace del merito» (così Appiah in belle pagine contro la meritocrazia) che torna a bloccare, all’interno di nuove gerarchie, la mobilità sociale conquistata da una società che ha rotto le mappe identitarie tradizionali.
SEGUENDO QUESTA LEZIONE, che può provare a riaprire lo scontro di classe dentro la produzione di soggettività, e nel cuore stesso delle lotte trans- e post-identitarie, invece che in alternativa ad esse, si deve esercitare un anti-essenzialismo radicale, nella piena consapevolezza della storicità sempre contestabile di tutte le norme che pretendono di fissare confini e gerarchie di genere, di razza e di classe. Nessun rimpianto, allora, per le identità sedicenti forti, che siano nostalgie per una qualche differenza essenzialisticamente declinata o per una classe «industriale» dalla omogeneità più mitizzata che reale o ancora per quel da troppi invocato «popolo sovrano». Ma, al tempo stesso, è necessario lasciarsi indietro ogni versione solo sociologica o culturale dell’intersezionalità, per farne un motore di composizione di insiemi singolari, di un comune attraversato e segnato su tutta la sua superficie dalle differenze. Direzioni indicate oggi dai movimenti che praticano quotidianamente la rottura di identità e confini: attraversamenti migranti, navi «pirata» della solidarietà, movimenti transfemministi globali.