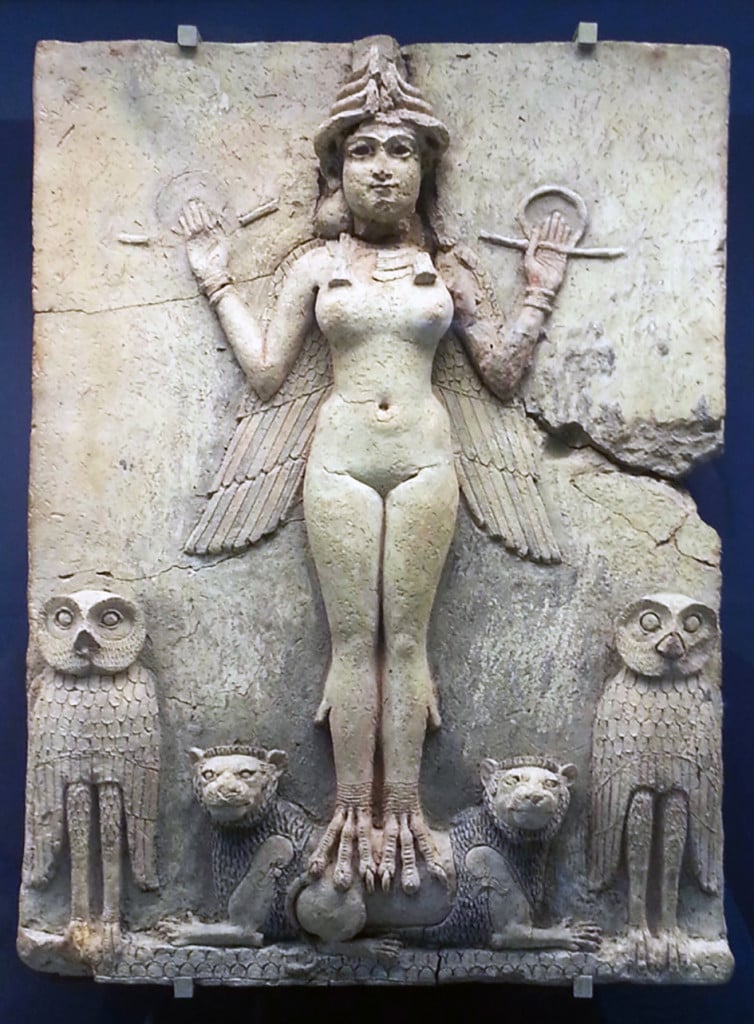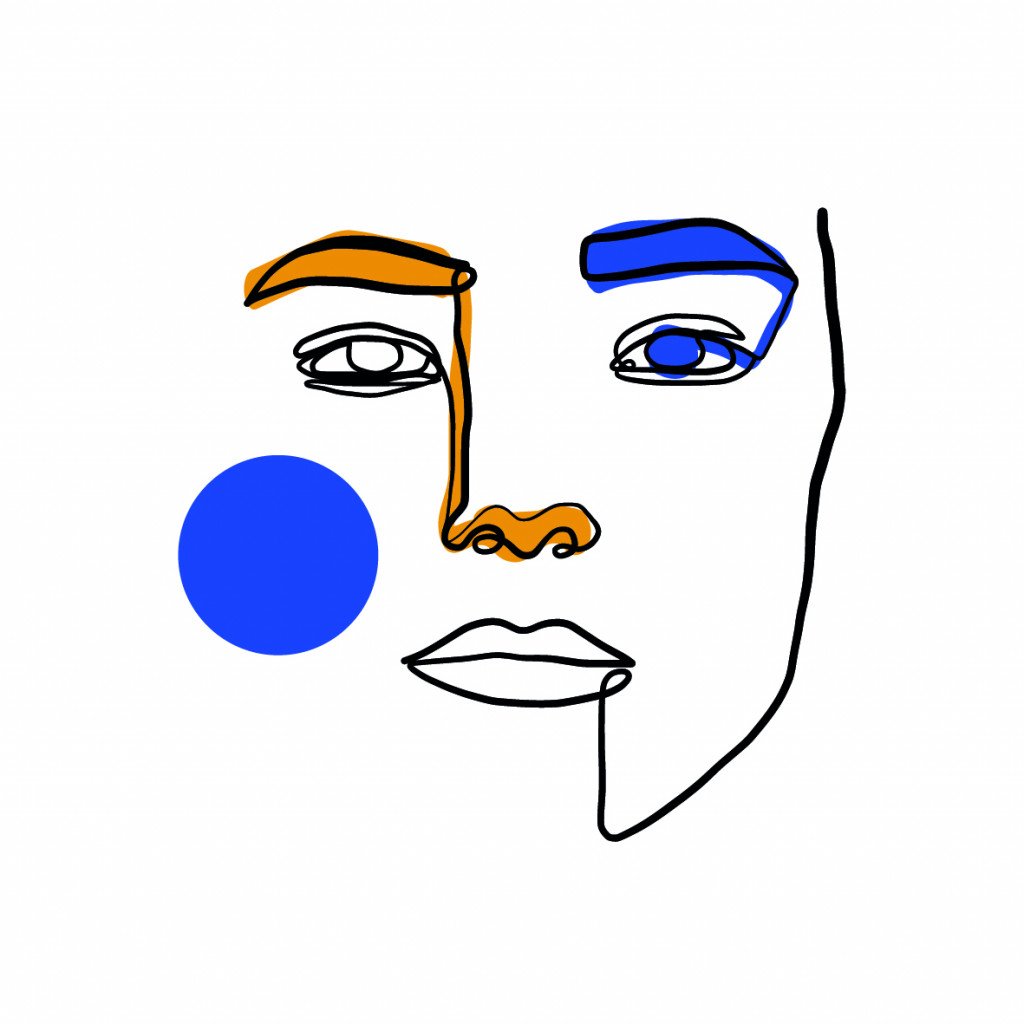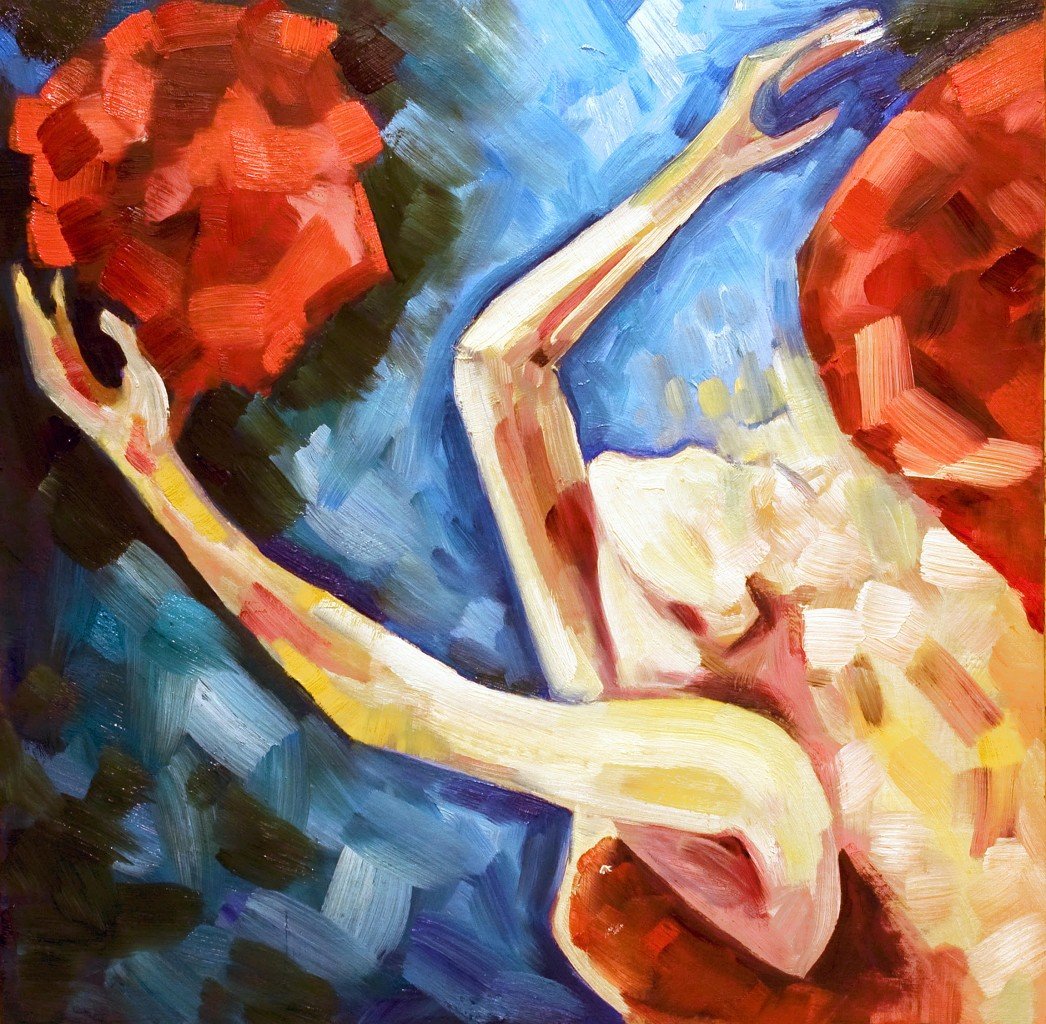Al netto delle critiche e delle preoccupazioni, tutte veritiere e assolutamente legittime, su cosa potrà accadere alla didattica qualora le scuole e le Università dovessero decidere, dopo questa grande «sperimentazione», di elevare a sistema la cosiddetta DAD (didattica a distanza); al netto delle critiche legate alla sproporzione che intercorre tra la retorica dell’innovazione ad ogni costo e la realtà –paradossalmente denominata come «lavoro da remoto» ovvero come un qualcosa che rimanda al passato, più che al presente o al futuro- ovvero il possesso o meno di uno o più PC, tablet, all’interno di uno spazio domestico, in questo articolo desidero soffermarmi, a partire dalla mia esperienza, su quelli che sono stati e sono i lati generativi della già citata DAD (didattica a distanza). Superata una prima fase di puro disorientamento legato alla fatica della comprensione di nuove piattaforme messe a disposizione dalle Università, su come fare per non perdere il rapporto con gli studenti –avevo cominciato i miei corsi universitari in presenza giustappunto nella prima settimana di marzo- e su come riorganizzarsi la vita lavorativa da casa, ho avuto modo di esperire una serie di situazioni interessanti e totalmente inedite.
La casa per una donna può essere una reggia o una prigione, secondo le circostanze, ma certamente le stesse donne, molto più degli uomini, sono storicamente meno impreparate al lavoro da casa, tanto più che in tante hanno scelto o scelgono volontaristicamente di farlo – come denota bene Sandra Burchi nel suo libro uscito qualche anno fa, in un tempo che precede la pandemia, dal titolo Ripartire da casa, lavori e reti dallo spazio domestico (2014, Franco Angeli). Il culto dell’oikonomia (governo della casa), nato all’interno dell’organizzazione della polis greca, a quel tempo necessario affinché gli uomini potessero discutere di politica e filosofia senza le donne e gli stranieri che si occupavano solo del loro sostentamento e di quello della comunità, da parecchi anni pare essersi rovesciato al punto da trovarlo come un modello possibile di governo virtuoso centrato sulla cura, la pratica delle relazioni, la gestione delle cose a partire dal modello «domestico». Un fenomeno che in tante abbiamo criticato perché utilizza strumentalmente le cosiddette «attitudini» del femminile elevandole a principi del capitalismo. Si pensi ai processi di «femminilizzazione del lavoro», al successo della «care economy» che mira a sostituire progressivamente il welfare state centrato sull’esigibilità dei diritti sociali, al «diversity management» molto caldeggiato dalle autrici del best seller Womenomics (C. Shipman, K.Kay, Womenomics, work less, achieve more, live better, Harperbusiness, 2010).
La critica al sistema, si sa, non ammette mediazioni, ma cosa accade quando un agente terzo, in questo caso un virus, si impossessa del mondo e delle nostre vite travolgendole totalmente? Cosa avremmo dovuto fare? Rifiutarci di continuare i nostri corsi online tradendo così il diritto fondamentale allo studio degli studenti? Evitare il contatto diretto con le piattaforme ponendoci il problema della proprietà dei nostri contenuti video-registrati? Esodare dai nostri doveri accademici? No, nel mio caso non è andata così, perché dal pensiero della differenza, oltre che dalla mia esperienza, ho imparato a fare del rovescio un elemento di politica generativa e feconda, oltre che ad approcciare una qualsiasi grande o piccola trasformazione evenemenziale in un qualcosa di vivibile, al fine di produrre piacere per me e gli altri, nonché risignificazione del desiderio originario e il mio è sempre stato quello di scrivere ed insegnare.
Così mi sono attivata per tenere i miei corsi online risignificando tra me e me parole, spazi, temporalità, non per farmela piacere, ma per puro desiderio di misurarmi con un qualcosa di nuovo, contingente, segnato da cause di necessità e urgenza, mettendo al primo posto le studentesse e gli studenti, anziché me stessa. Ho sempre preferito pensare di tenere dei corsi, anziché pensare di «fare didattica» – come si dice oggi – formulazione asettica, scientista, di matrice anglosassone e priva di ogni forma di implicazione sentimentale del nostro lavoro. E così, a partire da questo pensiero ho immediatamente constatato che tenere un corso online, stante la condizione pandemica nella quale siamo, può anche aprire ad imprevisti ed inaspettate modalità di intendere gli stessi, tutte molto interessanti.
La prima cosa che ho constatato è che il venir meno dello spazio terzo che si sovrapponeva tra me e loro, ovvero l’istituzione Università, con la formale ritualità della mezz’ora accademica, il microfono, io dietro la cattedra e loro dietro i loro banchi, ha generato una maggiore partecipazione da parte loro (naturalmente trattandosi di studenti universitari nessuno ha il problema di non possedere uno smartphone, un tablet o un PC). Non solo dal punto di vista numerico perché molti studenti lavoratori ora hanno più tempo da dedicare allo studio, ma anche dal punto di vista della cooperazione e della partecipazione, nonché della collaborazione tra loro e tra loro e me. In altre parole una modalità di trasmissione del sapere molto più centrata sulla cura, che non sul mero concetto di «prestazione» finalizzata solo all’esame finale. Lo spazio, da casa a casa, ha generato una maggiore intimità che ha liberato timidezze, formalismi, paure. Anche il tempo delle nostre lezioni si è dilatato. Se prima stavo in aula un’ora e mezza, ora ogni lezione dura più di due ore come fossimo tutti protagonisti di una rinnovata discussione filosofica e sociologica nello spazio-tempo di una polis dentro casa che non esclude più le donne e gli stranieri. E infine le chat, le quali anziché popolarsi di inutili emoticon diventano popolate di domande sul Leviatano, sul Panopticon, sullo Stato, sulle migrazioni, sulla pena e su mille altri temi affrontati a lezione.
Naturalmente il mio non vuole essere un elogio dei corsi online su cui hanno già costruito poteri e capitali le Università telematiche a causa di una sequenza di riforme assai discutibili dei saperi così come dell’istituzione universitaria, ma solo un modo per far emergere una serie di contraddizioni e di relazioni generative che prima di questa esperienza non avrei mai potuto verificare. Una sorta di lato positivo del disastro, da cui partire anche per contenere le derive neoliberiste, prestazionali e performative di cui si nutre l’Università contemporanea, quella in presenza. E così ho anche smesso di usare il termine «corsi» che prima usavo per non usare «didattica» o «offerta formativa» e ho stabilito che nella pandemia noi siamo due «comunità della cura» ritornando a dare al sapere la sua potenza originaria, quella di un pharmakon che cura il corpo e la mente, mentre fuori imperversa la pandemia. Naturalmente, appena sarà possibile, tutto questo diventerà di nuovo fisico, materiale, incarnato. Questo è solo un passaggio, un momento, una contingenza tutta da pensare e da vivere nel migliore dei modi possibili. Ma proviamo a pensarci un attimo: e se dal remoto venisse la cura?