Ex giornalista delle pagine culturali di Haaretz, docente di letteratura poliziesca all’Università di Tel Aviv, Dror Mishani è una delle figure più sorprendenti e stimolanti del noir israeliano, un genere che si sta progressivamente emancipando sia dai cliché del romanzo d’azione che ruota attorno ai conflitti del Medioriente, che dalla narrativa del «nation-building» del Paese.
Quella che racconta Mishani nelle sue storie – la serie dell’ispettore Avi Avraham, di cui da noi sono usciti due capitoli, Un caso di scomparsa e Un’ipotesi di violenza e, ora, questa volta senza il poliziotto introverso della periferia sud di Tel Aviv, Tre (e/o, pp. 246, euro 18, traduzione di Alessandra Shomroni -, è una società che insegue una propria paradossale «normalità» e dove, a ben guardare, il male e la violenza si situano anche altrove rispetto al confine tradizionale del conflitto con i palestinesi.
Così, dopo aver indagato la violenza domestica e il razzismo – non a caso visto che al pari di Avraham anche lui proviene da una famiglia sefardita, con avi sparsi tra Aleppo e Beirut, quella parte della popolazione israeliana spesso considerata come «troppo vicina» agli arabi – Mishani abbandona il suo personaggio per costruire un diario intimo del femminicidio dove le vere protagoniste sono le vittime, le loro fragilità e la loro straordinaria umanità: donne che inseguendo l’amore troveranno invece la morte. In una Tel Aviv livida e solitaria che non ha nulla della città-vetrina di tanti film, sarà un’altra donna a voler riaprire quei casi abbandonati per cercare di rendere almeno una parziale giustizia a quelle esistenze interrotte che sente però così vicine alla propria vita.
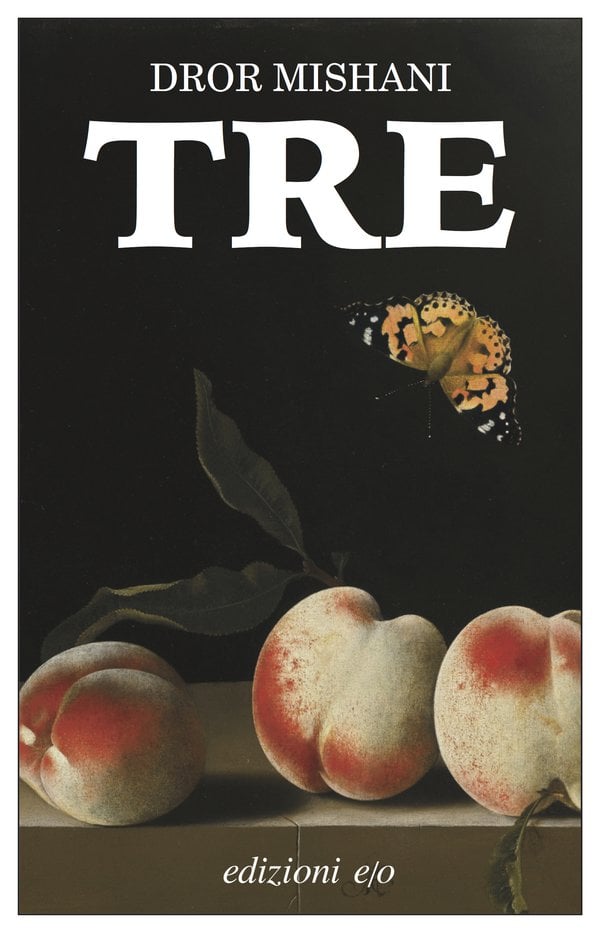
Con questo libro ho voluto mettere da parte la forma classica del romanzo poliziesco, una vicenda narrata dal punto di vista dell’investigatore o del killer. Questa doveva essere la storia delle vittime: sono loro a raccontarsi al lettore e non pochi minuti, ore o giorni prima del crimine, ma alcuni mesi o addirittura anni prima. Si è trattato di una decisione sia etica che estetica, nel senso che stavolta la storia dell’assassino sarebbe stata in qualche modo «fuori fuoco». Tre è il romanzo di Orna e Emilia, non di chi le ha assassinate.
Fino ad oggi, il protagonista delle sue storie era l’ispettore Avraham, in questo caso è invece una donna a indagare. Solo lei poteva risolvere questi crimini, perché si identifica con le vittime?
Non so se solo una donna potesse indagare su questi casi, so che personalmente non avrei potuto che scriverne così. Il punto è che la violenza contro le donne rientra a pieno titolo nelle strutture sociali e politiche del mondo in cui viviamo. Morti come quelle che descrivo nel libro – di due donne sole, entrambe a loro modo emarginate – non sono necessariamente ignorate, ma possono essere facilmente «dimenticate», trascurate, considerate come qualcosa di «naturale». Come accade a due investigatori maschi nel romanzo, gli uomini spesso non notano o non considerano importanti i particolari o i dettagli di vicende simili. Ci vuole una donna per rimuovere quella patina di inevitabilità che fa apparire queste morti banali e ne svela il carattere criminale.
Cosa significa evocare il femminicidio, o come nel caso dei suoi romanzi precedenti altre forme di violenza che si compiono tra le pareti domestiche, in un paese come Israele il cui orizzonte appare dominato dalle forme collettive, politiche, religiose della violenza?
Una decina di anni fa ho iniziato a scrivere partendo dalla consapevolezza che mi volevo occupare della violenza che abbiamo «dentro» (nelle nostre anime, nelle nostre case, nella nostra società). Volevo dimostrare che non si tratta di qualcosa di meno rilevante, o dal significato meno politico, di quella che proviene dall’esterno: la violenza che la cultura israeliana rappresenta abitualmente. I miei personaggi non sono agenti del Mossad o dei servizi di sicurezza come in Fauda – una serie tv molto nota nel Paese, nda -, ma un ufficiale di polizia che si occupa di violenze domestiche, stupri, crimini che si verificano intorno e dentro le nostre case. Anche se non si tratta dei temi affrontati nella maggior parte dei romanzi polizieschi, quali crimini sono più atroci di quelli che colpiscono le persone che ami e ti amano? La violenza non è ancora più crudele e straziante quando proviene da persone di cui ci fidiamo? Del resto, quando amore, violenza e morte si mescolano, inizia la tragedia: da Edipo a Abramo e Isacco e fino a Amleto, i crimini peggiori avvengono sempre in famiglia.

«Tre» appare a tratti come un diario dolente della solitudine: le donne che finiscono nel mirino dell’assassino sono prima di tutto isolate o sole e questo sembra renderle delle prede privilegiate della violenza. Oltre i confini del noir, sta esplorando un territorio che è allo stesso tempo psicologico e sociale?
Mi piace questo modo di descrivere il libro: «un diario della solitudine». Penso che adotterò la definizione… Da quando è uscito mi è stato chiesto molte volte se si tratta di un vero «romanzo poliziesco» oppure no. La mia risposta è che non sono soltanto interessato a raccontare un crimine, bensì ad ascoltare le storie delle persone che hanno a che fare tutto ciò (criminali, vittime, investigatori, testimoni…). Scrivo della società israeliana? Certamente, anche se non in modo diretto, da sociologo. Quello che sto cercando di fare, è raccontare storie di israeliani tra loro anche molto distanti: da questo emerge forse una descrizione della realtà quotidiana del Paese. C’è un detto secondo il quale lo scrittore israeliano dovrebbe essere «colui che si prende cura della casa di Israele». So che molti scrittori l’hanno fatto in passato, ma personalmente non posso, anche perché non credo che esista una «casa» sola. Quindi preferisco essere quello che «sbircia attraverso il buco della serratura delle diverse case israeliane».
Tra i protagonisti del romanzo c’è Emilia, una donna lettone che fa la badante a Tel Aviv. Come per gli abitanti della periferia di Holon – che compaiono in tutti i suoi libri, «Tre» compreso -, lei racconta la normalità dei ceti medi laici e suburbani, come dei «nuovi arrivati»: qualcosa di inedito per la letteratura del suo Paese.
Emilia non è la prima «straniera» di cui scrivo – l’ho già fatto in due indagini di Avi Avraham-, ma è vero che è la prima protagonista non israeliana di un mio libro. Perché ho scelto di scrivere di questo personaggio? Forse perché mi sento anch’io un po’ «straniero» in Israele. O perché, anche se non ne sono così sicuro, penso di conoscere il tipo di solitudine che vive. Più in generale, è vero, non sono interessato a scrivere né dei classici personaggi del poliziesco israeliano, né degli spazi abituali nei quali operano. Voglio raccontare storie e luoghi differenti. A cominciare da Holon, nella banlieue sud di Tel Aviv, dove sono nato e cresciuto. Una zona che da città dormitorio per gli operai si è trasformata in una sorta di periferia residenziale del ceto medio. Un posto normale, dove la presenza degli ebrei ortodossi è scarsa. Un pezzo di Israele in cui non sembra esserci quasi traccia dei simboli che definiscono la nostra mitologia nazionale. Anche se per me è prima di tutto il posto dove vivono le persone che conosco e che amo.
Lei insegna letteratura poliziesca all’Università di Tel Aviv, condivide l’impressione che questo suo ultimo romanzo richiami in qualche modo le atmosfere dei noir psicologici di Patricia Highsmith?
Spero davvero che sia così. Perché, vede, il libro è stato scritto anche grazie alla forte influenza che Highsmith ha avuto su di me. Si tratta di una scrittrice che ho scoperto tardi ma che, con le sue intuizioni, mi ha aiutato a mettere da parte la classica struttura del noir per provare a scrivere qualcosa di molto diverso. Ho cercato di riprendere una delle sue intuizioni: il fatto che non si è mai certi di quale sarà la visuale dalla quale sceglierà di raccontare la storia, rendendo per questo i suoi romanzi così imprevedibili e straordinari.

Anche in Israele ci si sta misurando con la pandemia. Da dove risponde a queste domande e come guarda al futuro in questo momento?
Le sto scrivendo dalla mia casa di Tel Aviv, con mia moglie Marta e i miei due figli, Benek e Sarah, nella stanza accanto. Ci siamo confinati qui nelle ultime quattro settimane e sebbene adori stare fuori, e anche se mi manca il mio ufficio, i miei negozi di libri preferiti, i miei studenti, stare a casa non è un grande prezzo da pagare se lo si fa per la nostra salute e quella degli altri. È una situazione strana. Da un lato si è bloccati a casa – in questi giorni dovevo essere a Parigi per promuovere il mio libro -, dall’altra è come essere in tutto il mondo: leggo i giornali e cerco informazioni su ciò che sta accadendo ovunque. Ecco perché scrivere in un momento come questo è fuori discussione. D’abitudine, per farlo, lascio il mondo fuori dalla mia stanza, a parte gli argomenti di cui mi occupo in quel momento. Ma, adesso, chi può lasciare il mondo fuori dalla sua stanza? Anche leggere non è facile, per le stesse ragioni: come si può chiudersi in un mondo immaginario proprio ora? Ma sono felice di poter dire che ho trovato i libri giusti per questo periodo e sono entrambi di autori italiani, madre e figlio: Le piccole virtù di Natalia Ginzburg e Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg. Stiamo vivendo settimane tragiche, ma con questi libri almeno riacquisti la sensazione che ci sarà – e si spera presto – un dopo.

