Tra i protagonisti della scena letteraria americana fin dalla metà degli anni Ottanta, il suo esordio con la raccolta di racconti «Ballo di famiglia», amaro ritratto delle delusioni della middle-class nell’era degli yuppie, è del 1984, David Leavitt è nato a Pittsburgh nel 1961, è cresciuto in California e dopo una breve parentesi newyorchese e una molto più lunga in Italia, Paese cui è legato profondamente, insegna da diversi anni all’Università della Florida dove dirige la rivista «Subtropics». Tutte le sue opere sono in corso di pubblicazione da Sem che ha anche proposto lo scorso anno il suo nuovo romanzo, «Il decoro».
Sono passati vent’anni dall’attacco a New York: cosa ricorda di quel giorno e cosa ha rappresento per lei, anche sul piano personale, quella tragedia?
L’11 settembre del 2001 mi trovavo in Italia. Avevamo appena ritirato la macchina, che aveva avuto un incidente, da un meccanico di Grosseto e ci eravamo fermati in un bar. Il barista piangeva e parlava della «Torre Gemelli». Ci sono voluti alcuni secondi per capire cosa fosse successo. È stato uno shock terribile al quale, come avviene sempre in questi casi, mi sono però gradualmente abituato. La parte più triste è che da allora credo che la situazione sia andata peggiorando sempre di più. Sono contento di essermi trovato in Italia in quel periodo. I nostri amici italiani non avrebbero potuto essere più gentili. Dato che non avevamo la tv, il proprietario del bar del paesino vicino a casa ci ha permesso di guardare la Cnn nel suo retrobottega. E gli anziani del posto, la maggior parte dei quali aveva vissuto la Seconda guerra mondiale, erano i più tranquilli nella loro gentilezza, probabilmente perché capivano meglio dei giovani cosa significa essere attaccati.

Quando ci penso, con mio grande stupore mi rendo conto che ho vissuto a tempo pieno a New York solo per circa tre anni, quando ne avevo venti. Dopodiché, per altri cinque ho vissuto a East Hampton, che in quegli anni era un piccolo villaggio di campagna popolato principalmente da newyorchesi. Però è stato solo quando sono andato a vivere in Italia nei primi anni Novanta che ho acquisito una prospettiva globale sufficiente per rendermi conto che New York non era il centro dell’universo, o almeno non il centro del mio universo. In effetti, credo che sia soltanto perché non sono rimasto a viverci che oggi sono in grado di scrivere di New York con un certo grado di chiarezza. Per me quella città rappresenta la giovinezza e l’ambizione. Combattere, competere, scalare. Beh, non sono più giovane e sono diventato cinico e mi preoccupo molto dell’ambizione.
Dopo l’11 settembre l’amministrazione Bush e gli intellettuali neoconservatori parlarono soprattutto di un «attacco ai simboli dell’America», un’analisi che almeno in parte sembra tornare oggi per motivare il ritiro dall’Afghanistan con l’idea che «il lavoro laggiù sia finito», ma in realtà per molti nel resto del mondo ad essere stato attaccato era un simbolo di libertà globale: la New York della musica e dell’arte, della scena punk e di quella omosessuale. Come stavano le cose?
All’epoca, la mia sensazione, frutto soprattutto del confronto con gli amici che vivevano ancora in città, era che dopo l’11 settembre New York avesse fatto un respiro profondo, valutato i danni, curato i suoi feriti, pianto i suoi caduti e fosse andata avanti. I punk andavano avanti, i queer andavano avanti, i musicisti andavano avanti, i musical di Broadway continuavano, le sfilate di moda e gli spettacoli di drag e le esibizioni: tutto andava avanti. Proprio come l’Aids avrebbe dovuto distruggere New York, l’11 settembre avrebbe dovuto distruggere New York, eppure la città si è rifiutata di essere distrutta. In parte questo è dovuto al fatto che i newyorchesi sono per natura resilienti. Devono esserlo. La vita in città è troppo difficile per sopravvivere se non sei resiliente. Fran Lebowitz riassume tutto questo molto meglio di quanto io abbia mai saputo fare nella sua recente serie di interviste con Martin Scorsese («Una vita a New York», su Netflix). Ma lei è una vera newyorchese, mentre io ho solo immerso l’alluce nell’Hudson per qualche tempo. Non mi sento di appartenere a nessuna città, Paese, pianeta in particolare. Direi che sono caratterialmente un espatriato. Per me la Florida, dove vivo ora, è un Paese straniero tanto quanto, diciamo, il Portogallo. Ma credo che la maggior parte degli scrittori siano per natura espatriati, anche quelli che vivono nello stesso posto tutta la vita. Per gli scrittori, tutto ciò che è fuori dalla porta d’ingresso è territorio straniero. Per questo, «tutto» è in realtà all’interno della porta d’ingresso.

Per la nuova traduzione di «Ballo di famiglia» (Sem) ha scritto un’introduzione che riflette sul rapporto tra la scrittura e il tempo: «Mi sembra che all’epoca in cui ero giovane (i primi anni Ottanta) le cose accadessero più lentamente. Quando li ho concepiti, quei racconti si svolgevano semplicemente “nel presente”. Da allora ho smesso di credere nel “presente”, o forse dovrei dire che ho smesso di fidarmene». L’11 settembre è spesso evocato come uno snodo decisivo per la comprensione del tempo che viviamo. Anche per lei?
In realtà l’11 settembre non mi ha fatto quell’effetto, forse perché ero molto giovane quando sono avvenuti gli attacchi o perché mi trovavo lontano, in Italia. Ciò che ha davvero distrutto il mio senso di continuità e – peggio – la mia capacità di discernere la verità, è stata l’elezione di Trump e la pandemia che ne è seguita, e che Trump ha reso ancor peggiore. Ricordiamo che l’attacco alle Twin Towers, nonostante tutti i suoi orrori, ha tirato fuori anche il meglio dagli americani. Ricordate le fantastiche immagini delle infermiere che accorrevano a New York da tutto il Paese? E, naturalmente, al culmine della crisi del Covid a New York, sono tornate. Al contrario, gli anni di Trump non solo hanno fatto emergere il peggio nelle persone, ma hanno annunciato quello che temo possa essere un periodo di agitazione che potrebbe portare a un’altra guerra civile nel Paese.
Nel romanzo «I due Hotel Francfort» (2013) racconta la crisi di due coppie in attesa di imbarcarsi per l’America nella Lisbona del 1940. I destini personali di quelle persone si intrecciano con quelli di un’umanità intera che cerca di sfuggire alla guerra. E anche la sua famiglia ha conosciuto la fuga dall’Europa verso l’America. Proprio negli ultimi vent’anni l’identità degli Usa come paese di immigrazione è stata messa di nuovo fortemente in discussione. Cosa ne pensa?
«Dammi le tue masse stanche, povere, ammucchiate che bramano di respirare liberamente». Queste famose righe – tratte dalla poesia di Emma Lazarus «The New Colossus» e che campeggiano sulla Statua della Libertà nel porto di New York, nda – implicano che tutti coloro che cercano rifugio negli Stati Uniti lo troveranno. Eppure non è mai stato così. Altrimenti perché a così tanti rifugiati, ebrei compresi, sarebbe stato negato il visto nel corso del tempo? Anche oggi, se chiedi a qualsiasi emigrato che esperienza sia richiedere un visto americano, si ottengo delle risposte che ti fanno vergognare di essere americano. La realtà è che non vogliamo che ci venga ricordato quanto sia più povero il resto del mondo, e per questo motivo ora mettiamo tanta energia nel non guardare alle «masse ammucchiate» intrappolate in Afghanistan e, più vicino a casa, raggruppate lungo il confine messicano, con i frammenti idioti del fottuto muro dell’ego di Trump. Prima di Trump la xenofobia americana era già un problema, ma con lui è peggiorata così tanto, all’improvviso, che penso che molti di noi hanno smesso di assorbire ciò che stava accadendo, anche se le prove delle atrocità si sono accumulate.

Alla fine del Diciannovesimo secolo e all’inizio del Ventesimo, il West era considerato il luogo del futuro americano. Dal Nord-est, molte migliaia di persone, compresi i miei parenti, sono fuggite a ovest in cerca di una vita e di un’aria più «pulite». In California abbondavano soprattutto le comunità utopiche. Uomini e donne che all’Est avevano lavorato come ragionieri e segretarie si occupavano di raccogliere arance, o acquistavano terreni su cui coltivare arance: così tanti emigrati che alla fine il West divenne ancora più affollato e pieno di smog dell’altra costa del Paese. Fin dall’inizio, la mia bussola psicologica ha puntato invece verso Est, prima a New Haven e Boston – centri consolidati dell’arte e del mondo accademico americano – poi in Europa – rovine romane, rovine greche, Michelangelo, W. G. Sebald – e infine anche molto più in là, in India. Ovviamente l’ironia è che se continui a viaggiare verso Est alla fine ti troverai lì dove sei partito.
Lo scorso anno ne «Il decoro» ha messo in scena l’ipocrisia dell’élite newyorchese che a Trump sembra aver rimproverato più la rozzezza che la politica razzista, qualcosa di simile a ciò che in altri suoi romanzi accadeva con le famiglie progressiste messe in crisi dal coming out dei figli. A far crescere le spinte para-fasciste nel Paese è stata anche la debolezza della cultura progressista che non ha saputo costruire un’altra idea d’America?
Senza dubbio. Inoltre gli sforzi per il cambiamento provocano quasi invariabilmente un contraccolpo. Attualmente le università pubbliche americane, compresa quella in cui insegno, sono nel mirino: alla componente progressista cui appartengo, che cerca riparazione per le ingiustizie passate e nuove politiche per futuro, si contrappongono disparate fazioni reazionarie che hanno trovato nella sinistra un nemico comune verso cui indirizzare il proprio odio. Del resto, non è la prima volta che gli atenei americani sono l’epicentro dello scontro. L’edificio in cui si trova il mio ufficio ha corridoi senza finestre che zigzagano follemente. Come mai? Quando fu progettato nel 1967, all’architetto fu detto di elaborare una planimetria che avrebbe confuso gli studenti al punto che non avrebbero potuto facilmente occuparlo e organizzarvi dei sit-in.
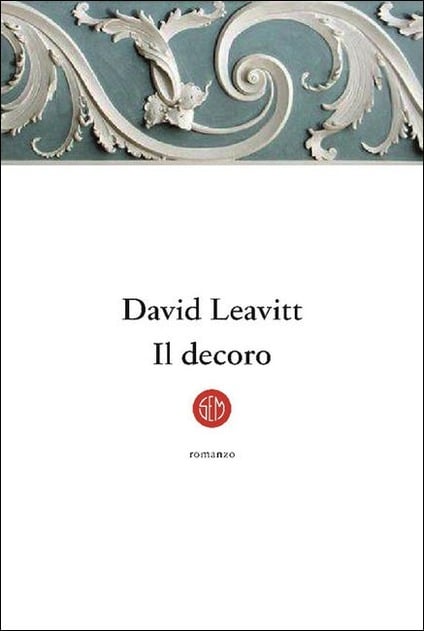
Gli anni di Trump sono stati così traumatici, e uso deliberatamente questa parola, che molti di noi si sono convinti che se solo fossimo riusciti a sbarazzarci di lui i problemi che affliggevano il Paese, e che lui aveva peggiorato – il razzismo istituzionalizzato, l’omofobia, l’odio per le donne, la xenofobia, un’epidemia di malattie mentali esacerbata dalla diffusa della dipendenza dagli oppiacei… – si sarebbero magicamente risolti da soli. Perciò, siamo stati così contenti di sbarazzarci di Trump che dopo la sua sconfitta abbiamo permesso a noi stessi di abbassare la guardia. Il risultato è che ora ci troviamo in un Paese spaccato in due. Se il lato dove mi situo io è il più grande, quello con cui si sono alleati i repubblicani è più arrabbiato e violento. Triste a dirsi, ma l’amore non ha vinto sull’odio, come credevano o speravano i cantanti folk degli anni Sessanta. L’odio è più forte, più appassionato, meno razionale. Gli hater sono disposti a credere a qualsiasi voce che dica loro quello che vogliono sentire. Quelli di noi che rifuggono dalla violenza e dalla rabbia, d’altra parte, sono ragionevoli, razionali. E per questo, temo, siamo destinati a perdere, almeno nel breve periodo.
Anche in reazione alla presidenza Trump si è arrivati alla vittoria di Biden, che lei ha sostenuto. Ora come valuta il modo in cui la sua amministrazione ha gestito il ritiro da Kabul?
Quando Biden ha annunciato il ritiro, ero nel bel mezzo delle ricerche sulle guerre anglo-sikh della metà del 19° secolo per il libro a cui sto lavorando. Anche allora la Russia teneva d’occhio l’Afghanistan, motivo per cui gli inglesi arruolarono i sikh per aiutarli a rovesciare il governo afghano e installare un regime fantoccio. In altre parole, tutto questo va avanti da molto più di vent’anni. Va avanti da quasi due secoli. E sì, come tutte le guerre combattute solo per il territorio è stato tutto vano.





