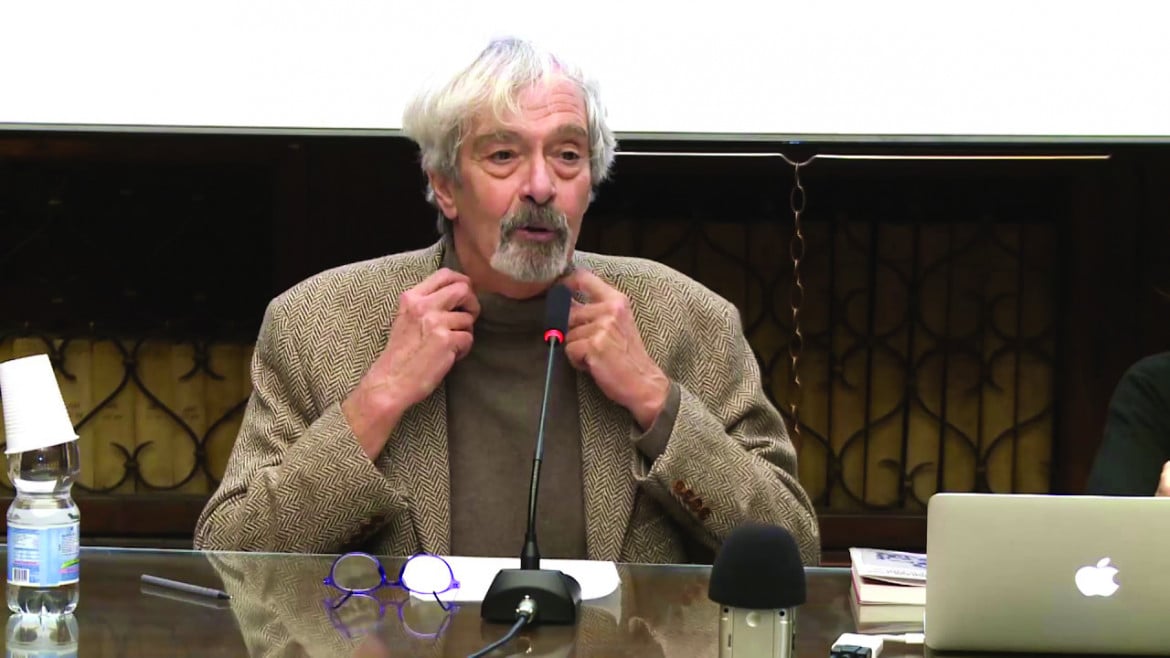Dal virus non nascerà il comunismo ma l’umanità vive un rischio comune
Giorgio Agamben ha pubblicato diverse riflessioni sull’ “emergenza-epidemia”. Ecco le sue domande: come è possibile accettare “in nome di un rischio che non era possibile precisare” che i corpi dei nostri cari siano bruciati o sepolti senza poterli vedere?
E di essere privati della libertà di movimento? Che società è quella che rinuncia alla libertà in nome della sopravvivenza? La sua risposta è che abbiamo rinunciato alla ricerca del bene per paura della morte, e questo grazie a una scienza medica che ha separato vita biologica e vita affettiva. La Chiesa, da parte sua, avrebbe dimenticato che i martiri sceglievano la morte per non rinunciare alla fede. E perché tacciono i giuristi?
Escludo che le domande di Agamben siano rivolte ai malati in terapia intensiva o ai moribondi – come a chiunque tema di ammalarsi e di morire. Non vedo proprio perché la paura della morte debba essere contrapposta, per principio, alla ricerca del bene e del giusto. Con un vero paradosso filosofico, quell’“essere-di-fronte-alla-morte” che Heidegger riteneva confinato alla nostra esistenza individuale, oggi è condiviso di colpo, grazie alla pandemia, con buona parte dei nostri simili.
Ognuno soffre e muore solo, certo, ma oggi ciò avviene potenzialmente insieme al resto dell’umanità. La retorica, quasi sempre dolciastra, sulla bontà, l’abnegazione di infermieri e medici, i canti ai balconi e tutto il resto nasce dall’orrore della solitudine nella malattia e nella morte, e al tempo stesso dalla confusa sensazione di una condivisione globale dell’orrore. E quindi perché dovremmo chiedere ai nostri simili di non avere paura della morte in nome del bene, quando la prima non esclude il secondo?
Sono stato operato poco più di un anno fa di due tumori, di cui uno ai polmoni. Mi hanno salvato e forse guarito. Sono riconoscente ai chirurghi e alla loro perizia. Ma il punto è che, per quanto intubato e sedato, ho sperimentato una comunanza con il personale medico e i miei vicini di letto che non mi aspettavo. Ho avuto occasione di conversare con persone che non avrei mai avuto occasione di conoscere, tra cui un vecchio che aveva lavorato come caruso in una solfatara. Ho assistito agli ultimi giorni di un malato terminale e al terrore di una moglie che non vedeva tornare il marito, dopo dieci ore di camera operatoria.
Esperienze comuni, se si è ricoverati. E sono anche convinto che la gentilezza del personale medico fosse frutto di una buona professionalità, così come il calore tra i degenti occasionale e irripetibile. Ma li ho provati entrambi, e questo mi è bastato per non sentirmi un mero corpo privato degli affetti. Nella nostra vita reale esistenza biologica e affetti non sono così separati da obbligarci a scegliere in condizioni estreme tra il primo e la seconda.
Non possiamo chiedere ai nostri simili di rinunciare alla paura della morte in nome di una libertà teorica. È possibile in un seminario di filosofia, non nel travaglio quotidiano. E comunque, ognuno decida per sé – se sia il caso di scegliere la fede invece della vita, se morire da martiri o vivere da esseri comuni. Ho sperimentato, dal mio letto d’ospedale, che una tecnica medica anonima e spersonalizzante non esclude la sollecitudine per gli altri. Allo stesso modo, in questa fase non siamo privati della libertà, ma di qualche libertà. Una differenza non da poco. Prima di parlare di fascismo nel caso di questo governo – mediocre, non più autoritario di altri – aspettiamo di vedere come evolve l’attuale isolamento. Se non sarà più giustificato, ognuno farà le sue scelte.
Il rischio di cui parla Agamben non era prevedibile in febbraio, quando ha pubblicato il suo primo intervento, ma oggi lo è. Sappiamo di essere potenziali vittime di una molecola che salta di specie in specie e muta a piacimento, nel tempo e nello spazio – ma sappiamo anche che i suoi effetti possono essere amplificati in modo esponenziale dai miserabili calcoli di amministratori, politici e demagoghi. Inoltre, un virus così apparentemente democratico non colpisce tutti allo stesso modo.
Nasce qui un terreno di scontro, politico prima che etico, sul conflitto tra economia e vita, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla protezione dei marginali e dei deboli, sui diritti umani universali.
L’inatteso ci costringa a ridefinire scelte di campo, criteri morali dell’agire, priorità che fino a ieri davamo per acquisite. Dal virus non nascerà il comunismo, come sostenuto nelle stravaganti esternazioni di Žižek. Ma per la prima volta nella storia (a parte la crisi ecologica) l’umanità deve affrontare un rischio comune, e come tale percepito, anche se declinato nelle forme e nei condizionamenti sociali e politici più vari. È del tutto aperta la questione se da tutto questo nasceranno nuovi Trump, Bolsonaro o Orbán o nuove forme di convivenza e di giustizia sociale.
Un terreno su cui incombe un cielo plumbeo, data l’impotenza generata dalla difficoltà delle scelte e dalla nostra debolezza di fronte al rischio. Ma non abbiamo alcun bisogno di martiri, maestri o guide spirituali. Invece, di una reazione umana e solidale al getto di dadi della sorte e alla desolazione che sta provocando nel mondo.