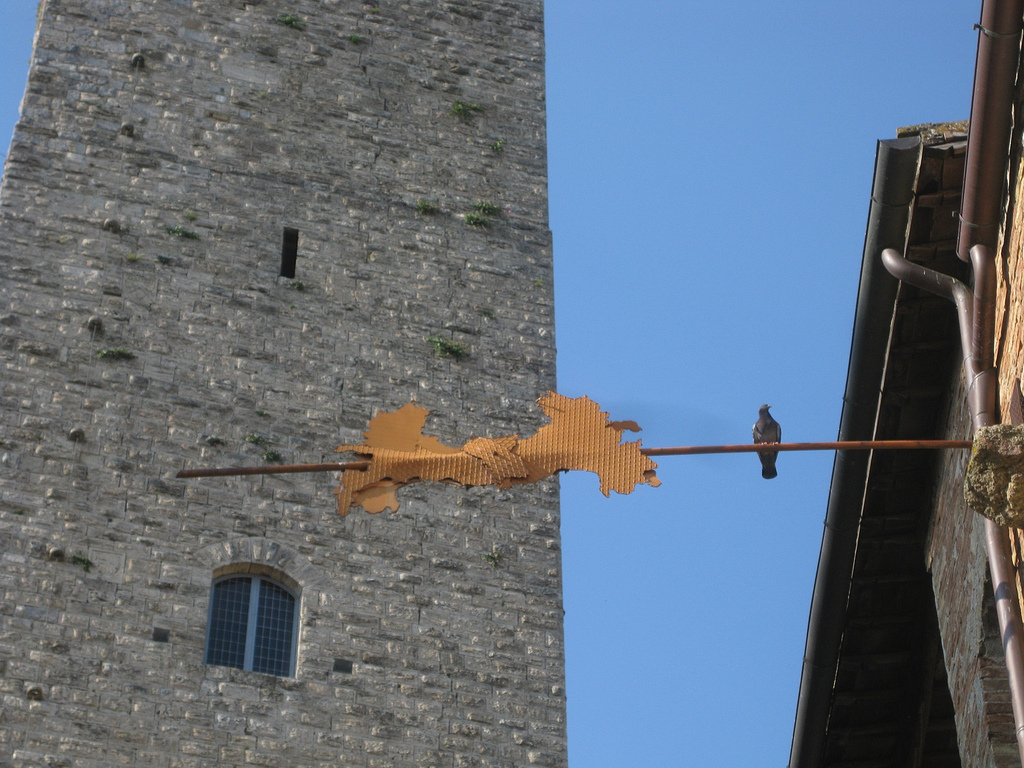Nel tentare di ri-pensare la società italiana si può muovere da una rapida speculazione sull’economia a tre livelli:
- il Mondo, che va;
- l’Europa, che non va;
- l’Italia, un disastro.
Le cose poi risulteranno diverse, ma tant’è. I “maledetti economisti” – come diceva Sergio Ricossa, imperfettista colto – non sanno far meglio…
a) Mondo
Non cessa di stupire che il Pil del globo dal 1820 si sia moltiplicato di 70 volte, di 10 volte pro capite in media. Per questo il capitalismo si è affermato persino a Cuba, mancando solo la Corea del Nord.
Si è affermato sebbene sia tremendamente instabile, iniquo, inquinante. Il progresso produttivo del globo continuerà, a buon ritmo. E’, questa, anche la condizione, sebbene non sufficiente, per limitare con risorse aggiuntive l’instabilità, l’iniquità, l’inquinamento – le tre “i” – che affliggono il sistema.
L’ultima previsione del Fmi vede la crescita del Pil mondiale accelerare dal 3,2% quest’anno al 3,9% nel 2021. Al di là di queste stime di medio termine ad alcuni economisti – Summers, Krugman, Gordon, Enzo Visco da noi – sembra di scorgere una tendenza secolare al ristagno.
Ora, la crescita è – lo insegna Solow – problema principalmente d’offerta: produttività, innovazione, ancor più che di accumulazione quantitativa di capitale. Non è detto – come teme Gordon – che il progresso tecnico nel lungo periodo si attenui. Si pensi solo a quanto l’Ict può ancora dare, o all’auto elettrica e senza guidatore… Fisherianamente, Summers desume dai bassi tassi d’interesse attuali un vuoto di domanda globale, un eccesso tendenziale del risparmio sull’investimento.
Ma i bassi tassi possono essere letti in chiave keynesiana: aspettative di deflazione, nonostante un eccesso d’offerta di moneta. I vuoti di domanda possono essere comunque colmati con l’investimento pubblico sostenuto dalla politica monetaria espansiva.
Nei fatti, il Pil della Cina decelera, sì, al 6%, ma va a sfiorare il 20% di quello mondiale. Il contributo cinese all’economia mondiale non sarà quindi inferiore a quello che la Cina esprimeva quando il suo Pil cresceva del 10%, e tuttavia era pari solo a un decimo di quello del globo.
Un po’ meno del 20% del Pil mondiale continuerà a far capo agli Stati Uniti, che con pragmatismo sanno mantenere la loro economia sul 3% di crescita. L’India – 1,3 miliardi di persone – in termini di Pil si svilupperebbe al ritmo dell’8% l’anno, il Pakistan – altri 200 milioni di persone – del 5%. Persino l’Africa Sub-Sahariana – quasi un miliardo di persone – segnerebbe un tasso di sviluppo del 5%. La brillantezza di queste aree compenserebbe ampiamente la stanca di Russia e Brasile.
b) Eurozona
L’area dell’euro spicca invece in negativo. E’ schiacciata sul trend di crescita più basso, deludente: 1,5%, meno della metà di quello mondiale. Come moneta l’euro è stata e rimane un successo. E’ anche internazionalmente domandata. A frenare l’Europa è, piuttosto, il rigore di bilancio imposto dalla Germania. La Bce è impotente, perché la politica monetaria poco può contro la deflazione, che le è sfuggita di mano nel 2012-2014. Contrariamente a quanto molti in Italia pensano, rigore di bilancio, più neo-mercantilismo, non avvantaggiano la Germania. La svantaggiano. Infliggono ai cittadini tedeschi costi economici pesanti: crescita al 2021 (1,2%) lenta e inferiore al potenziale; cessione di enormi risorse reali al resto del mondo, dato lo spaventoso avanzo commerciale (8,5% del Pil); pressione sul mercato del lavoro e sul welfare esercitata dagli emigranti che non sperano di trovare occupazione e assistenza in Spagna, Francia, Italia, Grecia.
Evidentemente la Germania, se accetta questi costi, persegue fini d’altra natura. Quali? Dopo le due guerre mondiali il popolo tedesco patì sul piano politico, oltre che economico, l’indebitamento nei confronti delle nazioni vincitrici. Si rilegga, fra gli scritti più belli di Keynes, Dr Melchior. A Defeated Enemy. L’essere oggi creditrice può consentire alla Germania di esercitare sugli altri paesi una supremazia politica. Ma ciò stride con l’ideale d’Europa. Sarebbe la morte dell’ideale, che va invece difeso dai populismi, dalla demagogia, dai neo-fascismi, alimentati anche dall’insuccesso economico dell’Eurozona. Non basta piatire dalla Germania, come fa il governo Renzi, qualche decimo di Pil di disavanzo pubblico in più rispetto ai minimi tollerati. E’ in giuoco ben altro. E’ in giuoco l’Europa come costruzione politica. Non a caso gli inglesi ipotizzano l’uscita, nonostante i possibili costi economici. Semplicemente, il loro storico orgoglio non accetta la supremazia politica altrui.
c) Italia
La crescita prevista dal Fmi per l’Italia al 2021 è dell’1%. E’ la più bassa d’Europa. La radice dei mali italiani è quindi interna, anche se il rigorismo tedesco li accentua.
L’economia è fiacca dal 1992, quando la lira crollò. Dal 2007 al 2014 il Pil è caduto del 10%, la produzione industriale del 30%. La domanda globale non si riprende. Il progresso tecnico è spento. Le imprese innovative sono una sempre più rara eccezione. Il Mezzogiorno rischia la desertificazione produttiva, con gli investimenti precipitati del 60% e il ritorno dei meridionali all’emigrazione di massa (750mila persone da inizio secolo, al netto dei rientri). Nel 2007 pubblicavo un libro sugli italiani intitolato Ricchi per sempre?, con il punto di domanda. Dieci anni dopo la risposta all’interrogativo purtroppo è…no!
Quattro fasci di forze – economiche – hanno interagito in modo perverso, abbattendo la produttività: la finanza pubblica, squilibrata; le infrastrutture fisiche e immateriali, inadeguate; gli stimoli concorrenziali, scaduti; i profitti troppo facili e troppo a lungo, ai massimi storici dal 1993 al 2005: una droga anestetizzante.
Sul trend declinante ventennale impresso alla produttività da questi quattro fasci di forze si sono innestate le due recessioni nell’insieme più profonde della storia patria. Quella del 2008-2009 fu da esportazioni, e quindi da investimenti, in un’economia giunta poco competitiva alla caduta ciclica del commercio mondiale. Quella del 2012-2014 è stata da consumi, e quindi da investimenti, per gli eccessi con cui il governo Monti attuò la restrizione fiscale voluta dall’Europa e solo in certa misura necessaria.
d) Oltre l’economia
La decadenza dell’Italia ha queste cause prossime d’ordine economico. L’economia si riprenderebbe, se si riequilibrassero le pubbliche finanze frenando gli sprechi e contrastando l’evasione; se le risorse di bilancio così risparmiate venissero rivolte a investimenti in valide infrastrutture; se la concorrenza sollecitasse le imprese alla produttività; se le imprese rispondessero agli stimoli concorrenziali, in un contesto reso più favorevole. Gli investimenti pubblici sarebbero decisivi. Possono potentemente sostenere sia la domanda – il moltiplicatore è ben superiore all’unità – sia la produttività delle imprese.
Una colpa storica dei governi Monti, Letta, Renzi è di averli tagliati del 20%. Se il governo attuale avesse volto in opere pubbliche un punto di Pil – anziché dissiparlo in sgravi ad alcune famiglie e ad alcune imprese – quest’anno l’aumento del prodotto sarebbe del 2,5% circa, invece del misero 1% su cui convergono le previsioni. Ma gli eventi favorevoli appena evocati non si realizzano.
Cosa lo impedisce? Qual è il perché dei perché della mancata risposta delle imprese, dei governi, degli italiani al declino? Le forze economiche – con il loro segno positivo o negativo – a propria volta si situano in uno strato più profondo del corpo sociale. La ricerca recente le riconduce a una triade di determinanti: istituzionali, politiche, culturali. Sulla scia di storici come Cipolla, North, Landes, Mokyr, Eric Jones hanno iniziato a capirlo gli stessi economisti teorici. Cito Morishima, Coase, Acemoglu fra coloro che hanno varcato i confini dell’analisi economica per spiegare lo sviluppo del Giappone, della Cina, del mondo. Su un terreno non suo, l’economista dev’essere prudente. Pure, non può esimersi dall’avanzare almeno delle ipotesi sul corpo sociale e sullo Stato.
e) Carenze istituzionali
In Italia a mio avviso le carenze istituzionali investono un ordinamento giuridico tuttora arretrato su troppi fronti: societario, fallimentare, processuale, amministrativo, della concorrenza, del risparmio. Le linee di riforma sono parziali e disorganiche.
Incertezze si estendono ai conati di modifica centralistica, se non antidemocratica, della Carta Costituzionale e della legge elettorale.
f) Scissione eletti ed elettori
Sul piano politico lacerante è la scissione tra eletti ed elettori. E’ saltato il legame fra loro che l’art. 49 della Costituzione assegna ai partiti. Questi stentano sempre più nel «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». I partiti dovrebbero rifondarsi: nei fini perseguiti, nella moralità, nell’organizzazione, nelle forme di finanziamento.
I cosiddetti movimenti e le forme sporadiche di democrazia diretta non possono bastare. Urge un superamento delle fazioni. Bisogna tornare a formazioni politiche capaci di mediare e di riscuotere larga accettazione delle misure politiche ed economiche di fronte a emergenze quali quella che l’Italia vive. Non a caso il metodo elettorale dal dopoguerra è stato a lungo proporzionale. I maggioritari, le alternanze di governo, gli “uomini soli al comando” in Italia non hanno mai funzionato.
In questa terra, da secoli divisa, la fazione vincente prevarica. La fazione perdente, certa di essere prevaricata, non accetta la sconfitta, reagisce. Non bastano un duca Valentino e il suo «miglior modo di ammazzare Vitellozzo Vitelli».
E’ comunque opportuno tornare a riflettere sul perché connubi, coalizioni, compromessi si siano resi nella storia dell’Italia contemporanea necessari.
Anche l’economia è andata meglio con Cavour e Rattazzi, con Depretis e ancor più con Giolitti, con la D.C. e associati, piuttosto che con Crispi, Mussolini, Berlusconi. Comunque, la vera unità nazionale e la tenuta del Paese non possono restare affidate soltanto ai collanti rappresentati dai sistemi pubblici pensionistico e sanitario, fondamentali conquiste.
g) La cultura
Vi è, infine, il terreno più scivoloso, la cultura. Ogni idea su cosa e come produrre equivale a conoscenza, orientata anche alla tecnica. Gli italiani di oggi hanno studiato più a lungo di quelli di ieri. La cultura italiana di punta resta di alto livello.
Persistono, tuttavia, residui di uno iato che affonda nel passato. Nel dire sempre attuale di Giulio Bollati lo iato tende a «separare l’homo italicus dall’homo oeconomicus»: una sorta di «opposizione fra cultura italiana e mondo reale moderno».
Difetta ancora nella cultura italiana l’accettazione delle virtù borghesi, cantate da Marx. Nella bourgeois dignity e nella sua sana retorica – lo sottolinea un altro storico, la McCloskey – è da ravvisare uno dei presupposti dello sviluppo capitalistico attraverso l’innovazione e il progresso tecnico. La retorica va intesa come attitudine a persuadere con i migliori argomenti, non come tecnica del discorso ornato.
Aveva ragione il non-economista Umberto Cerroni: «La riforma più urgente è oggi quella di inserire a fondo la cultura nel tessuto dell’attività produttiva (…). Senza una grande immissione intellettuale nell’attività produttiva non potremo adattarci ai nuovi standards tecnici e non potremo reggere la concorrenza».
E’ un compito tanto arduo quanto ineludibile: per i governanti, le imprese, la società civile, istituzioni come la Treccani. Al di là del rapporto fra “scienze fisiche” e “scienze morali” – come pure fra le ricerche congiunte delle diverse “scienze fisiche” – all’interno delle stesse “scienze morali” è già emerso quanto sia stata fertile l’interazione fra storia e teoria nell’analisi della “ricchezza delle nazioni”.
Un importante esempio più specifico riguarda l’esigenza che il rapporto fra diritto ed economia sia reso stretto. Dev’esserlo in forme originali, che non scimmiottino le versioni spinte della law and economics anglosassone alla Richard Posner – prima della sua recente, tardiva conversione a un Keynes mal digerito.
Semmai sono più equilibrate le versioni di James Hurst o di Guido Calabresi. La cultura giuridica della Penisola è da sempre ammirata, sin dal diritto dei romani, dei glossatori, dei commentatori.
La cultura economica italiana ha un pregio raro, anche se sottovalutato: è varia, articolata, non appiattita sull’ortodossia neoclassica, che pure non ignora.
Avvicinare economia e diritto, coglierne le potenziali sinergie, configura un’opportunità specialmente preziosa nel contesto italiano.
h) La ricostruzione
La conclusione è che la classe dirigente dovrebbe muovere nel quadro europeo da una nuova concezione dell’Italia, come avvenne al tempo della ricostruzione post-bellica nel quadro occidentale. C’è ancora una volta da ricostruire la casa comune, ben oltre l’economia.