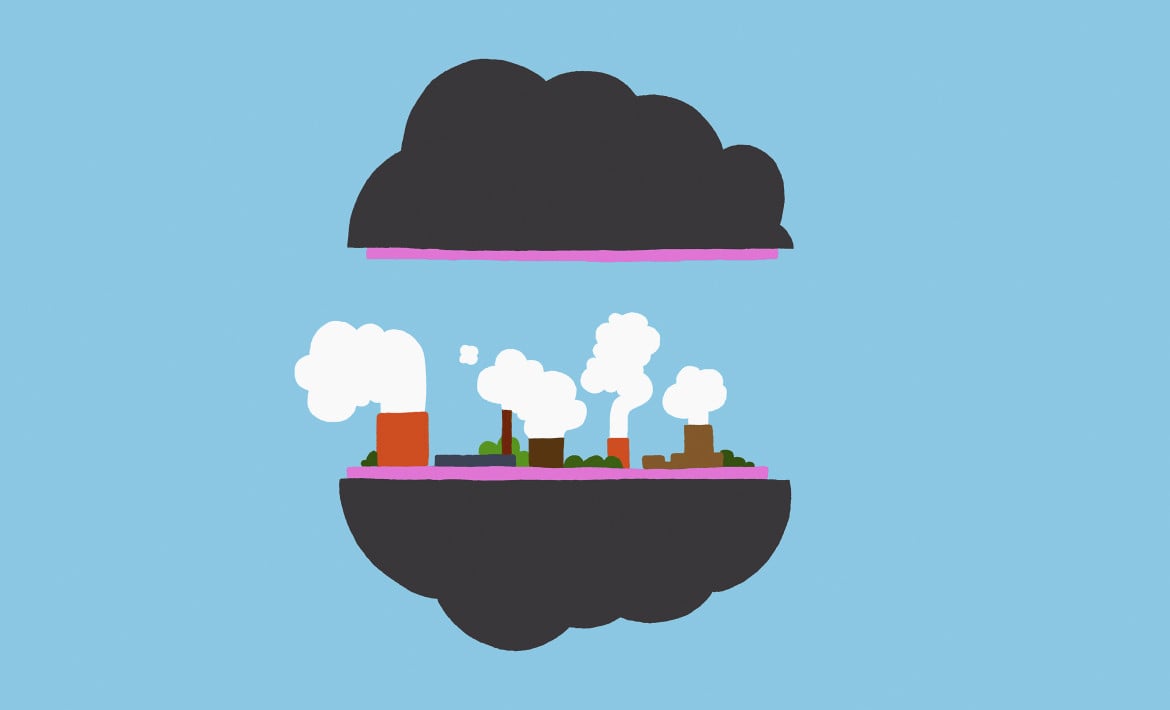Nel dibattito politico italiano sta tenendo banco da alcune settimane, ossessivamente, il tema delle cosiddette «clausole di salvaguardia» presenti nel bilancio dello Stato e la necessità di una loro «sterilizzazione».
Questione importante, per carità. Un aumento di due punti dell’Iva avrebbe certamente effetti recessivi sulla nostra economia, peraltro già fiacca e riluttante.
Nessuno dice, però, che gli stessi effetti recessivi si potrebbero avere rispettando fino in fondo gli impegni con Bruxelles, ovvero tagliando la spesa pubblica o aumentando le tasse per gli importi corrispondenti: 12,4 miliardi quest’anno, 19,1 miliardi l’anno prossimo.
Una cifra notevole, pari al 67% dell’intera spending review – taglio alla spesa per servizi, per la protezione sociale e gli investimenti pubblici – operata dai nostri governi dal 2009 al 2016, per consolidare i conti pubblici, ridurre il debito, uscire dalla crisi (austerità espansiva).
Come è andata? La ripresa è stata (ed è) debole, mentre il debito è cresciuto oltremisura, sia in termini assoluti, che in rapporto al Pil. In compenso, è aumentato l’avanzo primario e con esso la povertà degli italiani (5 milioni sono quelli in povertà assoluta secondo l’Istat). Lo Stato, al netto degli interessi sul debito, continua ad incassare dai cittadini molto più di quanto spende per loro, per i loro bisogni, ma i benefici per i conti pubblici sono pressoché inesistenti. «Da ciascuno più di quanto possa dare, a ciascuno meno di quanto abbia bisogno», si potrebbe dire, rovesciando, ironicamente, la celebre frase di Karl Marx, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita.
Nel 2009 il debito pubblico era il 116% del Pil, ora è il 130%, con una spesa per interessi che nel decennio ha superato gli 800 miliardi di euro. Questo, nonostante nello stesso periodo la spesa per la sanità, la scuola, la previdenza, l’assistenza, gli investimenti pubblici sia scesa di circa 50 miliardi di euro.
Come si spiega? Con gli effetti recessivi delle politiche di austerità, solo parzialmente mitigati dall’aumento delle esportazioni (ora anch’esse minacciate dall’aumento dell’Iva). La matematica non è un’opinione: col denominatore (Pil) che scende, anche se il numeratore (debito) rimane stabile, la percentuale aumenta. Figuriamoci, poi, se il denominatore scende (o rimane basso) e il numeratore aumenta, come è accaduto in questi anni, per via degli interessi passivi e di alcune spese straordinarie, come quelle per i salvataggi bancari.
E’ un problema di debito o di crescita, allora? Stando alla caduta del Pil in termini reali (al netto dell’inflazione) dal 2007 ad oggi, la risposta non può che cadere sulla seconda opzione. Pensare di ridurre il debito continuando a tagliare la spesa pubblica è una follia, meglio puntare sulla crescita e, parimenti, su una ragionevole crescita dell’inflazione (da solo il quantitative easing non basta), stabilizzandolo, rendendolo sostenibile, anche in rapporto alle soglie previste dalle regole europee.
Il vero tema, perciò, non è se morire di Iva al 25% o di tagli alla spesa pubblica nell’ordine di 30 miliardi (quella dei «tagli agli sprechi» è solo retorica). Piuttosto, quello di ribaltare la logica che ha ispirato in questi anni il ricorso alle «clausole di salvaguardia»: firmare cambiali per restare nei parametri del patto di stabilità, anche se questo comporta dei pregiudizi per l’economia e per i cittadini.
Per i prossimi anni non si prevedono balzi in avanti per la nostra economia. Tutte le stime più recenti, a cominciare da quelle del governo, parlano di un rallentamento della crescita già a partire da quest’anno. Una crescita debole che, per di più, rallenta, dunque, complici anche le tensioni commerciali su scala globale (guerra dei dazi). Basterebbe questo per spostare il discorso sulle conseguenze delle politiche di rigore, anziché attardarsi sul come e sul quando trovare i quattrini per impedire l’aumento automatico dell’Iva e di altre accise.
Più che un governo per «disinnescare le clausole di salvaguardia», servirebbe un governo che le mettesse decisamente in discussione. Ma ora è il momento dei «sovranisti», o no?