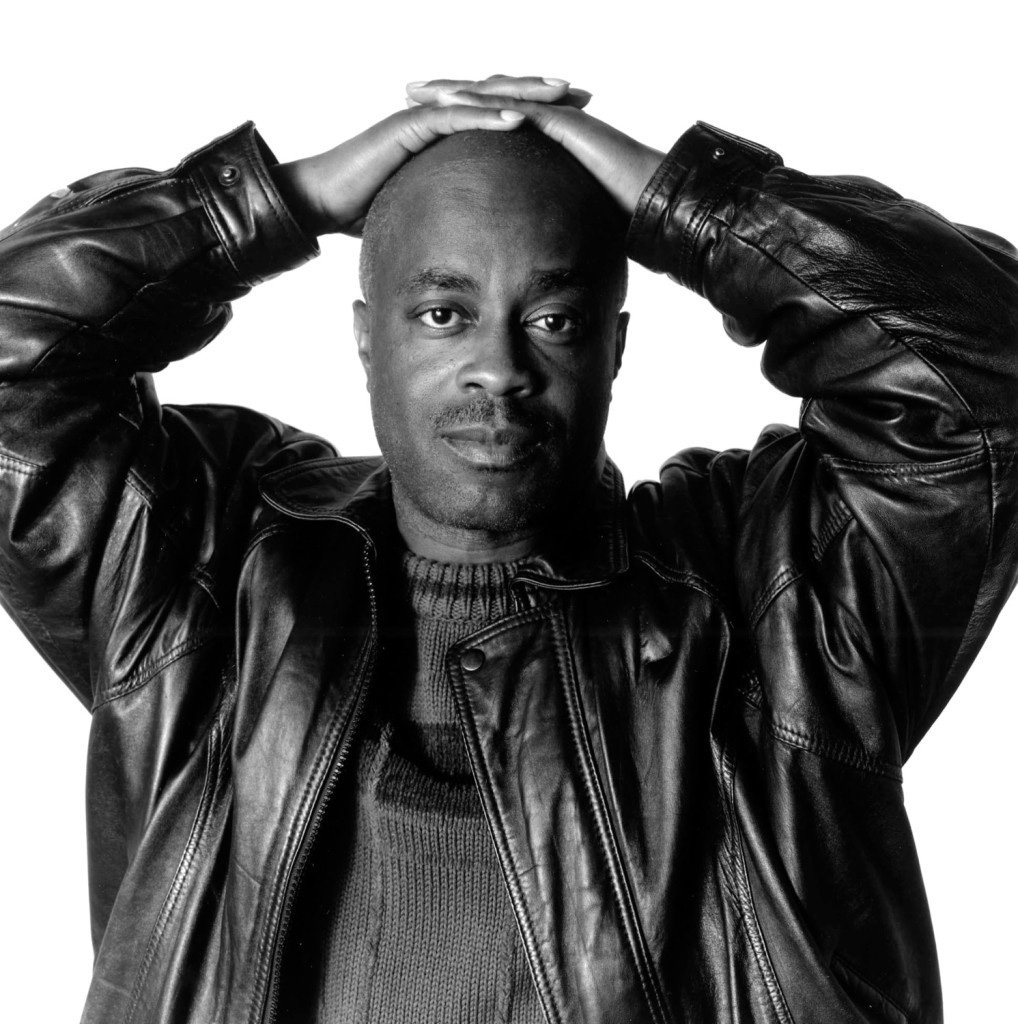Tutto comincia negli anni Sessanta, dalle marce di protesta vincenti, dalle rivolte, dai leader assasinati come Martin Luther King e Malcolm X. È allora, più o meno, che Charles Burnett, ragazzo del sud cresciuto nel ghetto nero di Los Angeles arriva all’UCLA, il campus d’eccellenza californiano, facoltà di cinema e televisione, dove incontra altri giovani african american che con lui condividono il desiderio di raccontare la propria storia in modo indipendente.
Haile Gerima, Julie Dash, Larry Clark insieme a Burnett diventeranno protagonisti di una nuova onda di cinema a improvvisazione controllata, invenzione dell’ arte recitativa, e soprattutto libertà dagli stereotipi per una nuova, imprevista, immagine degli african american radicalmente politica nelle sue scelte estetiche e narrative. Una libertà che il mercato non perdona relegandoli all’esclusione, dimenticando ancora oggi, in epoca di Oscar african american quanto sia stata preziosa. Forse anche perché troppo «di classe».
Incontro Charles Burnett a Parigi, nei giorni del festival Cinéma du Reel, che gli ha dedicato una retrospettiva.
Cominciamo dall’inizio, dagli anni all’UCLA.
Era un posto fantastico, all’epoca vi potevano avere accesso tutte le classi sociali, c’erano molti african american, il mix era molto interessante. Non si facevano film con degli obiettivi commerciali e nemmeno con l’idea di prepararsi una via d’accesso a Hollywood. Allora – siamo negli anni Sessanta, ndr – il sistema degli Studios era completamente chiuso ai registi african american indipendenti, o ai film con protagonisti neri a meno che non rientrassero nei codici della black exploitation. Fare cinema per noi studenti african american era una presa di posizione politica e personale. Il responsabile del corso, Eliseo Taylor, una figura che è stata per me importantissima, aveva avviato un dipartimento di Etno-Comunicazione con un programma che cercava di coinvolgere gli african american, gli ispanici, i nativi americani, gli asiatici. Io ero uno dei suoi assistenti in quel gruppo, l’obiettivo era costruire con gli african american un racconto della comunità. I risultati sono stati molto positivi: tutti i partecipanti al corso cercavano di smantellare l’immagine dominante degli african american, falsa e negativa, promossa da Hollywood. Oltre a questa tendenza anti-hollywoodiana però, l’aspetto più importante era il tentativo di raccontare la propria storia inventando al tempo stesso una forma estetica personale in cui tradurla.
Nel tempo il suo rapporto con Hollywood non è cambiato.
Il problema principale è che a Hollywood vogliono sempre imporre la loro visione sulle tue storie anche quando non conoscono la realtà che stai raccontando. È la tipica arroganza di chi ha potere. Così se i tuoi personaggi non corrispondono al loro stereotipo ti dicono che non sono «neri abbastanza» o che il loro linguaggio «non è reale» quando mancano droga o criminali. E se gli fai notare che la realtà non corrisponde alla loro idea lo prendono come un attacco personale. Nessuno degli story editors o produttori esecutivi hollywodiani ha avuto rapporti con la comunità african american, però vogliono che la sua immagine soddisfi i desideri del pubblico bianco. Ricordo che ai tempi di To Sleep with Anger (1990) un tizio mi ha detto: «Non credevo che i neri avessero la lavatrice». Da cosa prendesse questa sicurezza non è dato saperlo. Se non che noi dobbiamo essere poveri e sporchi, gangster e prostitute. Un elemento reale nella loro visione appare come irreale.
Oggi però un regista african american ha vinto l’Oscar – Barry Jenkins con «Moonlight» – mentre Hollywood dopo la polemica dello scorso anno sull’ «Oscar troppo bianco» ha cercato di rispondere nel segno del «politicamente corretto».
È sempre una questione mediatica. I neri vincono l’Oscar e così ci si sente più tranquilli a Hollywood ma quanti nativi sono arrivati sul tappeto rosso dell’Academy? O quanti ispanici? Il punto non è questo, anche perché non possiamo ridurre il problema alla sola opposizione di «bianchi» e «neri». La questione principale è sempre di classe. Oggi la maggior parte degli african american non ha accesso all’istruzione perché costa troppo, questo significa la crescita senza alcuna educazione di una grossa parte della popolazione americana che non avrà accesso a un lavoro dignitoso quindi che è condannata alla schiavitù. I neri vengono uccisi dalla polizia spesso senza una ragione ma i poliziotti sono sempre giustificati perché i neri sono violenti e pericolosi pure se disarmati. In molti nella comunità african american vorrebbero andare via dal Paese, sempre di più parlano della possibilità di andare in Africa … Il razzismo rispetto agli anni Sessanta è forse minore, almeno in certi Stati, ma il problema rimane quello sociale, la divisione tra ricchi e poveri. E gli african american sono per lo più poveri in un sistema come quello americano che è basato sulla classe. Prendiamo l’assistenza medica: i poveri, di qualsiasi appartenenza, non hanno la possibilità di essere curati. Obama con l’Obamacare, la riforma sanitaria, aveva cercato di offrire anche ai più deboli un’opportunità. Ma Trump, garantendo gli interessi di multinazionali e medici da sempre sostenuti dai repubblicani, l’ha subito cancellata. Ai poveri si chiede di pagare le tasse, i ricchi pagano molto meno di quello che dovrebbero e però impongono la privatizzazione ai beni che dovrebbero essere per tutti come l’istruzione. Lo stesso vale per il sistema giudiziario che è molto pesante con i poveri e rende possibili situazioni paradossali. Si finisce in prigione, all’ergastolo persino, anche se si è innocenti ma poveri e non bastano a salvarti nemmeno gli avvocati. Inoltre la middle class sta sparendo e mi chiedo cosa accadrà quando i servizi saranno completamente automatizzati.
Rispetto al racconto della comunità african american che lei ha fatto negli anni Settanta cosa è cambiato?
Le conquiste di quegli anni, e del decennio prima, sono andate perdute. Si deve combattere di nuovo il razzismo, la violenza della polizia, si deve lottare per sopravvivere perché se non hai un lavoro, come molti nella comunità, come fai a essere indipendente? A South Central Watts, c’è la più alta concentrazione di inquinamento chimico della California, la gente vive nella malattia. Tutto è chimico, a cominciare da cibo, sul quale i repubblicani speculano massacrando la salute di chi è costretto a comprare alimenti a poco prezzo.

Come si è posta in queste elezioni la comunità african american?
Hanno votato Hillary Clinton, anche se in diversi stati i repubblicani hanno fatto di tutto per impedire che gli african american votassero per i democratici, approfittando ad esempio del fatto che molti hanno lo stesso cognome. Così se qualcuno che si chiama «Jackson» e era in prigione, provavano a far risultare che un altro Jackson aveva già votato e via dicendo.
Lei pensa che i democratici dovevano puntare su un altro candidato?
Sono convinto che la scelta di Hillary Clinton è stata la migliore possibile anche se lei, politicamente, viene identificata con l’establishment: è democratica ma è molto conservatrice. Per quanto riguarda Bernie Sanders, è stato una novità nella campagna elettorale, e il suo risultato ha sorpreso un po’ tutti specie perché è riuscito a conquistare molti giovani. Però da presidente sei obbligato a un confronto con le istituzioni, le corporazioni, e credo che lui in questo senso avesse dei limiti. Anche Obama nel suo staff aveva persone politicamente molto conservatrici.
Perché è stata possibile secondo lei la vittoria di Trump?
In parte, come sappiamo, grazie al sistema elettorale americano. Molti, i bianchi, hanno votato per interesse, altri per paura, si sentono minacciati economicamente, pensano che l’America sia debole, che abbia bisogno di proteggersi da invasioni di ogni tipo.