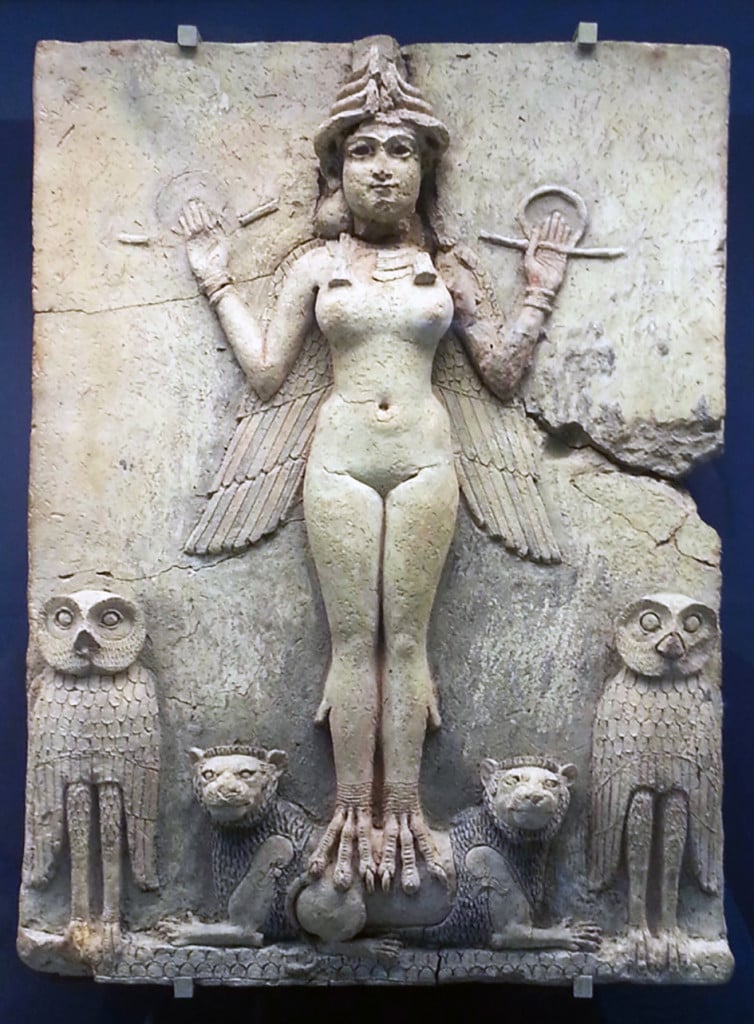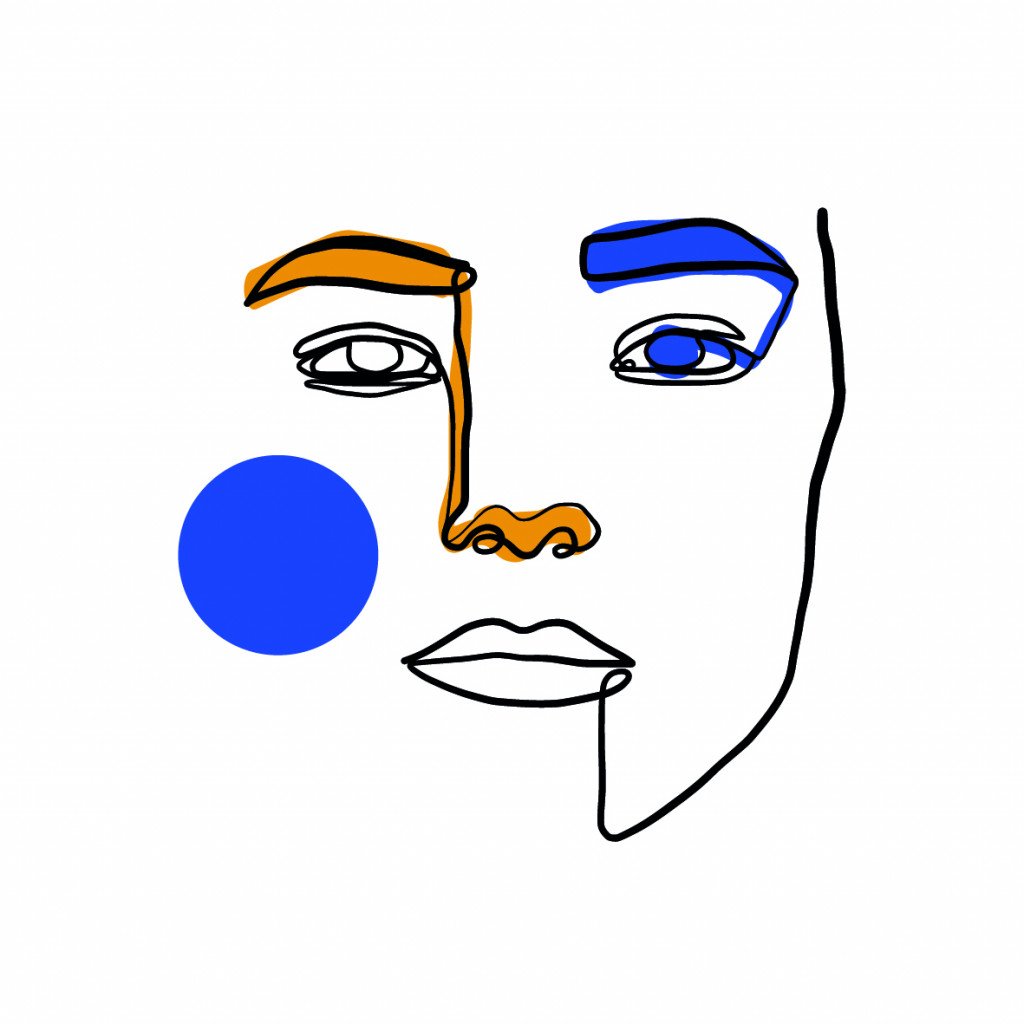Dei primi giorni della quarantena in Italia mi restano intatte le mail lunghe che ho scambiato con le amiche e gli amici più cari. E i messaggi. La memoria invece, quella che cura i traumi con la dimenticanza selettiva, ha reso i primi giorni di marzo un ammasso nebbioso di terrori originari e di chiamate ossessive e ripetute alla mia famiglia bergamasca.
Ricordo come di un’era lontana l’aver passato buona parte delle ore notturne senza pace, alla ricerca di informazioni statistiche attendibili che ponessero quei terrori su un piano meno personale e a cui potessi appigliare elementi di ragione. Invano.
A nulla è valso il fatto che a Parigi le ritmicità della città quotidiane continuassero a ripetersi. E che nessuno mi sembrasse allarmato. Doveva essere il 12 marzo, percorrevo lo scambio alla Gare Montparnasse. Tutto attorno a me si presentava come il giorno precedente e come tutti i giorni che lo avevano preceduto. Il fatto che un altrove vicino, il mio altrove vicino, fosse già in stato d’emergenza – un’emergenza vitale – mi fece perdere l’equilibrio. La vertigine del risucchio del mio mondo di prima, del mio altrove vicino, ebbe la meglio sulle mie gambe.
Questo stato di stordimento fisico da quel momento in poi ha iniziato a lasciare spazio a un posizionamento posturale nuovo, la variazione di un “passo a due” tra due mondi – che avevo già imparato a ballare da quando avevo lasciato l’Italia per la Francia.
*
“Perché il governo francese, assistendo a ciò che avviene in Italia, non agisce d’anticipo?”
Nelle prime settimane di marzo questa domanda, nella sua genericità, era l’unica che riuscissi a formulare.
Il mio altrove vicino ha dominato ogni formulazione, razionale e emotiva. I mille chilometri che separano Parigi dal lago d’Iseo hanno assunto la grevità della distanza reale, quella a misura d’uomo, dei piccoli passi umani – quella che l’alta velocità del tgv verso Milano, figuriamoci l’aereo, non riesce a rendere. Ho sentito come mai prima la consistenza dei confini di stato e la responsabilità della scelta di vivere in un altrove che non sia il paese dei propri affetti familiari. L’esilio volontario ha assunto il peso della lontananza imposta. Ad esso è seguita la consapevolezza che la distanza che avevo scelto di darmi poteva ora raggrumarsi, tutta d’un colpo, nell’impotenza di assistere i miei cari. Ma il senso di perdita definitiva e d’impotenza solitaria stava lentamente lasciando spazio a una rinnovata risorsa relazionale, la vulnerabilità.
Mi sono ricordata di un libro di Wanda Tommasi intitolato Ciò che non dipende da me. Vulnerabilità e desiderio nel soggetto contemporaneo (Liguori editore, recensito sul manifesto il 3 febbraio 2017).
Dalle pratiche femministe ho imparato quanto l’esperienza della vulnerabilità sia costitutiva del soggetto e la soggettività sia dipendente dall’esterno e quindi interdipendente. Quando si abbandona l’illusione bieca di un’autonomia del sé, l’esperienza della vulnerabilità consente di sentire insieme alle proprie trafitture anche quelle del vivente.
*
Il progredire dell’epidemia in Francia si è accompagnato ai primi segnali d’interesse reale per quello che stava succedendo in Italia. Con l’arrivo delle notizie e delle immagini italiane alcuni conoscenti transalpini, sapendo che sono nata in provincia di Bergamo, domandavano il mio punto di vista sulle ragioni del sovrannumero dei contagi e delle morti. Settimane fa, pur in preda allo sgomento per quanto avveniva a Bergamo e le sue provincie, rispondevo ipotizzando ragioni di responsabilità – anche quelle indirette – per quanto stesse succedendo. Allora come oggi poco mi convincono quelli che additano cittadini colpevoli e sciagurati, poco inclini alle regole. Oggi più di allora sono convinta che la produttività esasperata e la difficoltà di fermarsi camminino insieme, ma l’una sia causa dell’altra, e che di certo il peso delle responsabilità di chi promuove l’una non equivalga a quelle di chi subisce l’altra.
*
Il 10 aprile Les pieds sur terre una trasmissione radiofonica curata da Sonia Kronlund di France Culture ha dato voce a Mireille e a Vincent, una cassiera bretone e un corriere parigino. La trasmissione, intitolata Journal de non-confinement: une cassière et un livreur, riporta i loro diari telefonici raccolti nella settimana dal 23 al 28 marzo. Insieme alla frustrazione e alla paura quotidiana che traspaiono nei dettagli di una routine lavorativa stravolta, dichiarano entrambi di sentirsi abbandonati a loro stessi. Nel caso si rifiutassero di continuare a lavorare temono infatti di non aver diritto, per questioni contrattuali, a un indennizzo statale.
La Francia del confinement è spaccata in diverse realtà. Quella di Parigi e degli arrondissements residenziali, quella della Francia rurale, delle grandi città francesi come Marsiglia o Lione, del Grand-Est (tra i primi focolai epidemici), dei départements d’Outre-mer, della popolatissima Île-de-France con le specificità delle banlieues e in particolare quella di Seine-Saint-Denis. La saturazione dei servizi ospedalieri di quest’ultima è già in atto da almeno due settimane. Le misure di contenimento del contagio sono più complesse a causa delle condizioni abitative, la precarietà lavorativa e il lavoro sommerso. Senza la tutela dell’indennità di disoccupazione non tutte e tutti possono fermarsi e il rischio di contaminazione diventa inevitabile.
Da una parte le confinate e i confinati, con urgenze che restano diverse e in relazione al rapporto di genere che esiste con la nozione di spazio domestico e al portato della domesticità. Il lavoro domestico, con i suoi attributi di servizio alla persona e di riconoscimento subalterno, avvicinano una parte all’altra: quell’altra parte di coloro che devono uscire per fornire determinati servizi e mettersi in pericolo in modo da poter soddisfare le esigenze altrui. La crisi sanitaria sta rendendo visibili coloro che, nel funzionamento sociale, sono normalmente invisibilizzate e invisibilizzati. E che ora non sono confinati ma sono esposte e esposti al contagio. La società, quasi ferma, pur dicendo di limitarsi alle sue funzioni essenziali, espone coloro che si prendono cura delle nostre necessità. Il fatto che ora ci si renda conto che una porzione della popolazione esca di casa quotidianamente per fornire determinati servizi e si metta in pericolo per poter soddisfare le esigenze e le necessità di tutti gli altri, risolleva i nostri sguardi sui loro corpi. Essi stessi, non adeguatamente retribuiti e mal protetti, raccontano ad alta voce che esistono almeno due mercati del lavoro, con regole, privilegi e valorizzazioni diverse. Questa crisi sanitaria sta gettando luce sulle disuguaglianze e le opacità del mondo del lavoro e sulla mancanza di tutele, entrambe sofferte da decenni.
Una delle tante infermiere dell’Istituto geriatrico milanese cosa racconterebbe a tal riguardo della situazione italiana?
*
La filosofa e sociologa Dominique Méda, su “L’ Humanité”, il 9 aprile spiega come le donne precarizzate e di origine immigrata sono state mobilitate, in particolare da grandi società di distribuzione o di consegna ma anche in tutti i settori della cura all’individuo. Una delle prime “misure di rottura” del dopo epidemia per Méda sarà quella di rivalutare la gerarchia sociale dei mestieri.
Ripensare alla gerarchia entro cui piazzare le proprie necessità, fare la cernita tra le fondamentali e quelle che sono iscritte nella logica della dote acquisita del benessere accessorio, potrebbe liberare lo spazio mentale che serve per riattivare le nostre capacità immaginative. Quelle inscritte nel pensiero utopico e quelle che vogliono narrare di nuove pratiche di relazione e d’interdipendenza del vivente.