Non dovrebbe sorprendere che l’opera critica di un poeta novecentesco superi anche di molto per ampiezza quella in versi. È almeno dal 1996, quando apparvero i ponderosi «Meridiani» dei saggi di Montale, che siamo abituati a riservare lo spazio maggiore sullo scaffale di un autore contemporaneo ai volumi di articoli e recensioni invece che ai libri di poesia. Ciononostante, saranno pochi – tra gli stessi specialisti – quelli risparmiati da un moto di stupore o da una punta di scetticismo davanti alla mole delle Prose critiche di Giorgio Caproni, uscite per l’editore Aragno di Torino, a cura di Raffaella Scarpa e con una prefazione di Gianluigi Beccaria (4 tomi, pp. LXVI-2168, e 150,00). Finora infatti di quella vastissima produzione erano noti gli articoli raccolti nella Scatola nera (Garzanti, 1996), usciti con prefazione di Raboni. Si sapeva, certo, che l’attività pubblicistica di Caproni era stata intensa e duratura, ma solo ora che la raccolta complessiva ha visto la luce, grazie alla costanza della curatrice e al coraggio dell’editore, è possibile capire la misura e la qualità di quell’impegno: più di cinquecento pezzi, comparsi su quotidiani e periodici (tra i quali «La Fiera letteraria», «Italia socialista», Il Lavoro nuovo, La Nazione) in un arco di tempo che va dal 1934 al 1989. Oltre agli scritti militanti, le Prose includono anche reportages e inchieste sociali (come quelle davvero notevoli sulle borgate romane, pubblicate sul «Politecnico» nel gennaio del ’46).
Non si tratta solo dell’opera di servizio di un «produttore di parole stampate» (così Montale, a proposito del ‘secondo mestiere’ di uno scrittore). È vero, Caproni aveva ben presente la fatica provocata dall’obbligo di una scrittura quasi quotidiana, che sottrae tempo all’invenzione e alle passioni, esponendo talvolta ai malumori del compromesso; e lo dichiara persino mentre scrive una recensione, facendo accostare il lettore al proprio scrittoio, mettendolo a contatto con l’aspetto materiale e psicologico del lavoro critico: «Si posano ogni giorno sul nostro tavolo – comincia così un pezzo del 1954 intitolato La mano nel sacco – nuovi libri di versi, e per ciascuno di essi è subito un rimpianto di più (per la probabile occasione perduta), che viene a sedimentare nel cuore. (…) Al povero recensore non resta allora, prima che il mucchio sparisca, che affidarsi al caso (o alla prima impressione, che è pressappoco la stessa cosa)».
Ma la buona scrittura funziona a volte come una partita doppia, in cui si calcola quello che viene lasciato in sacrificio alla pagina e quello che la pagina restituisce in termini d’idee, coscienza, verità. Ciò vale a maggior ragione per Caproni, che sentiva anche la poesia come lavoro: «Lavorare con semplicità, con dedizione totale, intorno alla costruzione di un imbuto, intorno alla costruzione di una poesia. Questo è più difficile, come tutte le cose spontanee, che lavorare con l’ambizione di toccare l’eterno per il secondo fine della gloria.» (Lavorare, lavorare, produrre, 1946). È in termini fabbrili che Caproni concepisce appunto la scrittura poetica: «i versi dei veri poeti (…) devono essere anche utensili per essere veramente utili»; devono cioè essere – prosegue Caproni, quasi anticipando la formula del coetaneo Sereni – «strumenti per sospirare, per esclamare la gioia, il dolore, l’amore ed altre infinite indefinibili cose o stati d’animo» (Versi come utensili, 1948).
Il nesso tra lavoro e poesia, tra utilità e creazione, spiega come la scrittura critica di Caproni, anche quando nasce per uno scopo pratico, tenda alla costruzione di una geografia letteraria, di un luogo agibile in cui lui e i poeti della sua generazione possano ritrovarsi seguendo coordinate comuni. Nei suoi pezzi, Caproni non parla quasi mai di sé; gli autocommenti sono tardivi, le dichiarazioni provocate da sollecitazioni esterne (come la risposta a un’inchiesta: Le contraddizioni della poesia, 1986). Ciononostante, nel panorama vastissimo di questi scritti (molto numerosi specialmente negli anni cinquanta), è possibile inquadrare un settore in cui Caproni stesso s’inscrive con più pertinenza: è la ‘tradizione del Novecento’, per riprendere il titolo della serie di saggi sulla letteratura contemporanea di Mengaldo, in cui Caproni ha un ruolo di primo piano. Quel paesaggio, che confina con il territorio della poesia ermetica (si veda soprattutto L’ermetismo e i più giovani, 1946), è abitato dai maestri indiscussi (Montale in primis, insieme a Ungaretti e Saba, questi ultimi più evocati che effettivamente attraversati), e dai compagni di strada come Luzi – oggetto di una tempestiva attenzione da parte del Caproni critico – Bertolucci, Sereni. Le parole di Poesie nate in guerra (1947), per esempio, spiegano il sentimento esistenziale del Diario d’Algeria quasi meglio di quanto non abbia fatto lo stesso Vittorio Sereni: «Io non sono mai stato in Algeria. La guerra per anni m’ha dissipato altrove – scrive Caproni – ma immagino cosa possa essere stato, laggiù, un campo per prigionieri di guerra. Immagino l’aridità tremenda (e dico aridità in ogni senso) assediante come un’atmosfera morta».
Dentro quel paesaggio letterario, dentro quella tradizione (o forse ai suoi confini) si sviluppa la cosiddetta «corrente ligustica», al centro di una serie di scritti pubblicati da Caproni nel 1956, in cui il poeta riconosceva un’affinità genealogica tra gli autori di area ligure del Novecento: Ceccardo, Mario Novaro, Boine, Sbarbaro e naturalmente Montale. Tratto comune ai ‘ligustici’ sarebbe quell’aderenza all’oggetto, alla materialità del dato naturale concreto, in cui lo stesso Caproni, «genovese di Livorno», poteva riconoscersi. Non così affine, ma per questo anche più amato, è invece il poeta cui Caproni concede forse la sua migliore amicizia critica, cioè Pasolini, del quale recensisce nel ’47 il libro dei Pianti, accolto con «commossa letizia» dopo la lettura delle Poesie a Casarsa.
Negli anni, l’esplorazione della poesia italiana contemporanea, che era stata acuta e capillare, si riduce d’intensità; in compenso, si allarga il raggio degli autori (anche stranieri) e dei generi presi in considerazione: è così che, soprattutto negli anni sessanta, Caproni può dar conto anche delle nuove uscite di narrativa: da Lo scialle andaluso di Elsa Morante al Giardino dei Finzi-Contini e Dietro la porta di Bassani, dai Tre racconti di Landolfi al Giornale di guerra e di prigionia di Gadda. Dagli anni settanta, le prose diventano molto più rare: è forse venuta meno la necessità, non però la coscienza dell’abnegazione richiesta dal lavoro critico. Ne è una testimonianza anche l’ultimo scritto qui raccolto, una lettera aperta a Beniamino Placido, pubblicata su La Repubblica il 9 novembre 1989. In un articolo della settimana prima, Placido aveva commentato lo scandaletto letterario del momento: la ‘scoperta’ che nel 1950 Montale si era fatto scrivere alcune recensioni da Henry Furst, un amico americano dal multiforme ingegno, per poi firmarle a proprio nome. In quel pezzo, Placido chiamava in causa anche Caproni, il quale in un intervento radiofonico aveva alluso alle recensioni compiacenti che gli era toccato scrivere nella sua carriera. Nella replica, il poeta rinnegò «la squallida immagine di un povero Caproncello facitore forzato di ‘recensioni di merda’», richiamando sì la «fatica», ma anche «quel senso di responsabilità» che deve avere «ogni onesto recensore».
Difficile immaginare un miglior sigillo per queste Prose critiche, vero monumento a quella fatica ma soprattutto a quella responsabilità.
Caproni, recensore onesto
Letteratura . Aragno ha raccolto in 4 volumi le prose critiche del poeta livornese
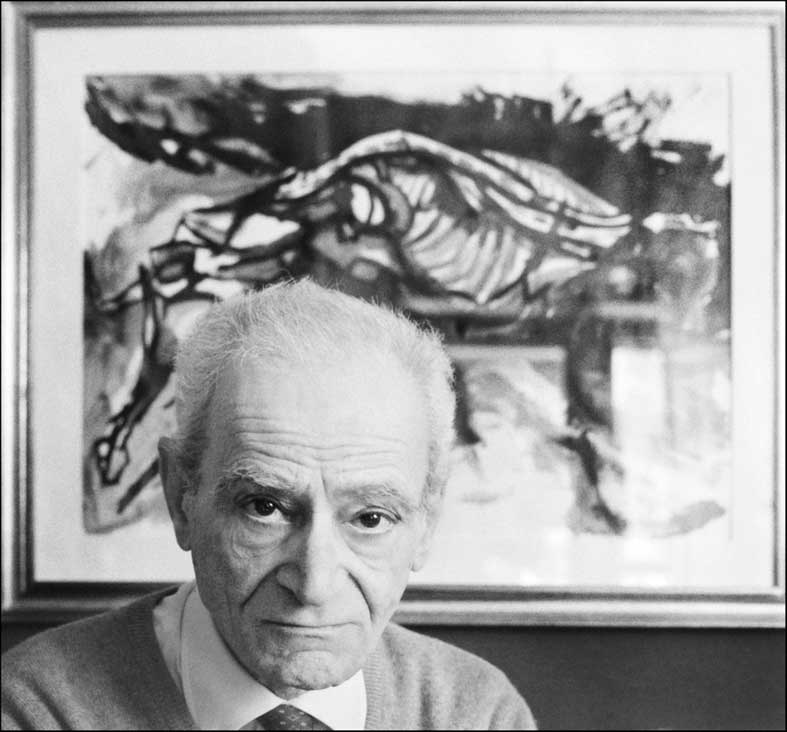
Letteratura . Aragno ha raccolto in 4 volumi le prose critiche del poeta livornese
Pubblicato 11 anni faEdizione del 7 aprile 2013
Pubblicato 11 anni faEdizione del 7 aprile 2013
