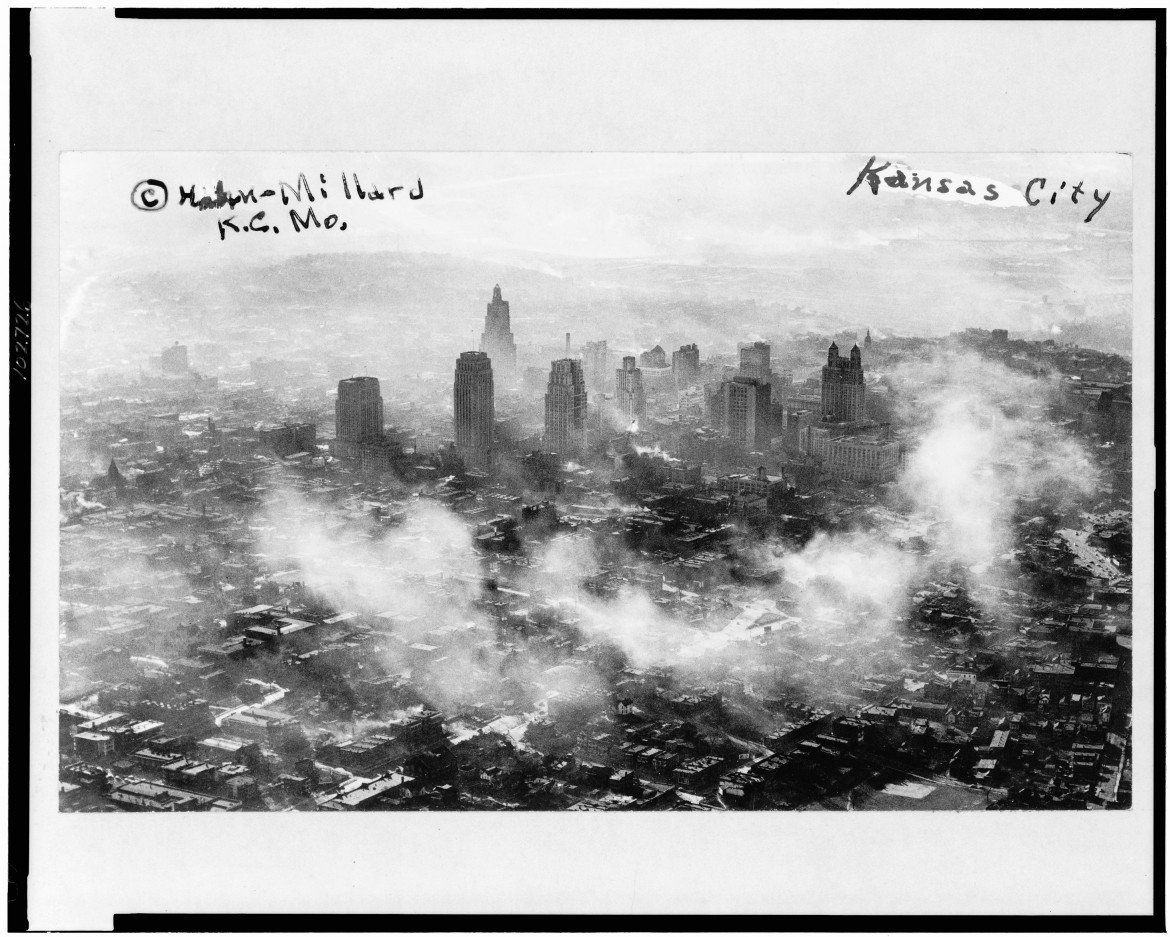«Broke House», il linguaggio della scena nel tempo presente
Big Art Group nasce nel 1999 da un incontro, quello tra Caden Manson e Jemma Nelson a New York dove erano approdati dal Texas – Caden – e dalla California – Jemma – seguendo itinerari diversi – Manson a diciotto anni aveva lasciato Robstown per studiare all’università di Austin, la capitale della scena più indipendente degli anni Novanta-Duemila, pensiamo al cinema di Richard Linklater, che oggi ci dice è divenuta molto più convenzionale.
In comune hanno il desiderio di una ricerca, di un pensiero, di linguaggi capaci di entrare nel proprio tempo, di narrarne i conflitti, il movimento, il respiro attraverso una invenzione formale con cui interrogare lo spettatore, il proprio gesto artistico, la sua materia. «Quando andavo a teatro avevo l’impressione di ascoltare una lingua straniera che non rispecchiava in nulla la mia visione del mondo. Big Art Group cercava di rispondere al bisogno di un linguaggio scenico contemporaneo». Una scommessa, e una necessità che continuano a attraversare il lavoro del gruppo allenando a ogni passaggio sensibilità e forme nel corpo al corpo con la realtà – o l’irrealtà – del proprio tempo.

Cosa ci racconta dunque il Big Art Group ? L’America soprattutto e il nostro mondo da The Balladeer (2000), riflessione sul massacro di Columbine – scenario che peraltro si ripete all’infinito basta pensare all’ultima sparatoria nella scuola di Uvalda – a Flicker (2002-2005) in cui con la tecnica del Real Time Film, il montaggio video in scena, e ricontestualizzando horror e b-movie esplorano l’immagine della violenza sullo schermo. House of No More (2004-2006), che chiude la trilogia del Real Time Film (a cui appartiene anche Shelt Life), torna ancora alla violenza nell’isteria mediatica e repressiva dell’era di Bush.
Broke House che sarà presentato alla Biennale Teatro (il 26 e il 27 giugno) va in scena per la prima volta nel 2012 anche se questa versione rimanda più al loro primo spettacolo Clearcut, Catastrophe! (1999) di cui riprende i riferimenti, Tre Sorelle di Cechov e Grey Gardens, il film capolavoro dei fratelli Albert e David Maysles: la vita di Edith Ewing Bouvier Beale e Edith Bouvier Beale, madre e figlia e rispettivamente zia e cugina di Jacqueline Kennedy, cadute in miseria e recluse nella casa cadente di Grey Gardens.
Qui si aggiungono altre suggestioni cinematografiche come Un anno con tredici lune e Week End, in scena ci sono cinque telecamere che Manson «guida» in diretta, quel Real Time Film che ha lo stesso tempo del teatro, permettendo agli attori di «entrare» e «uscire» dall’architettura scenica, di moltiplicarsi, di essere corpi fluidi nelle immagini.
Ci incontriamo in una calda mattina romana alla Pelanda dove hanno provato, le risposte uniscono (e si completano con ) le parole di entrambi.
La vostra ricerca esprime una visione politica legata alla realtà dell’America. Quale è la vostra posizione di fronte a un Paese ora così diviso, dove prevalgono scelte conservatrici nonostante una presidenza democratica?
Quello che è accaduto negli anni di potere dell’ex-presidente (Trump) è che dalla società civile è stato rimosso il pudore: non c’è più vergogna a attaccare i diritti civili, la sanità, l’aborto, ogni tipo di insulto nel linguaggio è stato sdoganato. La destra cristiana non prova alcun imbarazzo a insultare chiunque esprime un pensiero diverso dal suo, e questo viene strumentalizzato dai repubblicani che non si preoccupano della politica ma cercano di usare la rabbia diffusa mentre di fatto l’ex presidente continua a convogliare soldi soltanto nelle sue tasche.
Il Paese è molto violento e arrabbiato, ci sono esempi di questo ogni giorno. È un processo che è iniziato da tempo ma i cristiani attivisti e i conservatori adesso si sono uniti per sfruttare questa condizione addossandone la responsabilità a precisi soggetti sociali in modo da spingere sempre più verso cambiamenti che vanno contro i diritti e contro i democratici .
Perché avete deciso di riprendere «Broke House»?
La prima piéce del 1999, Clearcut, Catastrophe! aveva come suggerisce il titolo una dimensione catastrofica. L’idea che univa Tre sorelle e Grey Gardens era la condizione di essere intrappolati nel tempo; lo sono i personaggi di Cechov, Irina nel futuro, Olga nel passato, Masha nella ricerca di un futuro che cade nel presente. E lo sono la madre e la figlia di Grey Gardens rinchiuse in quella casa, nelle loro vite di prima, in una relazione che le soffoca.
Rimanere bloccati nella trappola del tempo è uno stato d’animo che ci sembra universale. Nello spettacolo questo concetto rimanda anche alla storia di una certa America dove come accade alle due donne del film dei Maysles le case sono impossibili da mantenere, oppure crollano letteralmente o ancora si perdono.
Quando abbiamo fatto il primo spettacolo i Maysles e il loro film non erano molto conosciuti nel mainstream ma erano un riferimento per la cultura queer. Poi è arrivato il musical di Broadway (nel 2006, ndr) tanti anni dopo il nostro lavoro. Del film ci piaceva anche che parlasse di una grande famiglia come quella di Jacqueline Kennedy Onassis divenuta povera, ci sembrava un’immagine anche questa molto significativa per capire l’America in cui si mescolavano la memoria degli anni Settanta e l’abbandono messo in atto dalla società nei confronti dei suoi cittadini.
Rispetto al Broke House del 2012 questa versione è molto diversa a cominciare dalla relazione col tempo che è quello attuale e di questa America, e riguarda un’instabilità che è anche la nostra. Il punto è come vivere qui, come esserci e come occupare il presente con la politica. Volevamo anche tornare sulla crisi delle case, che è di nuovo molto forte: siamo in una bolla nella quale le abitazioni continuano a essere troppo care a causa del sistema che vi ruota intorno. Le persone molto spesso non riescono a affrontare le spese, perdono tutto e diventano homeless – un problema sempre più grande in America. Abbiamo così una politica e un’economia che distruggono la società.
C’è un altro aspetto che ci interessava riprendere, e che riguarda il rapporto tra il teatro e il cinema: in che modo stanno insieme, se sono felici, se possono incontrarsi. La ragione che ci porta a utilizzare i video e i film viene dalla ricerca di uno spazio queer della rappresentazione che non si trova sui media «ufficiali» o nella televisione .
È da qui che viene l’ideazione del Real Time Film?
Per noi come compagnia è un mezzo per reinterpretare in chiave queer il video e sovvertire i limiti di ogni inquadratura in modo da costruire una nuova rappresentazione e un nuovo corpo pubblico e privato. L’idea è un po’ quella di un «reenactement» nel quale grazie alle riprese in tempo reale i personaggi provano a re-immaginare se stessi, le storie, i codici di narrazione.
A proposito, c’è una grande discussione sul linguaggio, sulle sue declinazioni, sul suo genere, sull’uso della schwa.
Il linguaggio è già cambiato con la tecnologia, che ha mutato il nostro modo di comunicare. Ma il linguaggio deve essere vivente, per questo muta naturalmente e il gender è una parte della sua trasformazione. Il fatto che vi sia un’opposizione a questi processi è perché un linguaggio binario è espressione di un certo gruppo di individui, viene usato per garantire il controllo del patriarcato bianco che cerca così di proteggere i suoi privilegi attaccando chiunque lo contesta.
Mi viene da dire che accade lo stesso con le persone che definiscono il teatro in un solo modo – penso alle critiche sull’uso del video in scena, anche questo è un discorso di potere. Riguardo al gender uno schema simile, cioè binario non può funzionare, le categorie dell’identità rimandano infatti principalmente a un assetto economico: tutto ciò che resiste alla categorizzazione viene visto come una minaccia e invece è proprio questa a esserlo contro l’umano e come tale si deve rifiutare.