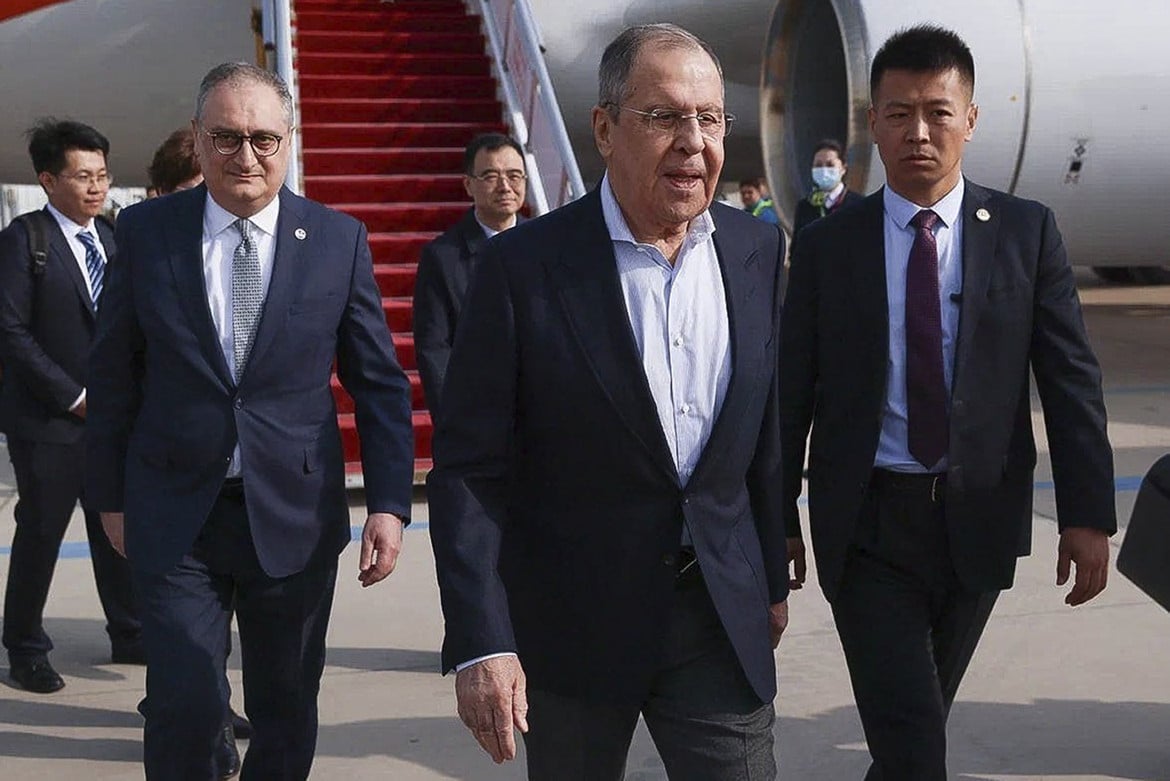Dopo aver trasformato molte sfere del quotidiano contemporaneo il complesso digitale industriale si appresta a «perturbare» – disrupt per usare uno dei termini che amano a Silicon Valley, ma come vezzeggiativo – il mondo alimentare. Gli ultimi mesi hanno visto in America una forte accelerazione nella convergenza di supermercati ed e-commerce, principalmente con una corsa dei giganti digitali all’aquisizione di grossi nomi della distribuzione alimentare. Il merger principale è stato quello di Whole Foods con Amazon.
L’ultima mossa del tuttivendolo di Seattle ha fatto molto parlare anche per il tipo di supermercato che ha acquisito.
Whole Foods, che vende cibo senza grassi idrogenati né coloranti, dolcificanti aromi o conservanti artificiali, è nata alla fine degli anni settanta dalla fusione di due alimentari naturali di Austin Texas e sotto la guida di John Mackey è cresciuta acquisendo negozi «bio» in diverse regioni fino a diventare marchio nazionale (e oltre: ci sono filiali anche in Canada ed Inghilterra) di alimentazione e «lifestyle», una sorta di modello Eataly (anche per l’ abbinamento ibrido vendita prodotti/punto ristoro), ma con la diffusione capillare di uno Starbucks.
Mentre ha contribuito ad espandere sensibilmente il mercato bio in America Whole Foods è stato criticato da fautori della sostenibilità come Michael Pollan per non promuovere col suo inventario mondiale le filiere locali. Mackey inoltre non fa segreto di vedute libertarian, ha dichiarato di non considerare un diritto l’accesso all’assicurazione medica degli impiegati e non ha mai permesso che la sua forza lavoro fosse sindacalizzata.
Soprattutto però la catena è derisa da chi fa notare i prezzi inflazionati (e le arie altrettanto maggiorate di chi vi fa la spesa). Whole Foods ha comunque aperto nuovi orizzonti sociali-alimentari per le emergenti classi millennial, radicandosi nei quartieri gentrificati delle principali città americane, particolarmente in prossimità di comunità affluenti di giovani professionisti e creativi. Nell’era dei top chef, della cucina-spettacolo e di una emergente cultura del cibo in America, Whole Foods è diventato brand culturale universalmente riconosciuto.
Una coniugazione di consumismo e costume che ha fatto degli stessi negozi marcatori di riqualifica urbana. L’apertura di un supermercato Whole Foods può di per sé mandare al rialzo il mercato immobiliare del quartiere circostante. Al suo carattere inevitabilmente elitario ed ai prezzi maggiorati ha però fatto seguito, dopo anni di espansione, un biliancio non del tutto roseo che ad agosto ha aperto la strada al takeover da parte di Amazon.
Per il gigante di Seattle si tratta di un altro trofeo di prestigio nella bachehca del colosso e-commerce, accanto a nomi come Washington Post e Amazon Studios, la divisione che produce film e programmi originali in streaming.
La prima decisione della nuova proprietà è stato l’abbassamento dei prezzi a livelli competitivi con quelli di supermercati «normali». Una prospettiva che ha fatto venire il sudore freddo ai concorrenti in un settore in cui gli utili dipendono da un margine tradizionalmente sottile. A preoccupare la mezza dozzina di altre catene nazionali sono le tasche smisurate di Amazon, un’ azienda nota per aver applicato la strategia della terra bruciata nell’assicurarsi il controllo del mercato , partendo da quello dei libri come testimonia la scia di piccole librerie mandate in bancarotta.
Per l’azienda costruita sulle spedizioni, Whole Foods rappresenta ora l’opportunità di ampliare il portafoglio immobiliare e di espandere le operazioni nella sfera fisica. Amazon aveva già lanciato il servizio Amazon Pantry con cui i clienti «prime» possono ordinare prodotti non deperibili recapitati in pacchi a domicilio. Di recente furgoni con l’insegna di Amazon Fresh hanno preso a circolare sulle strade di alcune città pilota del nuovo servizio a domicilio per cibo fresco. Adesso con oltre 400 filiali Whole Foods, Amazon dispone chiavi in mano di una rete di distribuzione capillare.
Ma probabilmente è solo l’inizio. Già nei primi mesi di quest’anno a Seattle l’azienda aveva aperto in via sperimentale alcuni negozi Amazon Go, minimarket in cui i clienti che hanno scaricato l’apposita app entrano, prelevano i prodotti desiderati ed escono senza passare dalla cassa (che non c’è). Il conto Amazon viene automaticamente addebitato dal telefono grazie a sensori di radiofrequenza (RFID) e i geolocalizzatori dei telefonini.
Da decenni la grande distribuzione mette a punto strategie meticolose per favorire i consumi e muovere la mercanzia, dal design delle esposizioni alla disposizione fisica dei prodotti e la frequenza del ristoccaggio.
Ora gli algoritmi e il data mining di cui dispone un gigante digitale come Amazon aprono la prospettiva di strategie estremamente più dettagliate. Le combinazioni di piattaforma digitale, telefonia mobile e database sono infinite, dalla spesa assistita alla selezione pilotata dei prodotti mediante gli inevitabili «consigli per gli acquisti», sviluppati però ora a misura di cliente in base ai dati in possesso dell’azienda.
Basta visualizzare le pubblicità che ci perseguitano per giorni a seguito di ogni minima ricerca effettuata su Amazon per cominciare a farsi un’ idea del probabile futuro degli scaffali dei supermercati in abbinamento eventuale con gli schermi dei telefoni e con indicatori elettronici dei prezzi.
Quest’ultima componente potrebbe rivelarsi fondamentale per implementare una politica «flessibile» dei prezzi in cui il costo dei prodotti possa fluttuare non solo con le stagioni ma con le ore del giorno, la temperatura ambientale o un’ infinità di altri parametri impostati dal commerciante. Se sembra un azzardo basta pensare a come ci si è abituati a comprare biglietti aerei, ad esempio, nell’era online ed alle drastiche fluttazioni di prezzo che queste possono subire quasi di ora in ora (o le tariffe maggiorate da Uber nell’ora di punta) secondo la dittatura di domanda e offerta e l’ortodossia iperilberista di Silicon Valley e della gig economy.
Un operatore come Amazon sarebbe in grado inoltre di calibrare fluttuazioni di prezzo anche in base ai profili dei singoli consumatori individuati in base alle migliaia di dati di cui le piattaforme dispongono su ognuno di noi (Facebook dispone di circa cento data point su ognuno dei suoi due miliardi di utenti, compreso reddito e valore della casa di proprietà). Gli algoritmi potrebbero dunque valutare a quale consumatore, o classe di consumatori, offrire eventuali sconti o offerte speciali, anche qui in «tempo reale». Non sorprende insomma che il rapporto «morboso» col consumatore abbia portato infine al cibo ed al supermercato, dove avviene la spesa quotidiana e più «intima», quella delle abitudini e dei bisogni primari.
Immediata è stata la contromossa di una altra azienda «tuttologica»: Google ha stretto un accordo di collaborazione col colosso WalMart, di certo con l’idea di implementare strategie simili a quelle del concorrente. L’idea è sempre quella di applicare alla spesa il modello «life bundle» sviluppato da prime: l’abbonamento, simile a quello dei bouquet delle TV premium, con cui il consumatore si affida al provider unico per ogni suo bisogno.
Per i cittadini consumatori che nel nome della convenienza hanno già delegato alle automazioni digitali i propri consumi di svago, cultura, servizi, informazioni, comunicazione, ricordi, si profila un altro mastodontico trasferimento di controllo agli oligopoli del silicone.