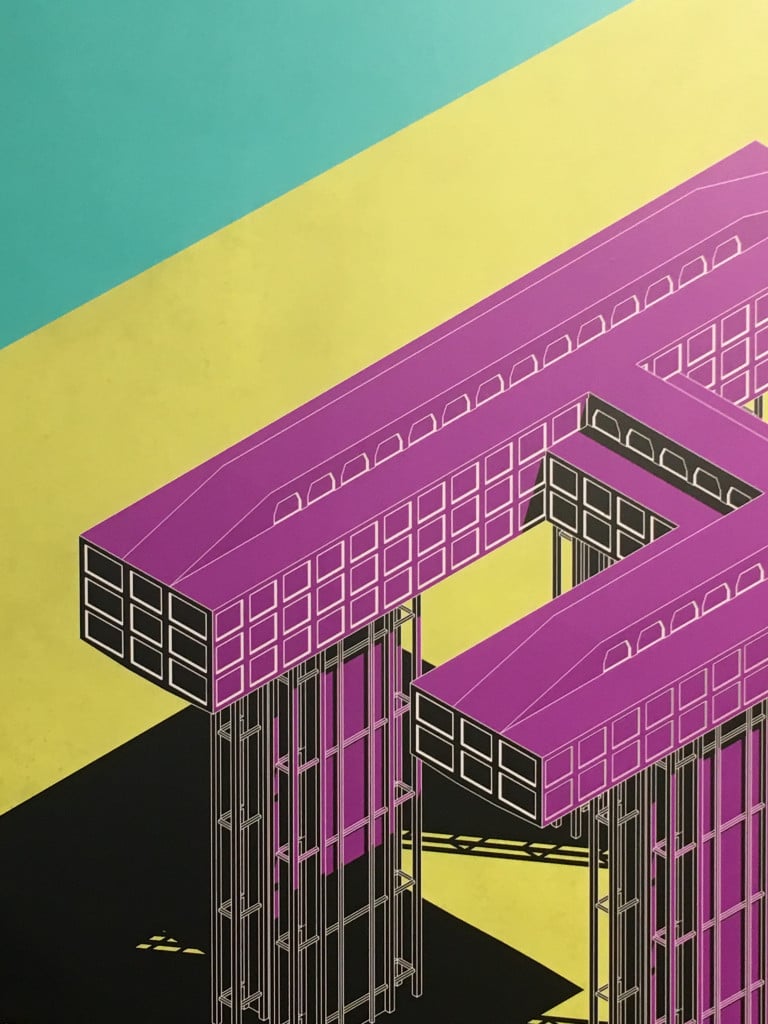«Avevo cinque anni quando L’incantatore fu scritto e la mia presenza era più che altro una fonte di disturbo nel nostro appartamento parigino e nelle pensioni della Costa Azzurra, e mio padre si ritirava nel bagno del nostro modesto appartamento per lavorare in pace, dopo avere generosamente dedicato del tempo a giocare con me». Così il figlio Dmitri rievoca – in calce alla novella da lui tradotta in inglese e date alle stampe in America nel 1986 – la stesura di quello che, a detta di Vladimir Nabokov, può considerarsi «il primo, piccolo palpito di Lolita». In quello stesso testo, tra ricordi e altre considerazioni, Vladimir regola diversi conti, scagliandosi in particolare contro chi aveva creduto di scorgere la mano di Nabokov in un «mediocre libretto» intitolato Romanzo con cocaina (Gog edizioni, traduzione di Vittorio Bonino, postfazione di Ernesto Valerio pp. 221, € 16,00).
Il manoscritto era giunto nel 1934 via posta a Parigi nella redazione di una rivista di esuli russi, che lo ospitò, parzialmente e a puntate, sulle sue pagine con un nome di comodo, quello di un certo M. Ageev. Di lì a un paio di anni un altro editore russo, anch’egli stanziato nell’Île-de-France, diede corso alla pubblicazione integrale in volume.
L’eco di Nabokov
L’indifferenza che lo accolse ne ha fatto perdere le tracce per mezzo secolo, ovvero fino a quando non venne riesumato e tradotto in vari paesi; nell’84 ne era uscita una versione di Serena Vitale, nella Medusa Mondadori, da tempo introvabile. John Updike, lettore onnivoro e recensore frenetico, non si lasciò sfuggire quella inglese, e anche lui, cui sembrava un romanzo interessante, disse che gli richiamava alla mente «l’eccentrica precisione di Nabokov». Si accodava così a quei russisti che si erano spinti ben oltre la semplice reminiscenza, mentre proprio la povertà dello stile di Ageev e l’abbondanza di locuzioni volgari e scorrette rendevano inconcepibile, per il figlio Dmitri, una simile attribuzione.
Almeno su un punto, però, Updike aveva ragione: l’opera è interessante. Comunque lo si voglia giudicare, lo stile è perfetto per il protagonista, un adolescente che parla di sé in prima persona con irriverenza brutale e sfrontata benché non priva di un suo romantico lirismo. In effetti, somiglia più alla voce del giovane Holden che non a quella assai più matura e manierata di un corruttore di ninfette. Entrambi sono tuttavia riferimenti impropri. Che Vladim Maslennikov, il protagonista, discenda in linea diretta da Dostoevskij è difatti annunciato in termini fin troppo scoperti nel sottotitolo, dove si specifica che stiamo per leggere le «memorie di un malato».
Curioso che, nella sue avvelenate confutazioni, Dmitri Nabokov sorvoli su un richiamo tanto evidente e preferisca concentrarsi sul fatto che il manoscritto venne spedito da Mark Levi, un ebreo russo «ossessionato dalle droghe» e morto a Istanbul nel 1936 «presumibilmente per le conseguenze dell’abuso di cocaina». Prova sì a spiegare certe somiglianze come goffi tentativi di imitare lo stile del padre, ma non accenna in alcun modo a Dostoevskij, che Nabokov giudicava a uno «sciatto commediante» molto apprezzato solo perché fuori dalla Russia lo si legge tradotto.
Ancora più strano è che nessuno abbia finora pensato di leggere questo libro proprio in termini di commedia, come un esperimento provocatorio in cui si mescola il diavolo con l’acqua santa: un romanzo dostoevskijano scritto alla Nabokov. Del resto, la stessa voce narrante di Lolita non è forse un uomo del sottosuolo, non parla forse da un abisso di abiezione, non rientra forse nel solco di una precisa tradizione letteraria anche se praticata con toni e intenti diversi, anzi dichiaratamente opposti?
In Romanzo con cocaina, accade qualcosa di simile. I punti di contatto apparirebbero più evidenti se solo definissimo questi parlatori del sottosuolo per ciò che in effetti sono: non voci, ma monologhi narranti.
Ratifica della dissoluzione
Delle quattro parti in cui è suddiviso l’eloquio di Vladim, le prime due si prendono lo spazio maggiore. Vi è esposta la fase in cui il giovinastro rivela la sua natura bieca e astiosa, umiliando la madre e strapazzando le ragazze che seduce malgrado sappia di essere affetto da una malattia venerea. Finirà per innamorarsi di una donna più adulta e già sposata di nome Sonya, non a caso come la prostituta dall’anima pura che in Delitto e castigo libera Raskol’nikov dal nichilismo innescando un processo di pentimento.
La redenzione che questa Sonja sembra favorire è però effimera. A Vladim preme soprattutto autoassolversi. In fin dei conti, non ha ucciso nessuno; non è che un miserevole edonista, crudele come spesso sanno esserlo i giovani. E la cocaina? Giunge molto avanti e occupa soltanto la terza parte del libro e, quasi fosse la ratifica di una dissoluzione morale già cronicizzata, ci svela quel che in effetti avevamo da tempo intuito: «Tutte le tue parole sono teatro, tutto è solo teatro: non sei caduto nell’abisso». Altrove, pressoché innominata nel romanzo, la rivoluzione russa faceva intanto il suo corso.