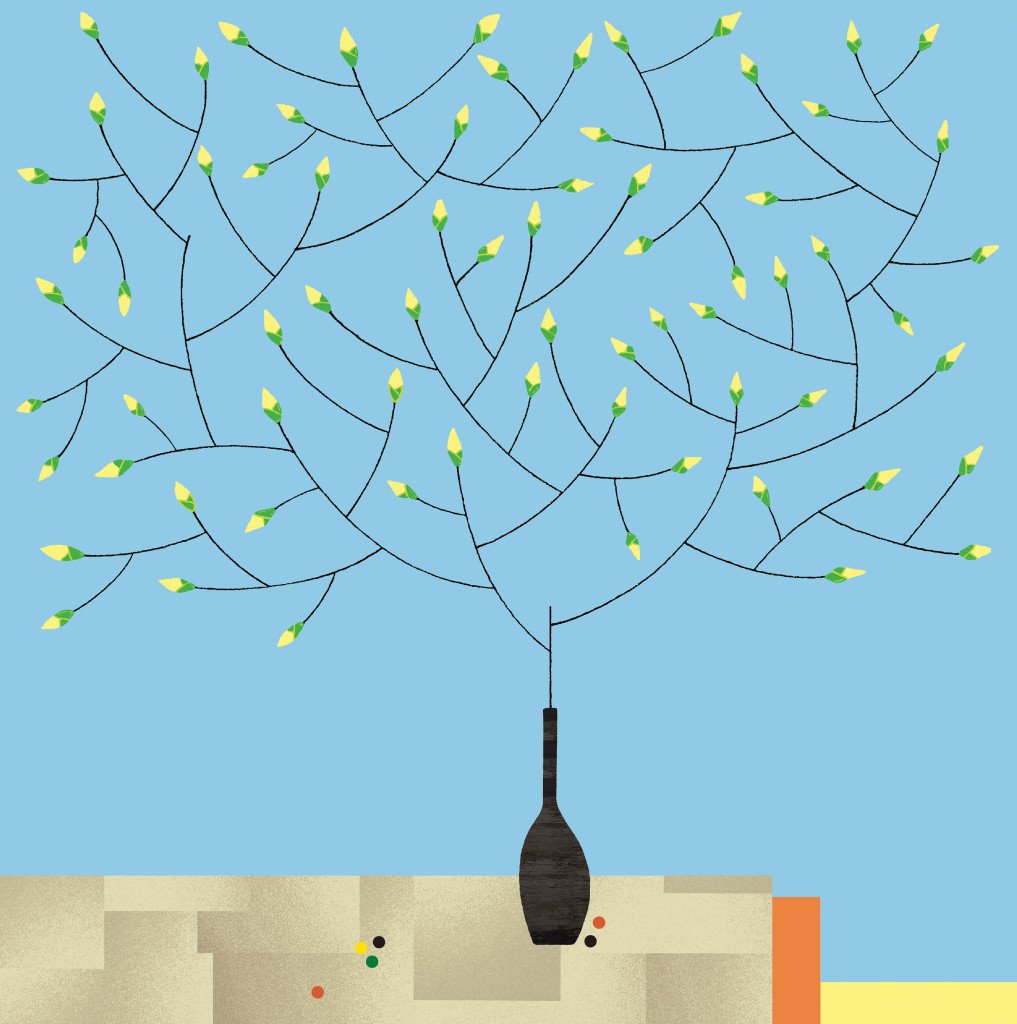Sono coppie che si ritrovano, amori che faticano a sbocciare, passioni che sorprendono chi ne è protagonista, figli che accompagnano i padri fino all’ultimo istante e padri che stupiscono i figli per la loro vitalità. E ancora, uomini che scoprono in sé doti genitoriali che non sapevano di possedere e donne che cercano di recuperare dopo decenni il rapporto con i figli che non hanno cresciuto. Decine di personaggi, giovani e vecchi, uomini e donne, talvolta poco più che adolescenti, in altre parole un piccolo mondo che non cessa di interrogarsi, molto spesso meravigliandosene, su ciò che prova per chi gli sta accanto, o vorrebbe gli stesse accanto.
Ancora una volta, nei venti racconti che compongono la raccolta dal titolo Legami (traduzione di Raffaella Scardi, pp. 318, euro 19), che nel nostro Paese inaugura il catalogo del nuovo marchio editoriale Gramma/ Feltrinelli, Eshkol Nevo dà prova della sua capacità di indagare non soltanto i sentimenti e l’animo umano, il desiderio come il senso della perdita, ma anche il modo in cui quello che sentiamo gli uni per gli altri è in grado di interrogarci e metterci in discussione ad ogni istante.
Storie scritte prima del terribile attacco di Hamas del 7 ottobre e della successiva tragica risposta israeliana a Gaza, nelle quali affiora tuttavia per intero la drammaticità e i nodi irrisolti della situazione mediorientale. Tra gli ospiti del Salone del libro di Torino – dove sarà sabato 11 maggio per due appuntamenti, alle 14.30 in Sala Azzurra e alle 17.30 al Bosco degli Scrittori – lo scrittore israeliano presenterà Legami lunedì 6 maggio alla Fondazione Feltrinelli di Milano in dialogo con Valeria Parrella (ore 18.30, viale Pasubio 5).
Partiamo dal titolo: che cosa tiene davvero insieme i racconti di questa raccolta, visto che i legami che indagano sono declinati in tutte le forme, verrebbe da dire dall’amore al suo contrario?
Posso rispondere in due modi. Quello più semplice è dire che il libro racconta le molte forme in cui siamo legati agli altri: genitori, figli, partner o amici. Se invece vogliamo scavare un po’ di più, credo si possa dire che a tenere insieme le storie sia l’elemento del tempo: vale a dire il modo in cui il passare del tempo, lo scorrere degli anni influisce anche su ciò che proviamo, su come guardiamo agli altri, sulle domande che ci poniamo e a cui rispondiamo in modo differente a venti, quaranta o sessant’anni. Non a caso, il libro avrebbe potuto intitolarsi anche «Questione di tempo», come una delle storie che contiene.
Malgrado le storie che racconta siano tra loro molto diverse, si ha la sensazione che da tutte emerga un sentimento di resilienza che conduce i protagonisti ad immaginare una possibilità di futuro anche nelle condizioni peggiori. Un atteggiamento che sembra connotare anche i personaggi delle sue opere precedenti…
A pensarci bene è probabile che sia così. Anche se non è una cosa che ho fatto in maniera deliberata, quanto piuttosto un esito del mio modo di guardare alla vita. I miei genitori sono entrambi psicologi, ma anche persone che si sono sempre date un gran da fare e che hanno sempre cercato di spronarmi a fare qualcosa per cambiare la situazione in cui mi potevo trovare. Diciamo che a casa mia era difficile potersi dire pigri o disperati al punto da perdere ogni speranza e rassegnarsi a non fare nulla. E questo credo di averlo in qualche modo messo in tutti i miei personaggi che magari non fanno le scelte giuste, o ne fanno di decisamente sbagliate: il punto è che anche un errore può essere all’origine di una storia che vale la pena raccontare.

In un racconto, Yonathan spiega a Dave che l’ospedale psichiatrico in cui è ricoverato sorge su quel che resta del villaggio di Deir Yassin, dove nel 1948 furono massacrati più di cento palestinesi, donne, vecchi e bambini. E come quei fantasmi continuino a bussare alle porte di chi vive lì. La storia ha per titolo «Ogni cosa è fragile» e sembra dirci che i legami di cui parla riguardano, soprattutto in modo doloroso, il rapporto tra i due popoli di quella terra…
La riflessione intorno alla fragilità può avere due significati. A livello psicologico: nel momento in cui capisci che la persona che ti sta di fronte è vulnerabile e fragile, allora, forse, puoi anche accettarla e perdonarla. Così, Shikma, la sorella di Yonathan, dice a Dave: «Per essere amico di mio fratello devi accettare il fatto che è fragile e non sarà sempre in grado di essere lì per te. Talvolta sparirà». E la psiche di Israele penso che abbia qualcosa di tragico: siamo addestrati a questa fragilità dell’esistenza. Esci al mattino e non sai se rientrerai la sera, hai una figlia che fa il militare, come è il mio caso ora, il che significa che devi mettere in conto che forse non tornerà più a casa. Gli israeliani sono molto bravi a improvvisare perché la vita in Israele è un’improvvisazione costante, perché la realtà ti può colpire in ogni momento. L’altra faccia della medaglia è che, proprio come accade a Yonathan, non tutti sono in grado di gestire tutti questi demoni che gli stanno attorno di continuo, non possono accettare di avere a che fare di continuo con questa storia sanguinosa e con la possibilità che succeda qualcosa di terribile. Per questo nella raccolta parlo a più riprese anche di israeliani che hanno scelto di non vivere più in Israele.
Dopo il 7 ottobre lei ha incontrato alcuni dei sopravvissuti all’attacco di Hamas e dei parenti degli ostaggi. Uno dei suoi interlocutori le ha chiesto: «Aiutaci a trovare una storia nuova. Quella che ci siamo raccontati sulla nostra vita sicura si è spezzata». Riesce ad immaginare come potrà essere questa «storia nuova» e quale il suo contributo come scrittore?
Le rispondo allo stesso modo in cui ho risposto quel giorno: non so quale potrà essere questa storia nuova, ma è importante pensarci. Personalmente, dopo il 7 ottobre, credo di essermi impegnato per diventare una sorta di scrittore-terapeuta, non qualcuno che arriva e fa un bel discorso, oppure scrive un articolo ad effetto, bensì essere il più vicino possibile a queste persone che sono ferite fisicamente o emotivamente. Perlopiù, negli ultimi sei mesi ho cercato di parlare con le persone, di scrivere per raccontare le loro storie. Il mio contributo come scrittore è stato questo: permettere loro di raccontarsi e di conoscere le storie di altri che prima del 7 ottobre non avevano mai incontrato. Stabilire un legame, per attraversare insieme questo dolore, per cercare di tornare, malgrado tutto a guardare al futuro con speranza.
Quanto è cambiata Israele dopo il 7 ottobre?
Credo che ci siano due aspetti determinanti. Il primo riguarda il fatto che quel giorno si è infranto quel senso di sicurezza in cui molti di noi si sentivano di vivere. Ora le persone non si sentono più sicure nemmeno nelle proprie case, ed è una sensazione che abbiamo bisogno di ritrovare. E poi c’è un’altra storia che in molti si raccontavano che è andata in frantumi: vale a dire che il conflitto con i palestinesi può non essere affrontato direttamente, tutto sommato si possono lasciare le cose così e basta. Ecco, la consapevolezza di tutto ciò implica una sorta di risveglio forzato: questo conflitto non bisogna solo «gestirlo», bisogna risolverlo.
All’indomani del 7 ottobre lei ha ammesso dolorosamente di fare fatica a provare empatia per la popolazione di Gaza, di non riuscire a separare quei civili dai terroristi di Hamas. Ora il suo sguardo è cambiato, come valuta quanto accade nella Striscia e la possibilità che si riapra una via per la convivenza o per l’ipotesi dei due Stati?
Credo che ora si riesca a fare qualcosa che sembrava, a me come a molti altri, impossibile nei giorni successivi al 7 ottobre. Fare una distinzione netta tra, da un lato, i cittadini di Gaza, le famiglie, le donne, i bambini e, dall’altro, Hamas che è un’organizzazione terroristica, è fondamentale per far prevalere l’empatia. Anzi, direi che ancora più dell’empatia, oggi sento, anche in questo caso come molti altri in Israele, tutta la gravità della tragedia cui sono esposte le persone che vivono a Gaza in questo momento. Affermarlo significa anche ribadire che non vogliamo essere in alcun modo come Hamas che questa distinzione non l’ha mai operata. Quanto alle possibilità per il futuro, l’empatia è il primo passo, se non verso la coesistenza, perlomeno nella direzione di una pace tra i due popoli: perché dobbiamo ricordarci sempre che «israeliani» e «palestinesi» non vuol dire una sigla o una determinata organizzazione o governo, ma due popoli fatti di persone, di esseri umani che prima di tutto devono imparare ad incontrarsi. O a ricominciare a farlo.