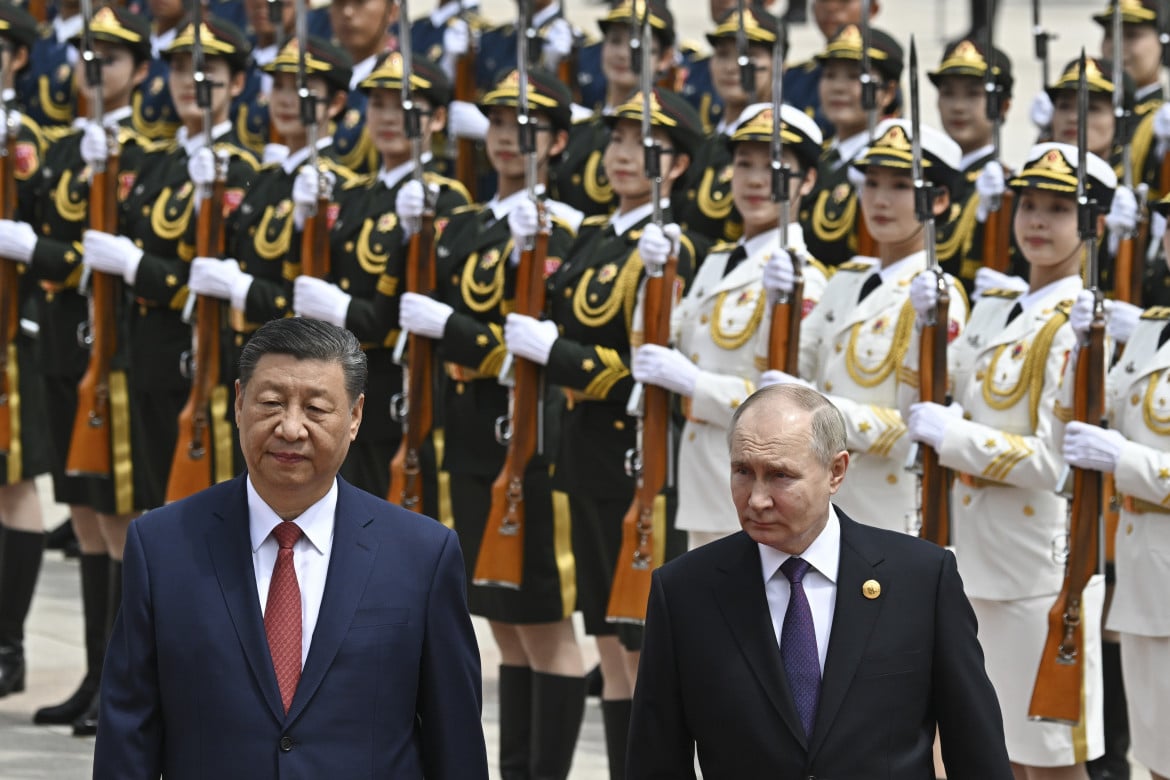Un uomo «quasi leggendariamente corpulento», «centodieci chili di bellezza maschile», come proclamava con modestia, uno «straordinario camminatore», «i piedi venosi nei sandali», «una testa di Zeus su spalle possenti e su ricci impenetrabili», una «stretta coroncina d’assenzio», «il suo bianco camicione di tela, del quale hanno discusso tanto a lungo e accalorandosi (in particolare le signore) se sotto avesse o no i pantaloni». Questa, in brevi tratti, l’immagine del poeta Maksimilian (Max) Vološin come ce la presenta Marina Cvetaeva nel suo saggio del 1932 composto in morte del poeta, dal titolo Vivo sul vivo (cura e traduzione di Annelise Alleva, con una sgargiante copertina elaborata da un’illustrazione di Leo Bakst, Passigli, pp. 141, € 16,50).
Letterato di orientamento simbolista, Vološin fu imitatore dei parnassiani prima, e poi «poeta teurgo», oltre che critico e pittore-paesaggista, un autore minore ma significativo del modernismo russo che dopo essersi formato e aver peregrinato tra Kiev, Feodosia, Mosca, Pietroburgo, e all’estero soprattutto a Parigi, ma anche in Italia e poi a Dornach, dove si fece seguace dell’antroposofia di Steiner, si stabilì con la madre, la tedesca Elena Ottobal’dovna Glaser, in Crimea, nella località di Koktebel’, che divenne ben presto il punto di ritrovo e rifugio per tanti poeti e scrittori dell’epoca d’argento e della nascente letteratura sovietica, da Andrej Belyj a Osip Mandel’štam, da Nikolaj Gumilëv a Michail Bulgakov, fino appunto a Marina Cvetaeva con il marito Sergej Efron. Vološin, convinto pacifista, visse lontano dagli echi della rivoluzione, ma non emigrò. Si chiuse in una sorta di silente esilio, vate e sacerdote di una poesia creatrice di miti e credenze. Solo al tempo del disgelo si poterono pubblicare suoi testi e la sua piena riscoperta arrivò negli anni del declino dell’URSS.
Il lungo saggio di Marina Cvetaeva non è semplicemente memorialistico: ha invece i toni e i tempi di una narrazione letteraria. Nel presentarci il personaggio, i suoi tratti psicologici e comportamentali, la sua maniera di esprimersi e mettersi in relazione con il mondo, Cvetaeva tende a costruire una vera e propria rappresentazione mitologica di Vološin, ora primo scopritore del di lei dono poetico con la recensione al suo primo libro di poesie, Album serale (1910), ora inventore di miti e mistificazioni poetiche: fra queste, la poetessa Cherubina de Gabriac (in realtà E. Dmitrieva) della quale Vološin montò la figura partecipando anche alla sua stravagante produzione in versi, e che finì per essere al centro di un duello tra lo stesso Vološin e Nikolaj Gumilëv (poi marito di Anna Achmatova) che si disputò nel luogo del fatale ferimento di Puškin e con pistole risalenti al suo tempo.
Per certi versi, le raffigurazioni delle poetesse che Vološin lanciò nell’agone poetico si presentano nel racconto di Cvetaeva come sue proiezioni, e infatti il saggio Vivo sul vivo costituisce in fin dei conti una sorta di ricostruzione autobiografica dell’ingresso di Marina nella letteratura, nel quale Max Vološin incarna la figura del maestro, strabordando dai dati propriamente fattuali verso una dimensione favolistica e atemporale. L’ambientazione è quella solare della Crimea e del Ponto Eusino, della nebulosa Cimmeria, del mondo antico e dei tenui colori dei paesaggi dipinti dal Vološin acquerellista.
La contrapposizione tra vita e letteratura, tra biografia e ars poetica, così propria di Marina Cvetaeva, è qui ampiamente confermata. In una lettera al redattore di «Sovremennye zapiski» (Annali contemporanei) Vadim Rudnev che aveva manifestato dubbi sulla veridicità del testo, Cvetaeva, fedele alla sua concessione della poesia, così rispose: «…dal poeta non si può aspettarci una ‘valutazione obiettiva’, per questo andate da qualcun altro, il poeta è un’eco rafforzata, un riflesso che abbellisce, l’oggetto più l’io, vale a dire più la passione», parole nelle quali traspare il tema centrale della celebre lirica di Puškin Eco.
La prosa di Cvetaeva è complessa, nervosa nello stile e nelle immagini, spesso orientata verso l’oralità, ora caratterizzata da un respiro propriamente epico e favolistico («Max era vero fumo, frutto, tizzone della terra. S’era spalancata la terra e aveva generato: quello, tutto pronto, enorme gnomo, folto gigante, un po’ toro, un po’ dio…»), ora da toni intimi e addirittura lirici, come testimonia anche la silloge di versi Ici-Haut posta in chiusa del testo e che Annelise Alleva ripropone in solidi versi italiani. Con laconica ruvidezza e inconfortabile nostalgia, i versi conclusivi mettono in risalto il senso tragico del distacco e dell’addio: «Max! Per me sarà — così morbido / Dormire sulla tua pietra».